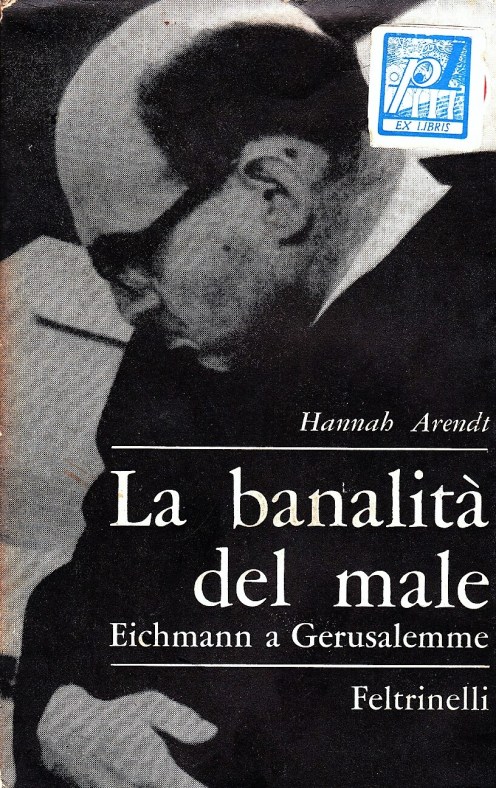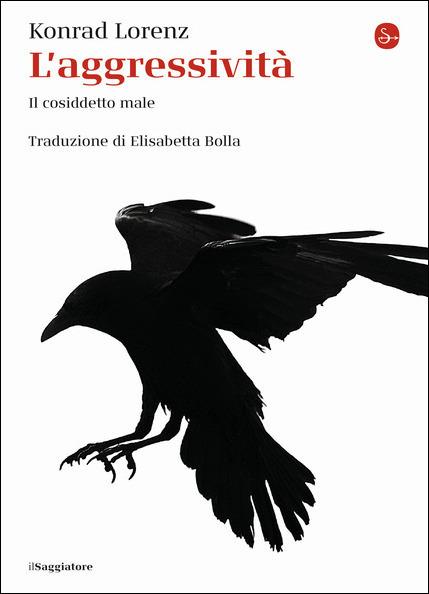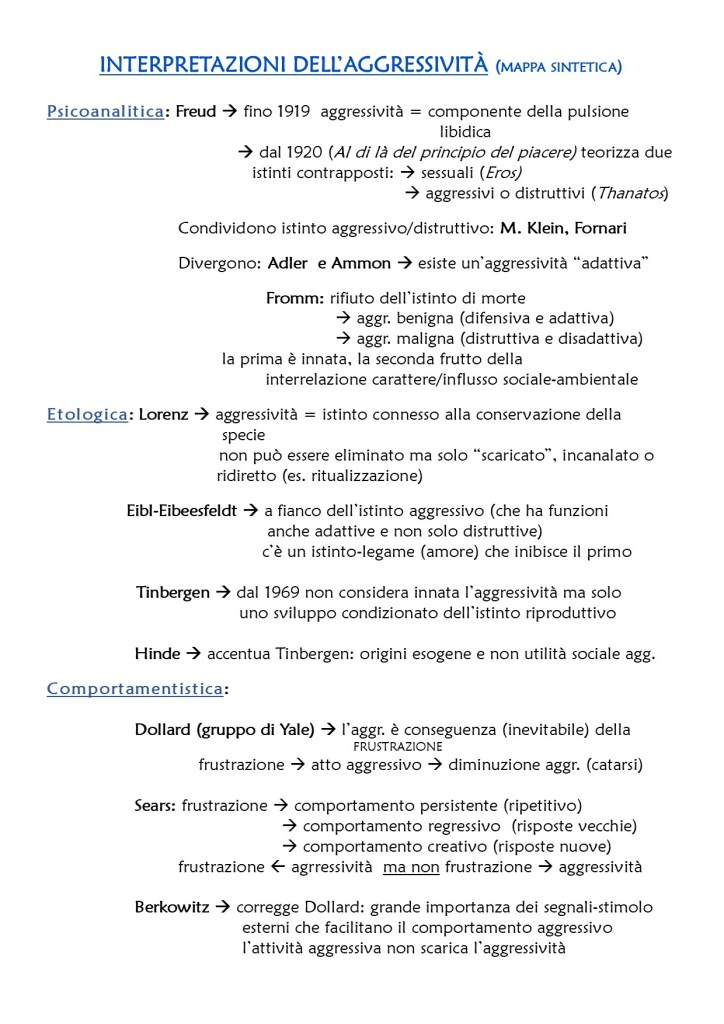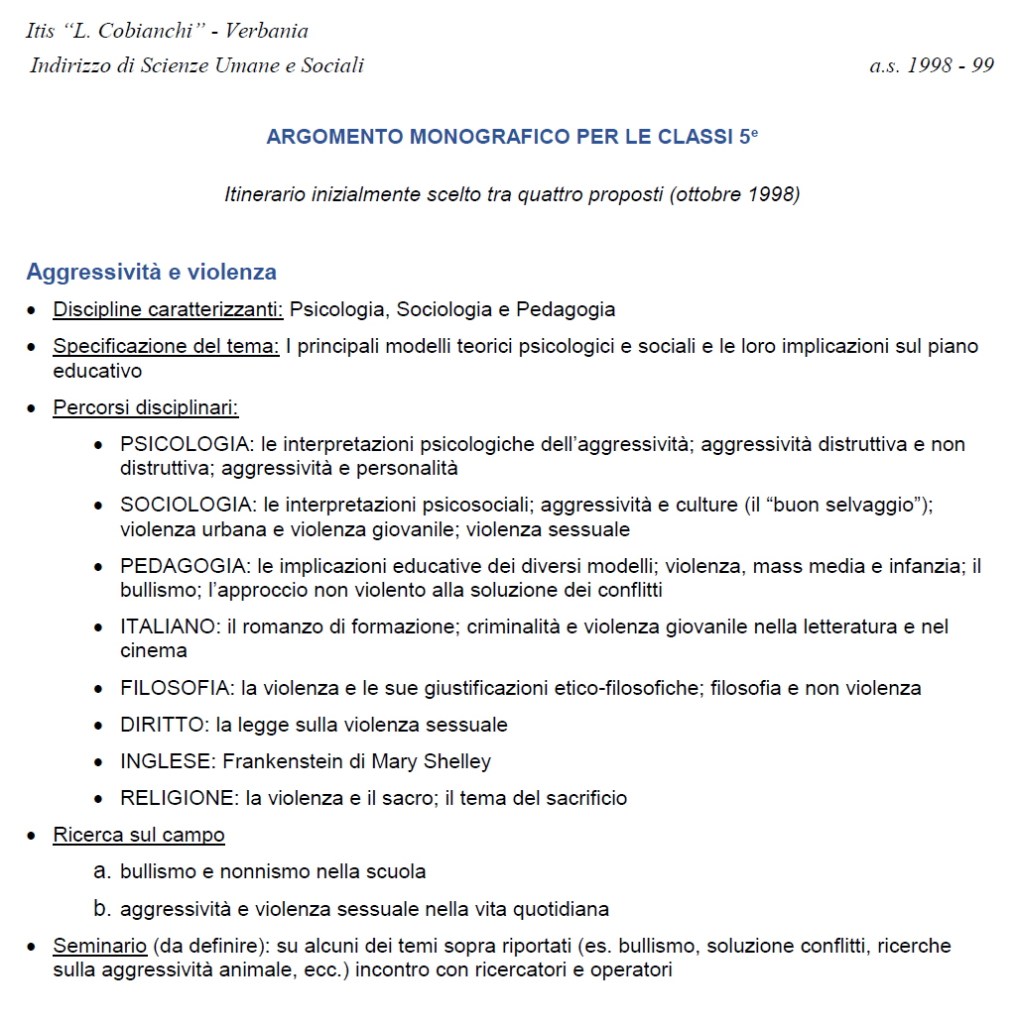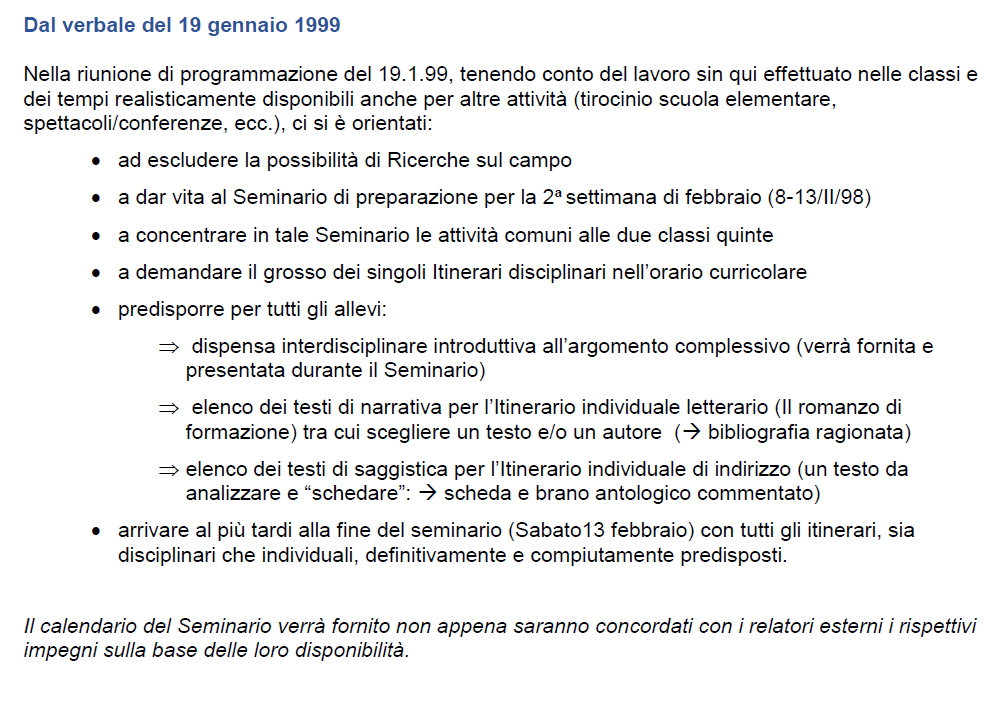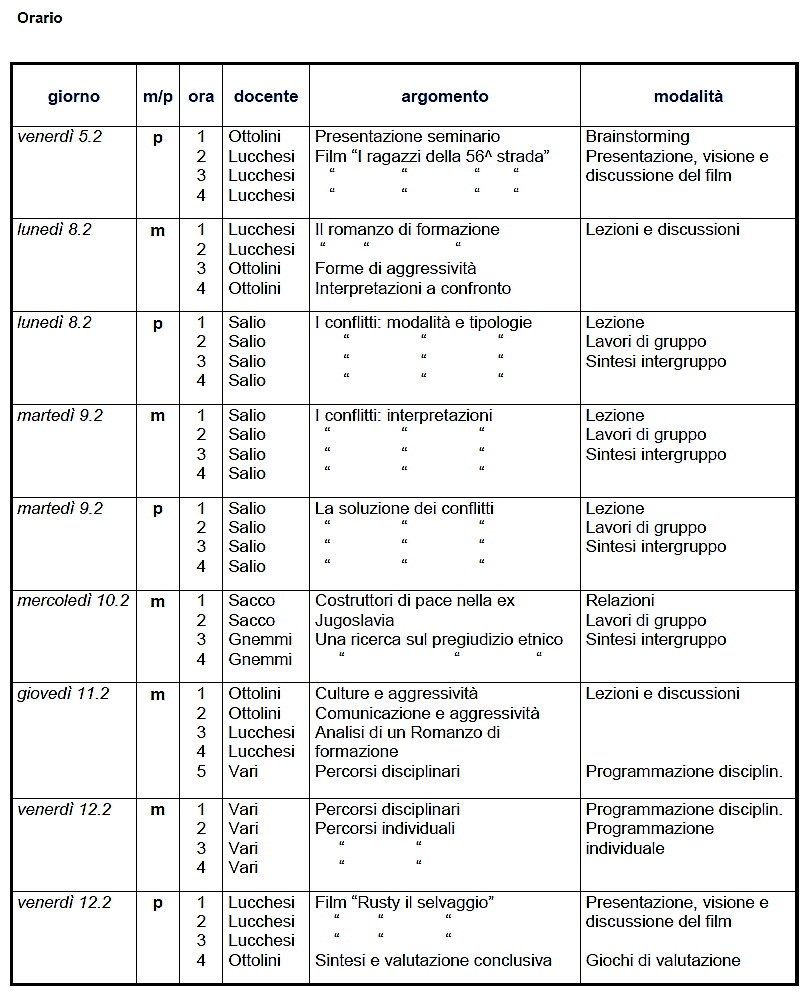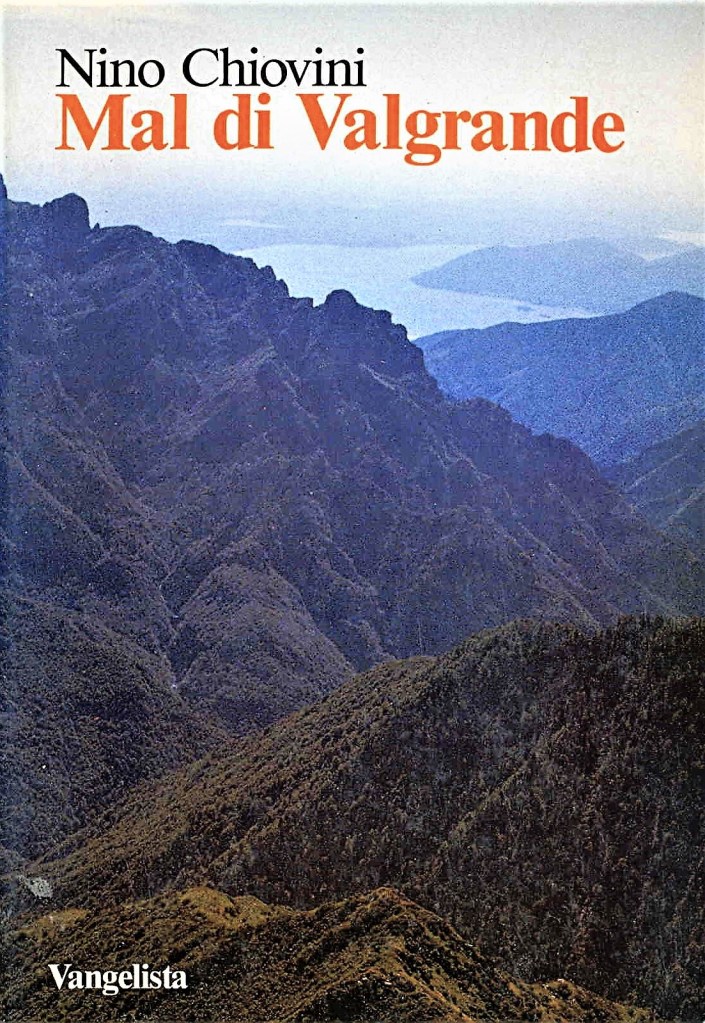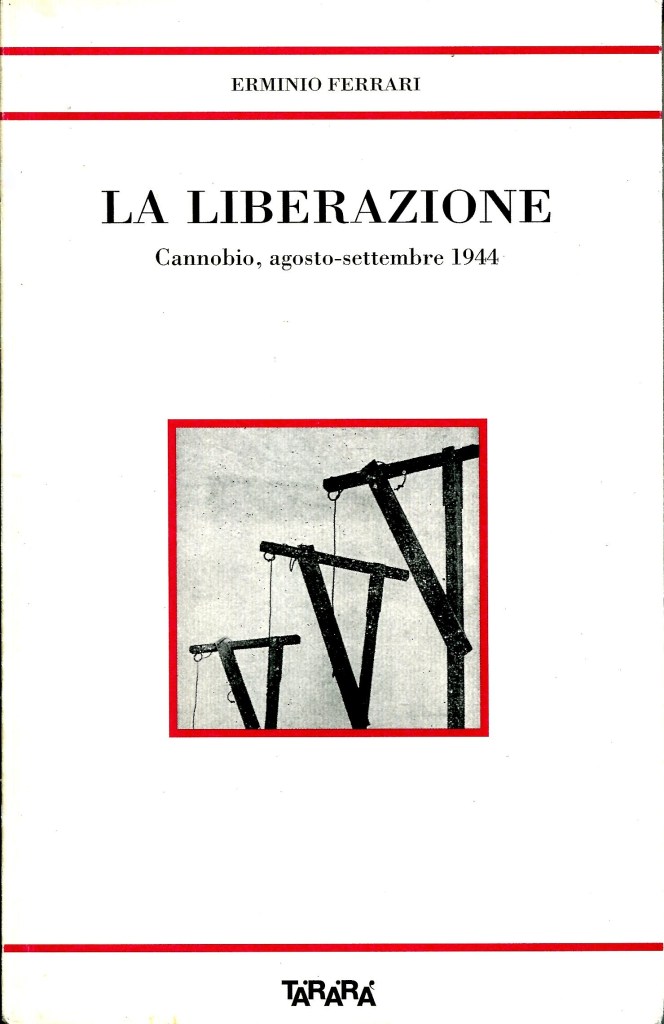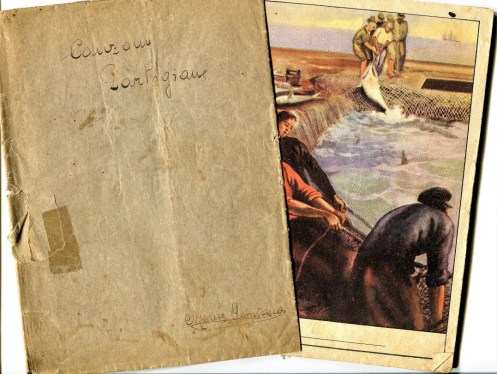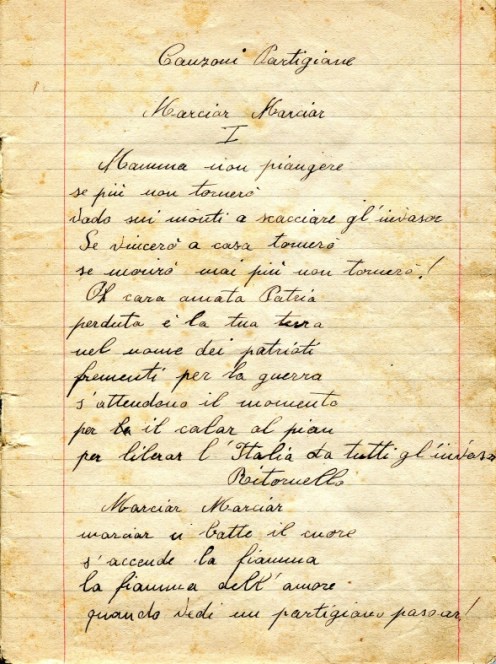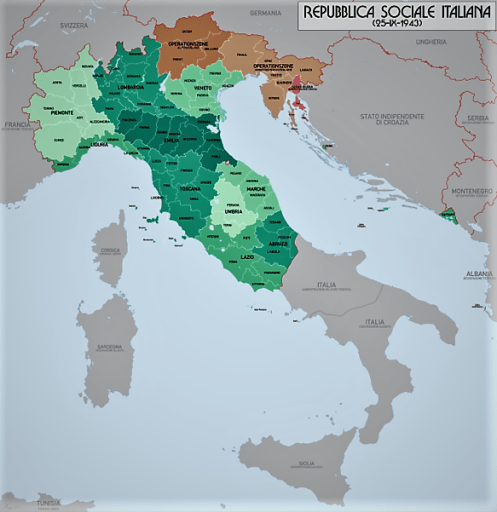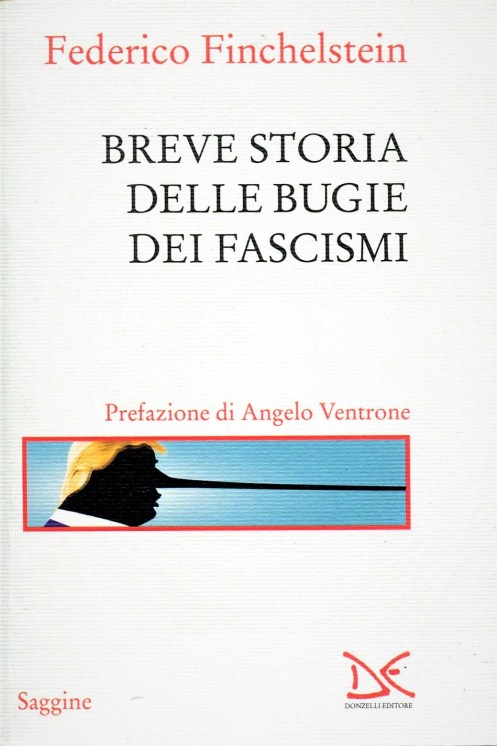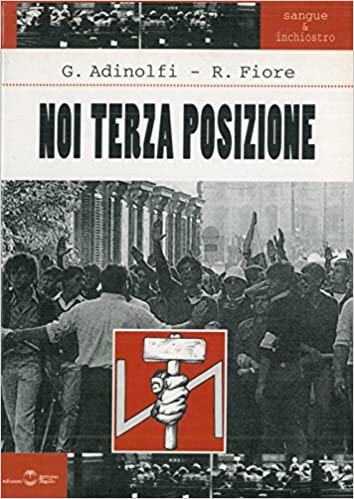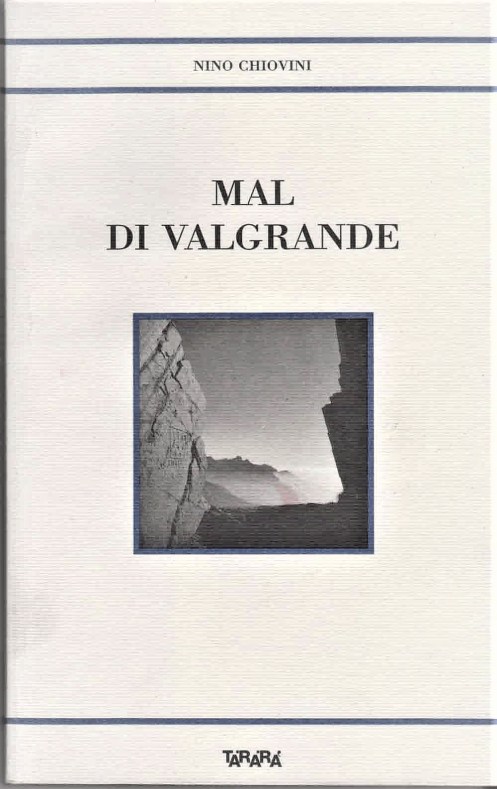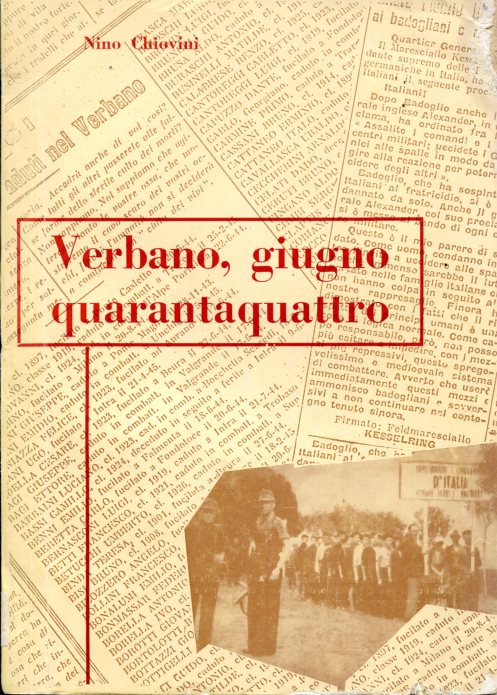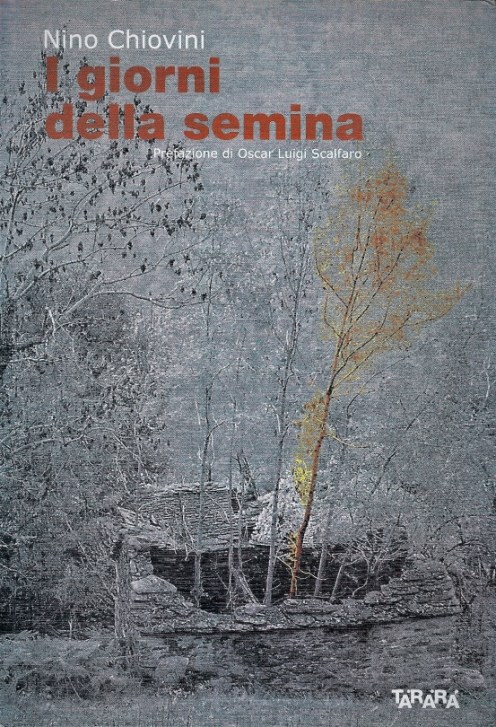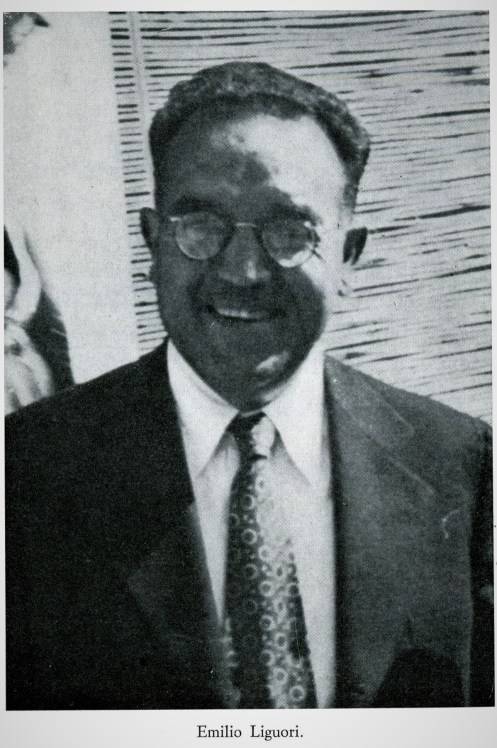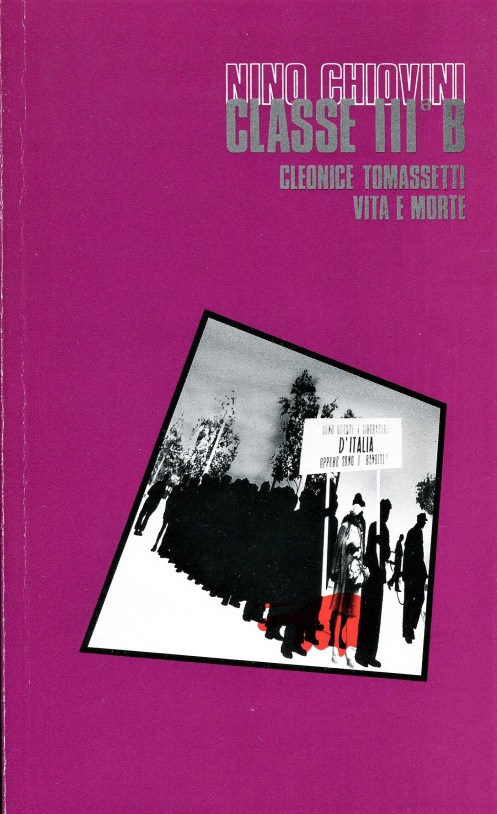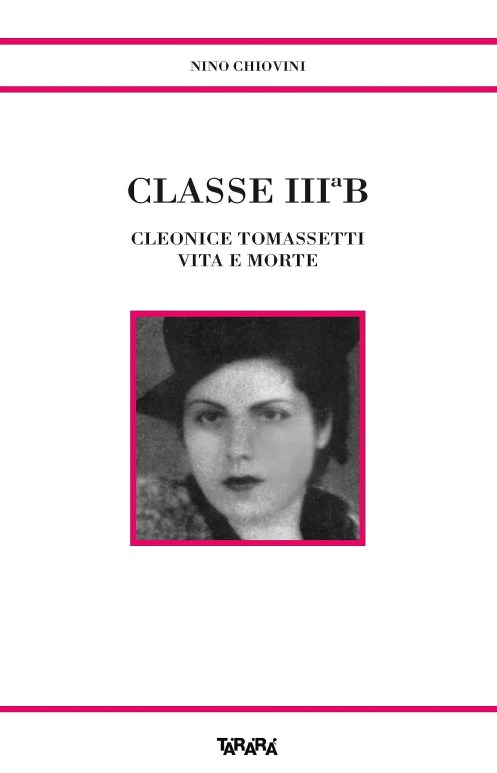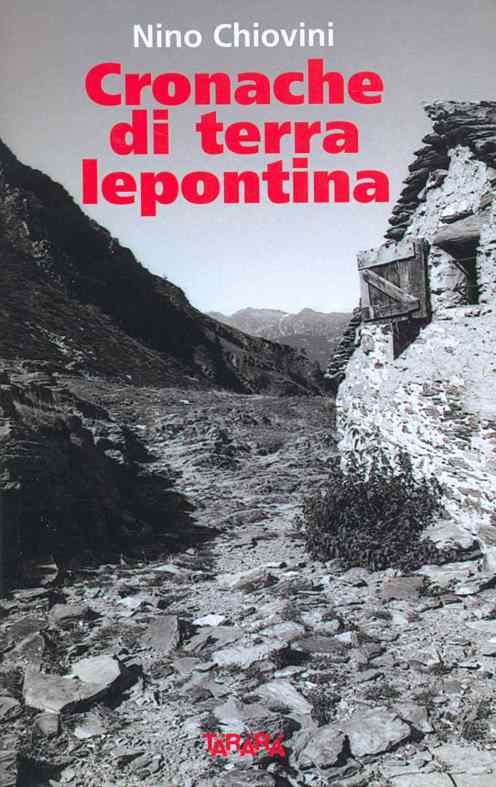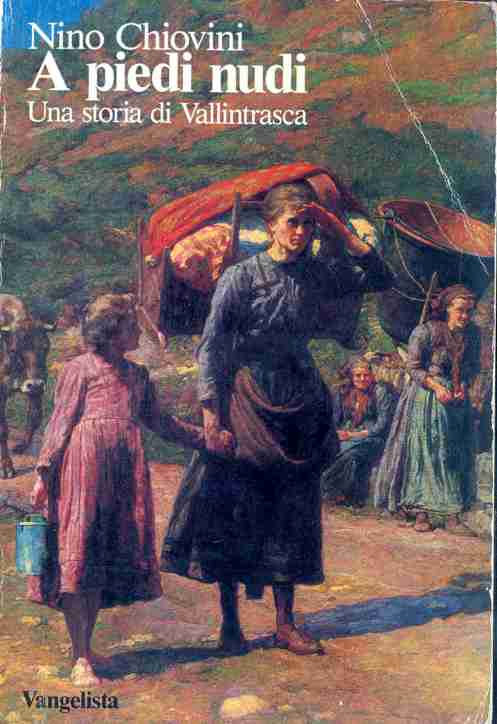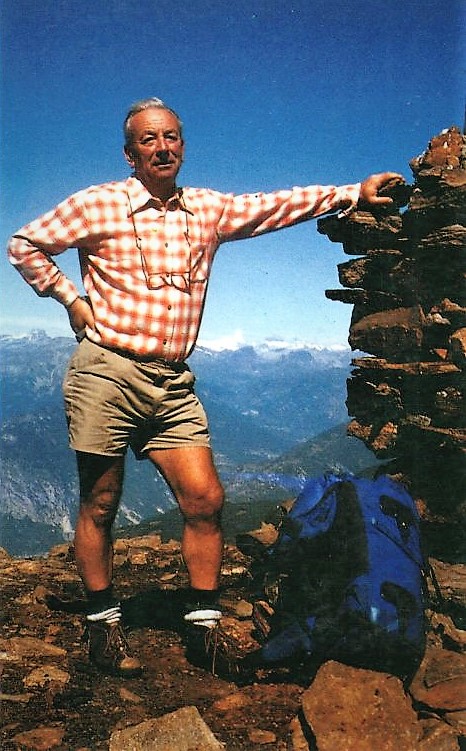In prossimità del Giorno della memoria ripropongo un post che anni fa avevo pubblicato su Facebook ripercorrendo il mio personale itinerario che mi ha portato in particolare ad approfondire gli eccidi compiuti nel 1943 a ridosso del Lago Maggiore. A maggior ragione osservando che viene malauguratamente ripresentato, proprio alla vigilia del 27 gennaio, un film che stravolse quella vicenda e il suo contesto storico e costituì offesa alla persona che di quella vicenda fu principale testimone.
Il mio rapporto con l’Olocausto *
Ho visitato i campi di Mauthausen, Gusen, Ebensee, Dachau all’inizio degli anni Ottanta. Erano le prime due visite organizzate dalla regione Piemonte nei lager, allora destinate solo agli insegnanti. Le conoscenze e la consapevolezza allora erano scarsissime, i tempi della Giornata della Memoria (istituita nel 2000 e celebrata per la prima volta nel 2001) erano lontani a venire.
Due aspetti in particolare mi avevano colpito; in primo luogo la standardizzazione industriale dell’olocausto, non solo la stessa organizzazione nei diversi campi, ma anche i più piccoli particolari, dai rituali che scandiscono la “vita” del deportato, alle forme delle baracche, allo sgabello per le punizioni … insomma una multinazionale del terrore volta a trarre il massimo profitto (che andava in buona parte alle SS) dallo schiavismo concentrazionario. Avevo tra l’altro letto che Himmler, diplomato in agraria, si era anche occupato di allevamento industriale di polli e vidi in questo una impressionante conferma di quello che si potrebbe chiamare “industrialismo concentrazionario”. In ogni campo era rigorosamente predisposta la durata media di vita del deportato: dai sei mesi di Mauthausen ai due mesi del duro lavoro sotterraneo di Gusen. Che venisse inoltre utilizzata anche l’informatica IBM per il computo preciso della merce umana in entrata e “in uscita” dai lager lo lessi solo molti anni dopo (IBM and the Holocaust).
L’altro aspetto che mi ha allora colpito è la circostanza che i luoghi scelti per i lager fossero spesso località “turistiche” (è il caso ad es. di Mauthausen e di Ebensee). Dalla lettura dei verbali di Mauthausen ho poi saputo che fra tutte le SS di quel campo una sola era stata al fronte: in sostanza il corpo delle SS del campo era costituito da “imboscati” piccolo borghesi che per amicizie e raccomandazioni familiari erano riusciti ad ottenere, in piena guerra, un “posto sicuro”, ben remunerato e remunerativo. Il lavoro sporco era assegnato alla struttura organizzativa in quanto tale e ai kapò.
Insomma un altro aspetto della banalità del male. In questo caso subordinato non tanto all’obbedienza ottusa analizzata dalla Arendt nel caso Eichmann (su aNobii una mia recensione: La banalità del male), ma al tornaconto personale. Certo l’ideologia razzista, la divisa dell’ordine superiore possono creare il contesto giustificativo, ma poi i moventi delle persone, in questo caso degli “aguzzini” sono assolutamente banali. Lontano mille miglia non solo come è ovvio dalla mitizzata “razza superiore” e dal superomismo, ma anche dalla immagine prevalente di nazismo e SS di tanta letteratura e di tanti film (non solo B-movie). Insomma, contrariamente a quello che molti pensano e alle prevalenti reazioni di fonte all’olocausto, la visita dei campi e le molteplici letture di quegli anni mi hanno confermato nella concezione (in qualche modo di origine socratica) del “male” non come principio attivo (ontologicamente e teologicamente come “entità”) ma come carenza, come assenza (carenza di consapevolezza, di immaginazione, di fantasia, di sensibilità, di intelligenza, di capacità di veder le cose da altri punti di vista). In sostanza carenza di senso etico visto che l’etica non è altro che l’assumere un punto di vista più universale. L’opposto di ogni concezione manichea. Il massimo male è il “niente”, il nulla. Certo, si potrebbe obiettare, ci sono (ci sono stati) i fanatici – non i “pazzi” – ma questi erano e sono una minoranza; quello che bisogna spiegare è come un intero esercito ed un intero popolo abbiano potuto dar vita e sostenere il regime dello sterminio.
Col passar del tempo dell’Olocausto me ne sono occupato sempre meno un po’ perché per le mie vicende didattiche non ho più potuto insegnar storia, ma soprattutto perché il leggere e vedere scene di violenza e di nullificazione dell’uomo in altri contesti (Cile, Sudafrica, Tibet ecc.) mi hanno reso sempre più insopportabile questa “banale” ripetitività. Una certa paura, non del tutto conscia, che la consapevolezza della banalità del male potesse per me diventare una banalizzazione, un mio assuefarmi, un banale appunto déjà vu.
Nel progetto di film sull’Olocausto sul Lago Maggiore (Even 1943) all’inizio sono stato “tirato dentro” un po’ a forza: da Camocardi, da Silvia Magistrini e soprattutto dalla giusta reazione di Becky Behar al brutto film di Lizzani. E allora, in modo condiviso, ci siamo detti con Lorenzo, Gemma e Claudia “non solo Meina, ma tutti gli episodi avvenuti in quell’autunno 1943; non solo le vittime ma anche i salvati; non solo i carnefici ma anche i ‘salvatori’, coloro che in modo semplice hanno aiutato, avvisato, nascosto o fatto fuggire chi era in pericolo di vita”. Questo aspetto per me è essenziale. Se c’è una banalità del male non credo sia corretto parlare di banalità del bene, ma piuttosto di “normalità del bene”. L’azione del “giusto”, la sua limpida normalità getta la giusta luce sulla “miserevolezza” degli eccidi. Sono convinto che non si possa oggi celebrare la Giornata della memoria se non ricordando oltre alle vittime anche l’azione dei “salvatori”.
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
* Pubblicato nel 2012 su Facebook

Domenica 5 settembre a Colle si è svolto il Convegno “Erminio Ferrari: narratore, giornalista, editore, traduttore. Un omaggio alla figura umana e professionale di un amico di LetterAltura e del territorio del Verbano-Cusio-Ossola.” Di seguito la ricostruzione, sulla base degli appunti preparati, del mio intervento, comprese alcune parti che avevo omesso per rispettare i tempi richiesti.
La liberazione[1] è il primo libro che ho letto di Erminio; ne ho una copia autografata dedicata a Madel, mia moglie, datata 28 aprile 2006: era appena uscito e lo aveva presentato alla Università della terza età. Le occasioni che ho avuto di conoscerlo personalmente, oltre a una intervista sul tema del contrabbando durante le riprese di Trarego memoria ritrovata[2], sono tutte relative a presentazioni editoriali e convegni.
Nel 2010 alla Fabbrica di Carta (Villadossola) la stessa sera si presentavano Classe III B[3] di Nino Chiovini – di cui avevo curato la riedizione – e il suo Mi ricordo la rossa[4]. Mi aveva colpito una certa ritrosia che interpretai come timidezza e solo col tempo vi riconobbi il tratto che accomuna molti grandi, consapevoli della umana transitorietà.
Nel 2011 il secondo Convegno dedicato a Chiovini (Leggere i fili del tempo) con un suo intervento sulla storia locale che, se non è pura erudizione, non è mai propriamente storia locale. E ancora nel 2012 a Cannobio con la presentazione di Fuorilegge???di Chiovini che permetteva di riflettere su un aspetto paradossalmente poco conosciuto: il Peppo partigiano.
Nel 2016 il convegno dedicato a Gino Vermicelli, con il suo intervento “Viva Babeuf! e la letteratura della resistenza” ove mise in luce la propria vasta competenza critico letteraria.
Ed infine nel febbraio del 2020 con il terzo convegno dedicato a Chiovini: nel suo intervento “I fogli della semina” Erminio ha sottolineato la letterarietà già presente nel Diario partigiano e ne I giorni della semina. Come nella edificazione di un muro a secco di una baita bisogna saper mettere la pietra giusta al posto giusto, così la costruzione scelta e successione delle parole richiede analoga precisione; è così che si fa letteratura, indipendentemente dal genere letterario. Parlava di Chiovini ma, inconsapevole, anche di sé.
Ferrari e la Resistenza: il tema e lo spirito della lotta partigiana ricorre in tutta la sua opera, dai saggi (Contrabbandieri), ai racconti (Porporì, Valzer per un amico) ai romanzi (Passavano di là). Mi soffermo sulle due opere al riguardo più significative: In Valgranda e La liberazione.
In Valgranda
Mauro Begozzi nel secondo Convegno Chiovini ha rovesciato l’immagine classica, col tempo diventata retorica, del “Monte Rosa sceso a Milano”: fu Milano, la pianura, i cittadini che salirono in montagna e si confrontarono e richiesero aiuto e collaborazione a chi la montagna viveva e praticava da generazioni. Rapporto complesso e non sempre facile che Nino Chiovini tematizza e problematizza nel saggio introduttivo a Val Grande partigiana e dintorni e che costituisce il tessuto che unisce i saggi di Mal di Valgrande[5].
In Valgranda. Memoria di una valle[6] di Erminio ne è la continuazione ideale, non solo implicita, ma più volte esplicitata sia con i continui richiami a Chiovini sia a ripetuti riferimenti a Mal di Valgrande.
Mi ha rimesso in strada il rumore di un elicottero. Era dell’elisoccorso. Andava a cercare qualcuno che in valle si era perso davvero. Una cosa difficile da capire: entrano in valle da soli, a gruppi, col bello e col brutto, qualcuno col machete, con le cartine stradali, con gli zaini enormi o con niente addosso, gasati, fanno foto, impauriti, italiani tedeschi francesi olandesi svizzeri inglesi, fanno le prove di sopravvivenza, si portano una bottiglia buona, raccolgono i rifiuti, superano i guadi, scivolano sullo strame bagnato, gettano le lattine e le buste di enervit, hanno uno spezzone di corda con sé, spiano i camosci, amano la natura, scrivono sul libro del rifugio dei loro amori lasciati a casa, o delle avventure sognate nella grande valle, dicono alla loro donna che la amano, vantano il tempo impiegato da qui a là.
Ogni tanto qualcuno cade e muore.
Al circolo, a Cicogna, quel pomeriggio se ne parlava. Ne parlavano quei tre o quattro a un tavolo, contandosela su con l’impegno che si mette quando bisogna stupire. La donna dietro al bancone, che li serviva, andava e veniva con il bottiglione e un tagliere di salame affettato. Le ho chiesto, indicando il Mal di Valgrande, esposto alle sue spalle, se ne aveva venduti, di quei libri. Altroché, ha risposto, altroché, come se fosse contenta di essere grata a chi lo aveva scritto. (p. 109)
“Il lavoro del Nino era stato questo: farsi una ragione attraverso le vite di quella gente” e, poco dopo, Erminio racconta il suo primo incontro, un 25 aprile ad Orasso, con Chiovini da cui ha tratto una “prima lezione” (prendere appunti per non lasciar andare quel il racconto nell’aria) ed una consapevolezza che diventerà programmatica: le diverse narrazioni di un evento non si contraddicono, ma si arricchiscono perché “senza le voci, una Storia muta non avrebbe niente da dire”.
Lo sfondo del nostro incontro è la piazzetta della chiesa di Orasso, Val Cannobina, per un 25 aprile. Io ero su a suonare Bella Ciao con la banda di Cannobio. Ho creduto di riconoscerlo e gli ho chiesto è lei l’autore delle Cronache? C’erano anche la Mari e il comandante Arca che raccontava.
La prima lezione il Nino me l’ha data lì. “Possibile che non hai niente per prendere appunti?”, mi ha chiesto, vedendo che lasciavo andare quel racconto a perdersi nell’aria. Allora ho cominciato a scrivere sul retro di una partitura che avevo per le mani.
Ed è stato grande: stavo scrivendo la seconda versione, in un paio di mesi, del rientro di Parri in Italia, attraverso le montagne della Cannobina. Quel mattino era Arca a raccontarla, col sorriso del capo che sa ringraziare col cuore. Giorni prima, invece, era stato un vecchio di Spoccia, ed era un’altra storia, ma sempre la stessa. Senza le voci, una Storia muta non avrebbe niente da dire. (p. 60)
In Valgranda è un libro di camminate e pensieri, di ricordi, di paesaggi ed emozioni perché “la geografia ha le sue emozioni”; ed è un libro di incontri: incontri casuali, spesso cercati, altre volte organizzati. Dentro questi ricordi e questi incontri si intersecano racconti che diventano storie. Storie che si elevano a Storia, della vita della valle e della Resistenza.
Nel cammino riemergono personaggi come quello straordinario di Maria Peron.
“Scendendo poi verso Pogallo, sul versante opposto al Corte dei galli, ho quasi imparato cosa è una laparatomia.” E di seguito rievoca come Maria in quel corte, in condizioni estreme, sul fieno di una baita, Maria abbia operato chirurgicamente con strumentazione improvvisata il partigiano Scampini gravemente ferito all’addome, lasciandolo poi alla cura di alpigiani. E così, lapidario, conclude:
“Benedetta Maria, Scampini la scampò”. (p. 19)
Ho riletto questa riga tre volte: una summa di umanità e stile dell’Erminio.
La figura ricorrente del comandante Superti o quella straordinaria di Gianni Cella, il partigiano sopravvissuto che “era mutilato di una gamba e sulla sola che aveva si è fatto la Valgrande coi nazisti alle calcagna”.
Il ricordo doloroso degli eccidi: quello del Casaröll rievocato dal Silverio Dinetti di Colloro, allora pastorello di 12 anni o quello del Fornà raccontato da “due donne che avevo intervistato a Falmenta, l’Angela Piazza e la Giovanna Grassi … a modo loro e intrecciando il ricordo dell’una e dell’altra”.
Incontri casuali o cercati e, soprattutto, quelli organizzati quale “mediatore” da Giuseppe Cavigioli che già aveva supportato Chiovini per le interviste riportate in Mal di Valgrande.
Ho conosciuto Cavigioli prima di sapere del suo ruolo di custode della memoria di Superti e del Valdossola, la sua formazione partigiana: faceva arrivare un trasporto di Chianti prodotto sulle colline tra Poggibonsi e San Gimignano; ogni anno faceva il giro dei suoi clienti e consegnava un foglietto che, in una bellissima calligrafia d’altri tempi, descriveva le caratteristiche enologiche di quell’annata. Di lui narra l’Erminio:
… sono passato da casa sua, affacciata, quasi, sul monumento ai quarantadue di Fondotoce. Ci conoscevamo più che altro per telefono: quando usciva un libro del Nino, lui mi chiedeva di segnalarlo sul mio giornale. Sapeva che non c’era bisogno di chiedermelo, ma almeno così ci sentivamo. …
Chiedimi quello che ti serve, se posso… Aveva fatto, in qualche modo, da agente letterario del Nino. Io ho scritto poco, quasi niente, non è il mio mestiere, mi ha spiegato, e la mia gioia è stata quella di far scrivere. (p. 25)

E così, grazie alla mediazione “del Peppino” intorno ad un tavolo, con la presenza del Pietro Spadacini, anche lui partigiano del Valdossola, viene raccolta e riportata per esteso la straordinaria testimonianza di Rinaldo Danini: è stato “uno dei primi a essere arrivato sulla riva del canale dove i quarantatré «erano sparsi a mucchietti. Era la sera del 20 giugno 1944.» Il Rinaldo ha iniziato così con ordine …”.
Al termine della narrazione di quel giorno del ’44, della scoperta del sopravvissuto, Carlo Suzzi, della condizione delle vittime e della loro successiva sepoltura, la moglie del Danini “ci ha servito il caffè e dei biscotti, che dopo un po’ di complimenti io e il Pietro Spadacini abbiamo cominciato a mangiare. Il Rinaldo che non si era più seduto, mi costringeva a inseguirlo col registratore”.
La testimonianza prosegue con il ricordo del 20 giugno dell’anno successivo, quando a liberazione avvenuta, è stata organizzata una grande manifestazione per commemorare i caduti di Fondotoce e, quella stessa sera, le casse delle vittime sono state riesumate per poter effettuare i riconoscimenti.
“La ventunesima cassa della fila superiore era quella della donna, la Cleonice. Lì vicino c’era una signora che diceva di essere venuta per stare vicino alla donna, alla Cleonice, che era partita per la montagna insieme a suo figlio. Ma per fortuna mio figlio è in Svizzera, diceva. “Lei ancora non lo sapeva, ma la cassa sotto quella della Cleonice era quella di suo figlio. Lo ha poi riconosciuto da un lembo di una camicia. E l’hanno dovuta accompagnare via.” (p. 57)[7]
Altra testimonianza raccolta con la mediazione del Peppino quella di Mario Morandi:
Il bello di questa storia è che ricomincia sempre. Non so se per difetto o virtù. E così succede di tutto, un giorno sei di qui, un altro di là. Il filo capita di perderlo senza accorgersene, e allo stesso modo lo si ritrova.
È il raccontare che fa queste cose. L’ascoltare – che è un lasciar raccontare – lo stesso. Un pomeriggio, era d’estate, io e il Peppino Cavigioli eravamo a casa del Mario Morandi, a Cambiasca. Lo avevo cercato perché sapevo che era lui il partigiano ferito al Casaröll e rotolato giù per il prato, di cui mi aveva raccontato il Silverio. È quel ’44 che non esce più dalla figura di questa valle.
Il Peppino aveva fissato l’appuntamento e il Mario Morandi ci aspettava. Ha subito cominciato a raccontare. (p. 111)
E così ascoltiamo “un’altra storia” (“ma sempre la stessa”): “con la Maria Peron per curare lo Scampini ferito, al Casal di gai” e di seguito la sua Valgrande con il ferimento del Pasta, la morte di Bruno Vigorelli, il Casaröll, il ritrovamento miracolosamente scampato di Gianni Cella, il partigiano con una gamba sola (“lo chiamavamo Gamba Una”, ha sorriso il Mario), l’uscita dalla valle, nascosto sopra Premosello. Per poi riattraversarla per arrivare ad Ungiasca.
E ancora le sue vicende avevano seguito la repubblica dell’Ossola, e la sua rotta, la fuga in Vallese, il rientro, la Valgrande rivisitata sulle tracce dei camosci e degli amici persi”. (p. 114)
E la storia ritorna con un altro incontro: quello a Miazzina con Attilio Tradigo e sua moglie Piera “che è una Primatesta di Premosello – perché anche lei ricordava qualcosa di quel giorno al Casaröll” (115).
Caricavano l’Alpe in Valgabbio e “c’erano i tedeschi in La Piana” che portavano via latte formaggio e qualche capra; quando tentano di prelevare anche le mucche decidono di lasciare la valle e dall’alto
alla Colmi abbiamo sentito tutti questi spari e abbiamo visto venire su il fumo dal Casaröll. (p. 138)
E dopo la Piera il racconto dell’Attilio cui “era toccata, in qualche maniera l’eredità di Superti, non certo come capo partigiano, ma come responsabile dell’attività dell’Ibai”, l’industria del legname con le sue teleferiche. E ascoltiamo il racconto straordinario di alcuni personaggi della valle: ul Pepp dul Lia che, il padre colpito da un malore, se lo ha caricato nel gerlo e da Riazzoli lo ha portato sino a Malesco; o il Pirùn Bionda che assieme al Gunda “hanno preso a contratto il trasporto” di una caldaia di più di un quintale da Piagger alla Colma. E quando il socio ha ceduto il Pirùn l’ha presa da solo sulla spalla sino alla Colma. E tutta la vicenda dl disboscamento sino al 1954 “quando è venuto il momento di smantellare la teleferica”.
Sono uscito a fatica anch’io da quella Valgrande, quella sera arrossata. Riaccompagnando a casa il Peppino (aveva preparato per me due bottiglie del suo chianti), vedevo quegli uomini e quel niente che ne è rimasto, fuori che il ricordo. Intanto gelava. (p. 144)
La liberazione
Se In Valgranda è un testo narrativo di memorie e percorsi che si interrompono, si riprendono e spesso si intersecano, La liberazione si struttura quale saggio che, capitolo dopo capitolo, ripercorre in successione quanto a Cannobio avvenne tra la fine di agosto e la prima decade del settembre 1944.
Il 25 aprile 1945, il Cesarino salì in cima al campanile e vi piantò il tricolore. Il campanile è così alto e mi chiedevo ogni volta come abbia fatto. Il perché, quello, credo di saperlo.
L’incipit nel primo capitolo parrebbe fuorviante perché non della liberazione del 1945 parla il libro, ma di quella effimera e più tragica degli “otto giorni di Cannobio”, presto rioccupata dai nazifascisti quando cadde lo zio, il giovane Erminio Ferrari di cui porta il nome e a cui il testo è implicitamente dedicato. Ma è sufficiente un ricordo liceale per capire che quell’incipit è un richiamo ad un analogo avvio: quella Libertà verghiana altrettanto breve ed effimera vissuta dal contado di Bronte.
Una ricostruzione rigorosa e allo stesso tempo corale perché anche qui “senza le voci, una Storia muta non avrebbe niente da dire”: testimonianze di familiari e altri cittadini di Cannobio, partigiani, autorità di entrambi i campi, oltre a documenti anche fascisti e tedeschi ed echi giornalistici oltre confine ecc. che Erminio ha raccolto e “montato” dove anche le voci e interpretazioni dissonanti ci danno un quadro vivo e realistico degli avvenimenti a partire da una sera di agosto.
La sera del 26 agosto 1944, a Cannobio, un drappello di partigiani si scontrò alle Quattro Strade con la ronda tedesca. Ne seguì una sparatoria, tre tedeschi morirono, un quarto rimase ferito; i partigiani si ritirarono con uno dei loro ferito a una gamba.
Il mattino successivo, il comando tedesco impose il coprifuoco e dispose un rastrellamento di tutti gli uomini abitanti nei dintorni delle Quattro Strade. A mezzogiorno, decine di adulti e bambini erano ammassati nella terrazza a lago dell’Albergo Cannobio, sede del comando tedesco. Poco distanti, sulla piazza, tre forche. Di quelle la foto c’è, e in un certo senso questa storia viene da lì. (p. 9)
Da questo più pertinente avvio, con la successiva testimonianza del partigiano ferito, Sergio Cantaluppi, si snoda la ricostruzione, di quello scontro e del rastrellamento successivo, nonché del “miracolo”[8] per cui “le forche non ebbero le loro vittime”, grazie alla intercessione del podestà, del commissario prefettizio di Cannero, del clero locale e dalla decisiva testimonianza, raccolta dal prevosto don Bellorini, del tedesco ferito per cui non di una imboscata si era trattato ma di un reciproco scontro a fuoco in cui la popolazione non c’entrava. Il comando tedesco allora “si limitò” a prelevare 50 ostaggi avviati sulla sponda lombarda, a Luino.
Nel frattempo le forze partigiane si assestano sempre più vicino a Cannobio il cui attacco, che suggellava operativamente l’unificazione nella Piave delle due formazioni Battisti e Perotti, è stato accelerato dagli avvenimenti intervenuti.
Il 2 settembre di prima mattina i partigiani entrano in Traffiume, aiutati dalla popolazione e “da qualche ragazzino reclutato come staffetta”. Alle 13, ora inconsueta, l’attacco: “il nemico, in continua allerta nottetempo e all’alba, fu colto in un momento di rilassata vigilanza, e non poté reagire altrimenti che asserragliandosi nei suoi accantonamenti”.
Il presidio tedesco di Cannobio, come subito dopo quello di confine di Piaggio Valmara, si arrende ottenendo il salvacondotto verso la Svizzera.
La scena, ha poi scritto Adriano Bianchi, era drammatica e insieme teatrale. “Un gruppo di uomini dignitosi e impauriti, i rappresentanti della più efficiente macchina da guerra mai vista sono portati via da un gruppo di ragazzini, che si sono gravati dei loro pesanti fucili”. …
Solo in vista della frontiera, i confinari tedeschi parvero sentirsi al sicuro. Ma non lo erano ancora. “Alla prima richiesta di farli entrare – continua Bianchi – per la novità, credo assoluta, di dover accogliere soldati dell’esercito tedesco consegnati da partigiani, gli elvetici rifiutano. Mentre al di là si svolgono febbrili consultazioni, dalla scorta qualcuno spara in aria, quasi a minacciare la fucilazione del prigionieri sul posto. Sapevo bene che il diritto d’asilo non poteva essere rifiutato, che gli svizzeri non l’avrebbero negato a chi si trovava in immediato pericolo di vita”. Infatti l’intera guarnigione tedesca di Cannobio fu accolta in Svizzera, lasciandosi andare “a scene fanciullesche di gioia. Uno fa il ballo dell’orso, tutti salutano: ciao! ciao! Auf Wiedersehen!” (55)[9]
Non analogo il comportamento della milizia fascista che alla richiesta di resa risponde facendo fuoco uccidendo il partigiano Bruno Panigada. Si dovranno arrendere il giorno successivo con la promessa che, se dal processo a cui erano destinati non fossero emersi crimini contro la popolazione, avrebbero avuta salva la vita.
I cannobiesi, che già il giorno prima avevano festeggiato (“non tutti” precisano più testimoni) imbandierando la città e suonando le campane, si precipitano ad insultare e in alcuni casi ad aggredire i militi condotti sotto scorta all’Albergo Cannobio dove avverrà il processo. Non altrettanto si erano comportati il giorno prima nei confronti dei tedeschi.
Il processo, pur rispettando le formalità, si svolge in tempi accelerati e, in un clima non certo favorevole agli imputati, si conclude con due condanne a morte, cinque ai lavori forzati e tre assoluzioni.
Il fatto increscioso, di cui Erminio sottolinea la gravità, è la successiva soppressione dei cinque condannati ai lavori forzati durante il loro trasferimento, soppressione giustificata da un poco credibile “tentativo di fuga”.
Chi decise e eseguì una sentenza mai pronunciata non fu mai rivelato. … Non vi furono inchieste né si presero provvedimenti – e cita Nino Chiovini che – con la sua lucida onestà di storico e di resistente ha scritto … «Gli avvenimenti dei giorni successivi concomiteranno a facilitare l’impunità e l’incognito dei responsabili, quelli che ordinarono o suggerirono o tollerarono, nonché degli esecutori, tutti individuabili nel settore meno controllato della Piave». (p. 64)
Mentre nella cittadina lacustre si avvia un il tentativo di un governo civile con un CLN locale, le forze partigiane, infoltite da nuove reclute, liberano l’intera Cannobina, Malesco e ridiscendono verso Domodossola che sta per esser liberata.
“Da trenta che eravamo, siamo diventati novecento” nel racconto enfatizzato di un partigiano.
Uno dei nuovi ‘ottocentosettanta’ era l’Ugo Ferrari, classe 1928. Sedici anni. E lo racconta ancora con un sorriso quasi imbarazzato. “La mattina della Liberazione sono sceso anch’io a Cannobio, all’Albergo Cannobio, per chiedere di essere arruolato nei partigiani. Mi sono trovato lì con l’Attilio Zanoni e tuo zio, l’Erminio.
L’Erminio l’hanno messo nel centralino; mentre io e l’Attilio siamo stati messi nella Polizia partigiana, pensa un po’, negli stessi locali della Pubblica sicurezza, sotto i portici in piazza”. …
“Mia suocera – ha ricordato mia madre – mi diceva che l’Erminio cercava di tranquillizzarla assicurandole che sarebbe rimasto giù al centralino in piazza, e che non lo avrebbero mandato sulle linee di combattimento”. (p. 71-72)
In Cannobio erano rimasti solo una trentina di partigiani, di cui molte nuove reclute, e nessuna arma pesante; il tenente Mosca (Michele Fiore) concorda con i tedeschi lo scambio di prigionieri con gli ostaggi cannobiesi tenuti a Luino.
E quando questi, in serata, arrivano a Cannobio, fu festa grande. Fu organizzato un ballo popolare e si andò avanti fino a notte. (p. 81)
Ma la festa durò poco. Alle sei di mattina del 9 settembre un traghetto che alzava bandiera bianca sorprese le ridotte sentinelle partigiane e i maimorti rioccuparono velocemente Cannobio. Tra i caduti partigiani l’Erminio: “Era di guardia al centralino in piazza, e non aveva neppure fatto in tempo a reagire”.
Il giorno dopo i partigiani entrano a Domodossola.
E mentre in Ossola si festeggia la discesa dei partigiani, Cannobio rioccupata, ha scritto Giorgio Bocca nell’appassionato Una Repubblica partigiana, restò “una spina piantata nel fianco dello schieramento partigiano”. (p. 97)
Se nelle prime cento pagine Erminio ricostruisce “a più voci” la storia (e le storie) di quei giorni, negli ultimi sette capitoli si interroga e riflette su quanto avvenuto:
Questa storia doveva finire il 9 settembre 1944. Ma più che finita, mi è rimasta sospesa una domanda: era stato necessario, giusto? (p. 103)
Non pochi sono gli interrogativi che rimandano a interrogativi più generali, storici, politici ed etici, sulla lotta di Liberazione. La liberazione di Cannobio era frutto di un progetto o più il frutto di una successione non sempre prevista di eventi? Ed è stata una liberazione opportuna? Sono state prese in considerazione le conseguenze che sarebbero ricadute sulla popolazione? E perché la cittadina è stata poi lasciata di fatto sguarnita? Quali i limiti da parte dei comandi partigiani, e in particolare quelli del comandante della Perotti, Pippo Frassati? Quanto ha pesato nelle loro scelte il ruolo dei servizi alleati che avevano prospettato l’intervento di una brigata internazionale a ridosso del confine svizzero (il cosiddetto progetto Alexander) e addirittura inviato in val Cannobina una troupe militare americana per riprendere scene di vita e di lotta partigiana? E quale fu il ruolo effettivo della popolazione? Se molti hanno festeggiato e non pochi aiutato, quale il peso degli informatori e delle spie fasciste nella rioccupazione?
Ed allora le domande locali diventano anche domande generali e le riflessioni di Erminio di incrociano, oltre a quelle di Chiovini, con quelle di Claudio Pavone sulla “guerra civile” e della Arendt sulla necessità in determinati momenti storici di mettere in gioco la propria vita:
“noi viventi dobbiamo imparare che non si può vivere in ginocchio, che non si diventa immortali se si corre dietro alla vita, e che, se non si vuole più morire per nulla, si muore nonostante non si sia fatto nulla.” (p. 140).
E soprattutto Todorov che narra e riflette “della coeva liberazione maquisard di Saint-Amand nella Francia occupata dai nazisti” seguita da una sanguinosa rioccupazione tedesca[10]. Di fronte a chi sceglie di aspettare l’intervento alleato “questi partigiani contribuiscono, con la loro azione, al formarsi dell’immagine che la collettività avrà di se stessa … essi agiscono dunque per il bene pubblico”. Ciò non toglie che vi sia un dilemma fra “l’etica della convinzione” (la scelta della resistenza attiva) e “l’etica della responsabilità” che mette nel conto anche le ricadute su altri delle proprie azioni. Così come, nel considerare la Resistenza nella sua globalità non bisogna prendere in considerazione solo la morale eroica del “del sacrificio” (quella dei ribelli) ma anche quella senza armi di chi si assume rischi calcolati per aiutare, proteggere, avvertire del pericolo, nascondere, non denunciare. Sono le “virtù quotidiane” basate sulla “fede nell’uomo” di cui le comunità abbisognano e che permisero ai ribelli in armi di resistere anche nei periodi più duri.
Un “passatore”
Questo denso richiamo a Todorov – autore che Erminio richiama anche in altre sue opere – mi ha colpito. Da un lato perché è un autore che considero fra i più interessanti che ha spaziato in molti campi (oltre alla storia, filosofia, letteratura, psicologia, semiologia e tanti altri) e che ci ha aiutato a capire la nostra epoca successiva al cosiddetto “secolo breve”. Personalmente mi è servito molto sia a scuola che in corsi di aggiornamento per le sue riflessioni etiche, per la lettura di momenti cruciali della storia (la “conquista”, l’illuminismo, i campi di sterminio, il nuovo disordine mondiale …), la letteratura fantastica, le dinamiche psicologiche interpretate in modo alternativo a quello freudiano (il sogno, i bisogni fondamentali dell’uomo…).
Nato in Bulgaria nel 1939, a ventiquattro anni ha lasciato il suo paese per la Francia assimilandone lingua e cultura. In una sua lunga intervista che ricapitola il suo ricco percorso intellettuale si autodefinisce un “passatore”: tra paesi e aree geopolitiche (Bulgaria – Francia), tra lingue e culture, fra ambiti disciplinari, “tra il quotidiano e il sublime”. “Dopo aver attraversato io stesso le frontiere, ho cercato di facilitarne il passaggio ad altri.” [11]
Ecco, questa predilezione di Erminio Ferrari per Todorov non penso sia casuale. L’immagine del passatore penso sia del tutto calzante anche per lui. Non solo per il quotidiano passaggio lavorativo della frontiera, per aver pubblicato sia in Italia che in Svizzera, ma anche per la capacità di passare e contagiare generi diversi: articolo giornalistico, saggio, racconto, romanzo, guida escursionistica …, cultura popolare e cultura alta, alpinismo, musica, storia e letteratura.
Non a caso, oltre a quello della resistenza, il tema del confine e del suo “passaggio”, dei passatori di merci e di uomini, è tema ricorrente in gran parte delle sue opere.
È che certi confini non si disputano, piuttosto si condividono, si confondono e si perdono di vista: in una selva di castagni uccisi e rinati da un male che ogni mezzo secolo li assale; o lungo il solco di una valle che alcune volte caccia acqua da far paura, altre è secca come certi cuori; o tracciato per pietraie ingrate, piccoli deserti lepontini; inteso da lingue che si sovrappongono, parole che figliano parole.
Qui capita spesso di avere un piede in Svizzera e uno in Italia, e un po’ ci si fa l’abitudine.[12]
Emblematica la figura di Meco, protagonista del romanzo Passavano di là[13], la cui solida moralità si fonda in modo omogeneo sul suo passato di partigiano e di sfrusìtt e che fatica a comprendere quella che invece indirizza il nipote e l’amico coetaneo, passatori odierni di uomini.
Bibliografia (provvisoria) degli scritti di Erminio Ferrari
Per aver pubblicato con piccoli editori sia in Italia che in Svizzera, la bibliografia cronologica che segue è sicuramente incompleta. A questo si aggiunge l’assurda situazione del Sistema Bibliotecario del VCO che non è associato al Servizio Bibliotecario Nazionale con il risultato che autori e testi locali sfuggono alle ricerche tramite l’OPAC SBN. Una situazione locale di confine che invece di fare da ponte è essa stessa confinata in un’enclave culturale.
Per gli articoli pubblicati sulla stampa ticinese si può far riferimento al seguente link (occorre login): https://www.pressreader.com/search?query=%22erminio%20ferrari%22
- Luoghi non tanto comuni. Cannobio, il suo lago, la sua valle, conLillo Alaimo e Daniele Grassi; pref. di Germano Zaccheo e Teresio Valsesia, con una poesia di Dante Strona, Press Grafica, Casale Corte Cerro 1985.
- Val Cannobina, Lago Maggiore. Con 27 itinerari escursionistici, con contributi di Mauro Branca … [et al.],Alberti, Intra 1988.
- “Francesco Biamonti. Un bilancio fra cielo e mare”, in Linea d’ombra, Milano settembre 1994.
- In Valgranda. Memoria di una valle, Tararà, Verbania 1996.
- Contrabbandieri. Uomini e bricolle tra Ossola, Ticino e Vallese,Tararà, ©1996, Verbania 1997 (Seconda ed. ampliata: 2000).
- Montagne di carta, La Regione Ticino, Bellinzona 1996.
- “Il passo sospeso del mondo” (su Francesco Biamonti) in laRegione, Bellinzona 27.02.1998.
- Porporì. Zatopek, la banda e altre storie, Tararà, Verbania 1999.
- Giuseppe Brenna, Cascine. Un omaggio ai signori delle montagne ticinesi e mesolcinesi, pref. di Erminio Ferrari, Salvioni, Bellinzona 1996 e 2000.
- Valgrande. Frontiera verde, con Angelo Cavalli, Tararà, Verbania 2001.
- “Val d’Ossola. Puniti dalla valanga”, in Rivista della montagna. Pubblicazione trimestrale del Centro documentazione alpina di Torino, A. 31, n. 2 (febbr. – mar. 2001), p. 66-71.
- “Rigoni Stern: una vita sull’altopiano”, testo e foto di Erminio Ferrari in Rivista della montagna. Pubblicazione trimestrale del Centro documentazione alpina di Torino, A. 31, n. 10 (dic. 2001) p. 88-93.
- Passavano di là, Casagrande, Bellinzona 2002.
- Arthur Cust, Ritorno in val Formazza, a cura di Erminio Ferrari, pref. di Roberto Mantovani, traduzioni e adattamento di Erminio Ferrari e Alice Margaroli, Tararà, Verbania 2004.
- Hubert Mingarelli, Luce rubata, traduzione di Erminio Ferrari, Casagrande, Bellinzona 2004.
- Fransè, Casagrande, Bellinzona 2005.
- La liberazione. Cannobio, agosto-settembre 1944, Tararà, Verbania 2006.
- Una valanga sulla Est. 1881, la “catastrofe Marinelli” al Monte Rosa, a cura di Ermino Ferrari e Alberto Paleari, Tararà, Verbania 2006.
- Riviera, Bellinzonese und Gambarogno. Tiefe Täler, ferne Gipfel, Marco Volken Bilder; Erminio Ferrari Texte; [Übers von Carlo Weder], Salvioni, Bellinzona 2006.
- Riviera, Bellinzonese e Gambarogno Valli profonde, vette remote, Marco Volken fotografie; Erminio Ferrari testi, Salvioni, Bellinzona 2006.
- “La discesa”, in Ticinosette, Bellinzona, 10.10.2008.
- “La parete”, in Ticinosette, Bellinzona, 5.12.2008.
- “Somalia, crisi umanitaria dimenticata dai media” [Registrazione sonora] conferenza, con Gabriella Simoni e Francesco Sinchic, Bellinzona 2008.
- Mi ricordo la rossa. Storie e luoghi dell’Alpe Devero, Tarara, Verbania 2009.
- “La legge padrona della vita e della morte”, laRegione, Bellinzona, 13.07.2011.
- Scomparso. Romanzo, Tararà, Verbania 2013.
- “Luigi Bonanate e Marco Revelli. L’eredità del Muro, la lunga vita del secolo breve”, Cahiers di scienze sociali, Fondazione Università popolare di Torino, n. 1 (2014) p. 62-67.
- “Storie di treni e di contrabbando” in Matteo Terzaghi e Matteo Campagnoli (a cura), Negli immediati dintorni. Guida letteraria tra Lombardia e Canton Ticino, di Anna Banfi [et al.], disegni di Giovanna Durì, Casagrande-Doppiozero, Bellinzona-Milano 2015, p. 57-61.
- Tracce bianche. Con le ciaspole e gli sci dal Lago Maggiore al Monte Rosa. 79 gite brevi,conAlberto Paleari, MonteRosa, Gignese (VB) 2013 (seconda ed. ampliata 2015).
- I 3900 delle Alpi, con Alberto Palearie Marco Volken, MonteRosa, Gignese (VB) 2016.
- Cielo di stelle. Robiei, 15 febbraio 1966, Casagrande, Bellinzona 2017.
- Elio Costa e Gabriele Scardellato, Lorenzo Grassi in ‘Merica. Un umile eroe falmentino in Canada; ed. italiana a cura di Erminio Ferrari; trad. di Alice Margaroli Dancy, Tararà, Verbania 2018.
- “Punta del Nuovo Weisstor”, in Ticino7, Bellinzona, 17.11.2018.
- “Il pizzo Boccareccio”, in Ticino7, Bellinzona, 8.02.2019.
- “Sull’Ofentalhorn. La cima che non ti aspetti”, in Ticino7, Bellinzona, 19.04.2019.
- “Per un pugno di Nickel”, in Ticino7, Bellinzona, 18.10.2019.
- Ossola quota 3000. Tutti i 75 tremila, con Alberto Paleari, Monte Rosa, Gignese 2019.
- “Pizzo Cornera. Toccare la cima, ma con molta attenzione”, in Ticino7, Bellinzona, 18.07.2020.
- Valzer per un amico. Racconti, Tararà, Verbania 2020.
- Un blues per Gilardi, racconto su laRegione, Bellinzona 2.10.2020.
Linkografia su Erminio Ferrari
Biografie e recensioni (cronologico)
- http://www.tarara.it/it_IT/home/autore(f7832947-7d64-4bea-8b5f-a57403c405ca) Biografia dell’editore
- http://www.edizionicasagrande.com/eco_dett.php?id=2022 Recensioni a Passavano di là
- http://www.milanonera.com/franse/ Recensione a Fransè, 15.09.2006
- http://www.letteraltura.it/9314,Ospite.html Biografia LetterAltura 2009
- https://www.anobii.com/books/la-liberazione/9788886593625/01e4588fd3d142057e/reviews/546495badd97263c608b456d Recensione a La liberazione su Anobii, 24.03.2010
- http://nottedinebbiainpianura.blogspot.com/2011/03/franse-di-erminio-ferrari-casagrande.html Recensione a Fransè di Angelo Ricci, 16.03.2011
- https://www.pordenonelegge.it/festival/edizione-2016/autori/2473-Erminio-Ferrari Bio-bibliografia di Erminio aggiornata al 2016
- https://www.corriere.it/cronache/17_aprile_22/minatori-italiani-uccisi-gas-marcinelle-dimenticata-svizzera-8534a70e-26c7-11e7-b6b1-a150ed5c16fd.shtml La tragedia di Marcinelle nel libro di Erminio Ferrari di Paolo Di Stefano, 21.04.2017
- https://www.rsi.ch/rete-uno/programmi/informazione/albachiara/Cielo-di-stelle-Robiei-15-febbraio-1966-8936182.html Presentazione di Cielo di Stelle, 21.04.2017
- https://www.viceversaletteratura.ch/book/16988 Recensione a Cielo di stelle, 5.01.2018
- http://sebamarvin.com/recensione-di-cielo-di-stelle-di-erminio-ferrari/ Recensione a Cielo di stelle, 9.01.2018
- http://mdm.atte.ch/MDM0390-pdf-articolo.pdf Recensione a Cielo di Stelle di Orazio Martinetti
- https://www.planetmountain.com/it/notizie/libri-stampa/valzer-per-un-amico-la-montagna-gli-uomini-e-la-vita.html Recensione di Valzer per un amico, 2.06.2020
Notizia della scomparsa, commenti, ricordi e iniziative
- http://cdn2.prealpina.it/pages/cannobio-precipita-dalla-montagna-morto-232705.html Prealpina, 14.10.2020
- https://www.lastampa.it/verbano-cusio-ossola/2020/10/14/news/escursionista-precipitato-in-valgrande-intervento-dell-elisoccorso-1.39415743 La Stampa VCO, 14.10.2020
- https://www.loscarpone.cai.it/addio-a-erminio-ferrari/ Lo scarpone, notiziario del CAI 14.10.2020
- https://www.montagna.tv/168538/val-grande-muore-in-un-incidente-lo-scrittore-erminio-ferrari/ 14.10.2020
- https://www.cdt.ch/ticino/locarno/addio-a-erminio-ferrari-AI3309057?_sid=i4wowsmm&refresh=true Corriere del Ticino, Addio a Erminio Ferrari, 14.10.2020
- https://ilgiornaledelticino.ch/tragedia-in-val-grande-morto-il-collega-erminio-ferrari/ 14.10.2020
- https://www.laregione.ch/cantone/ticino/1467977/erminio-ferrari-montagna-laregione-penna Addio a Erminio Ferrari, penna de ‘laRegione’, 14.10.2020
- https://www.laregione.ch/opinioni/commento/1468000/erminio-montagna-ermi-se-occhi Ciao Ermi, ci mancherai di Matteo Caratti 14.10.2020
- https://www.laregione.ch/opinioni/commento/1468068/erminio-notte-ferrari-fare-giornalista Un’ultima notte con Erminio Ferrari, giornalista di Lorenzo Erroi, 14.10.2020
- https://www.planetmountain.com/it/notizie/alpinismo/addio-ad-erminio-ferrari.html di Vinicio Stefanello 14.10.20
- https://www.rsi.ch/news/ticino-e-grigioni-e-insubria/Morto-Erminio-Ferrari-13515556.html RSI news del 14.10.2020 con tre video; modificato il 30.10.2020
- https://www.tio.ch/ticino/cronaca/1467987/ferrari-montagna-caduta-erminio-giornalista Il portale del Ticino del 14.10.2020, articolo di Davide Milo
- https://www.verbaniamilleventi.org/la-montagna-fatale-a-erminio-ferrari/ 14.10.2020, Ricordo di Matteo Gasparini
- http://www.parcovalgrande.it/novdettaglio.php?id=61758 Il ricordo di Erminio Ferrari, 15.10.2020
- https://www.discoveryalps.it/e-morto-erminio-ferrari/ 15.10.22020 con video LetterAltura 2016
- https://www.laregione.ch/cantone/ticino/1468199/erminio-montagna-anni-ferrari-guerra-giornalismo-redazione-giornalista-grande-ermi Erminio Ferrari: penna, scarponi e passione (il ricordo dei colleghi), 15.10.2020
- https://www.varesenoi.it/2020/10/15/leggi-notizia/argomenti/cronaca-20/articolo/tragica-caduta-in-val-grande-la-montagna-piange-il-volontario-del-soccorso-alpino-erminio-ferrari.html VareseNoi cronaca del 15.10.2020
- https://www.laregione.ch/opinioni/commento/1468478/ermi-anni-erminio-parole-redazione-giorno-tempo-libri-persona-cose ‘Hasta siempre’ Ermi. I saluti e i ricordi della redazione de laRegione, 16.10.2020
- https://www.rsi.ch/rete-due/programmi/cultura/laser/Oltre-la-cima-In-ricordo-di-Erminio-Ferrari-12995384.html ricordo di Erminio in onda il 16.10.2020 a cura di Emanuela Burgazzoli
- https://www.lastampa.it/topnews/edizioni-locali/verbano-cusio-ossola/2020/10/17/news/l-ultimo-abbraccio-di-cannonio-a-erminio-ferrari-ora-sei-nelle-tue-vette-che-hai-sempre-amato-1.39427611 (solo per abbonati) 17.10.2020
- https://www.laregione.ch/rubriche/generi-di-conforto-podcast/1468631/ferrari-erminio-ermi-genere-conforto Podcast Generi di Conforto: ricordo di Erminio Ferrari (puntata 33, 17.10.20)
- https://www.tvsvizzera.it/tvs/letteratura-_storie-di-confine–addio-a-erminio-ferrari/46100990 TV Svizzera per l’Italia del 18.10.2020, articolo di Leonardo Spagnoli
- https://www.verbanonews.it/aree-geografiche/canton-ticino/2020/10/25/un-premio-in-ricordo-di-erminio-ferrari/918662/ Premio in ricordo di Erminio su Verbano news del 25.10.2020
- https://corsodigiornalismo.ch/2020/12/21/assegnati-il-premio-erminio-ferrari-e-il-premio-renato-porrini-2020/ Corso di giornalismo Svizzera italiana, 21.12.2020
- https://www.tio.ch/ticino/attualita/1479760/erminio-premio-ferrari-onore-reportage Assegnato il Premio Erminio Ferrari (1a edizione); articolo di Jenny Covelli del 10.12.2020
- https://www.facebook.com/events/148312347345355/?ref=newsfeed Erminio Ferrari, giornalista, scrittore e tutto il resto … Fabbrica di Carta Villadossola 2.06.2021, evento
- https://www.facebook.com/fabbricadicarta/videos/338699741201639 Erminio Ferrari, giornalista, scrittore e tutto il resto … Fabbrica di Carta Villadossola: 2.06.2021, Video in diretta
- https://www.laregione.ch/cantone/locarnese/1530769/baitin-montagna-erminio-ferrari-limidario Lassù in montagna, ricordando Erminio Ferrari di Stefano Guerra 23.08.2021
- https://www.ossolanews.it/2021/09/04/leggi-notizia/argomenti/cultura-e-spettacoli-4/articolo/aspettando-lettealtura-unescursione-e-un-convegno-in-ricordo-di-erminio-ferrari.html Convegno in ricordo di Erminio Ferrari, 4.09.2021
- https://www.facebook.com/edizioniCasagrande/posts/1480595305624822 (3.09.2021)
- http://www.ticino24.it/index.php/9762-all-alpe-colle-ricordando-erminio-ferrari (4.09.2021)
- https://www.associazioneletteraltura.com/prodotto/aspettando-il-festival-ricordo-di-erminio-ferrari/ (4.09.2021)
Articoli, interviste, racconti di Erminio Ferrari reperibili online
- https://www.planetmountain.com/it/notizie/interviste/silvia-vidal.html Erminio ed Ellade Ossola intervistano Silvia Vidal, 20.09.2003
- https://www.planetmountain.com/it/notizie/alpinismo/walter-bonatti-2005-lintervista.html intervista a Walter Bonatti, La Regione Ticino 14 maggio 2005
- https://www.planetmountain.com/it/notizie/alpinismo/quattordici-volte-edurne-pasaban.html Erminio ed Ellade Ossola intervistano Edurne Pasaban, 24.09.2010
- https://www.planetmountain.com/it/notizie/alpinismo/ueli-steck-i-record-le-visioni-e-i-limiti-dellalpinismo.html Erminio ed Ellade Ossola intervistano Ueli Steck, 19.11.2011
- https://www.planetmountain.com/it/notizie/libri-stampa/attraverso-il-sempione-sentieri-roccia-neve-ghiaccio-di-enrico-serino.html recensione di Attraverso il Sempione – sentieri, roccia, neve, ghiaccio di Enrico Serino, 9.04.2013
- https://www.planetmountain.com/it/notizie/alpinismo/volevamo-solo-scalare-il-cielo-la-solidarnosc-degli-ottomila.html Recensione di Volevamo solo scalare il cielo di Bernadette McDonald, 10.05.2013
- https://www.planetmountain.com/it/notizie/alpinismo/nanga-parbat-1970-la-recensione-di-erminio-ferrari.html Recensione di Nanga Parbat 1970, di Jochen Hemmleb, 23.05.2013
- https://www.planetmountain.com/it/notizie/alpinismo/everest-60-anni-tra-mito-e-business.html Everest, 60 anni tra mito e business, 29.05.2013
- https://www.planetmountain.com/it/notizie/libri-stampa/di-roccia-e-di-ghiaccio-la-storia-dellalpinismo-in-12-gradi-ripercorsa-da-enrico-camanni.html recensione a Di roccia e di ghiaccio di Enrico Camanni, 27.10.2013
- https://www.planetmountain.com/it/notizie/libri-stampa/il-peso-delle-ombre-di-mario-casella-un-libro-sull-alpinismo-le-bugie-e-le-calunnie.html recensione a Il peso delle ombre di Mario Casella, 14.09.2017
- https://www.laregione.ch/estero/confine/1336197/punta-del-nuovo-weisstor Punta del Nuovo Weisstor, 17.11.2018
- https://www.laregione.ch/ticino7/ticino7/1364900/sull-ofentalhorn Sull’Ofentalhorn, 21.04.2019
- https://www.planetmountain.com/it/notizie/interviste/intervista-a-reinhold-messner.html Erminio ed Ellade Ossola intervistano Reinhold Messner, 13.01.2020
- https://www.laregione.ch/ticino7/ticino7/1450035/cornera-devero-anni-maurino-vetta-cima-pizzo Pizzo Cornera. Toccare la cima, ma con molta attenzione, 18.07.2020
- https://www.pressreader.com/switzerland/laregione/20201003/282136408864388 Un blues per Gilardi, 2.10.2020
- https://www.pressreader.com/switzerland/laregione/20201003/282136408864388?fbclid=IwAR0jweSmzBejpTSD9SfeF6_lKkBtD9qLcOm8ZE-ZKcQA6JGLbivsQB8dX6g
- https://www.laregione.ch/ticino7/ticino7/1468457/valzer-giorgio-musica-tempo-montagna-parole-amico-banda-zio-erminio Valzer per un amico, 17.10.2020
- Ricerca degli articoli di e su Erminio Ferrari sulla stampa ticinese (occorre login):
- https://www.pressreader.com/search?query=erminio%20ferrari
[1] La liberazione. Cannobio, agosto-settembre 1944, Tararà, Verbania 2006.
[2] Lorenzo Camocardi, Trarego memoria ritrovata, Lungometraggio, Casa della Resistenza, Verbania 2007.
[3] Nino Chiovini, Classe IIIaB. Cleonice Tomassetti vita e morte, Tararà, Verbania 2010, 3a edizione.
[4] Mi ricordo la rossa. Storie e luoghi dell’Alpe Devero, Tarara, Verbania 2009.
[5] Nino Chiovini, Mal di Valgrande, Vangelista, Milano 1991; 2a ed. Tararà, Verbania 2002.
[6] Tararà, Verbania 1996.
[7] Il partigiano caduto e riconosciuto dalla madre è Sergio Ciribi; cfr. Nino Chiovini, Classe IIIaB. Cleonice Tomassetti Vita e morte, Tararà, Verbania 2010, p. 36-42.
[8] “Il 27 agosto di ogni anno a Cannobio si celebra una messa di ringraziamento nel santuario della Santa Pietà, perché nel 1944 il Signore aveva guardato giù e salvato Cannobio dalla rappresaglia”. La liberazione cit., p. 23.
[9] Dopo la rioccupazione di Cannobio il comando tedesco imporrà alla autorità elvetiche il rientro in Italia di quei militari tedeschi che si erano illusi troppo presto di esser usciti dalla guerra.
[10] Tzvetan Todorov, Una tragedia vissuta. Scene di guerra civile, Garzanti, Milano 1995.
[11] Tzvetan Todorov, Una vita da passatore. Conversazione con Catherine Portevin, Sellerio, Palermo 2010, p. 429.
[12] Erminio Ferrari, “Storie di treni e di contrabbando” in Matteo Terzaghi e Matteo Campagnoli (a cura), Negli immediati dintorni. Guida letteraria tra Lombardia e Canton Ticino, Casagrande-Doppiozero, Bellinzona-Milano 2015, p. 57.
[13] Casagrande, Bellinzona 2002.
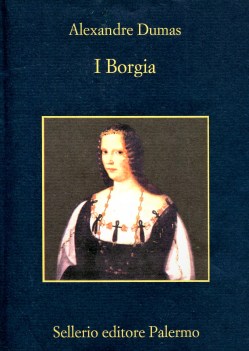
La “Fabbrica di Carta”, il salone annuale del libro del VCO, dopo la chiusura forzata del 2020, quest’anno tra maggio e giugno si è realizzata con il titolo: “Storie nella Storia. Il romanzo storico: da Manzoni a Buticchi”. Non sono un amante del genere ma l’abbinamento Dumas-Borgia-Sellerio[1] mi ha incuriosito.
La triade criminale
Come molti commenti hanno sottolineato più che un romanzo storico questa è una “cronaca criminale” che rientra nei diciotto “Delitti celebri” che Alexandre Dumas compose tra il 1835 e il 1840 ripercorrendo le più significative efferatezze dal Rinascimento agli anni a lui contemporanei; all’epoca si era distinto quale commediografo e giornalista e solo successivamente si dedicherà ai suoi più famosi romanzi storici. Il taglio è appunto fra il giornalistico e il cronachistico, rigorosamente in terza persona e con scarsa presenza di dialoghi a sottolineare implicitamente che quanto riportato non è invenzione letteraria ma frutto di una attenta ricerca documentale.
La vicenda si snoda fra il 1492, anno della elezione di Rodrigo Borgia a pontefice col nome di Alessandro VI e il 1507 con la morte del figlio Cesare, ormai in declino dopo la morte nel 1503 del padre, in un combattimento minore sul confine tra Navarra e Castiglia.
Gran parte della cronaca viene ricostruita in modo dettagliato (congiure, trattati e tradimenti, cambi di alleanze, cerimonie, sfilate militari, battaglie, ecc., ecc.) e risulta francamente noiosa laddove la minuziosità dei particolari fa più volte perdere il filo complessivo della narrazione. Non mancano comunque in questa ricostruzione del potere dei Borgia, dei loro crimini e del loro declino, momenti letterari intensi: oltre all’apertura con il dialogo immaginario fra il morente Lorenzo il Magnifico e il fanatico frate Savonarola e la chiusura, con la citazione di una novella del Boccaccio, posso ricordare la corrida a cui Cesare ha invitato il cognato Alfonso d’Aragona.
Una cornice spagnolesca ricostruita nel cuore della città santa in cui i due cognati si salvano reciprocamente dalla furia dei tori appositamente aizzati, a suggellare ufficialmente un patto fra dinastie, in realtà a mascherare il delitto progettato del marito di Lucrezia, ormai divenuto ingombrante per i piani del Pontefice e di suo figlio. E, all’interno di questa cornice, nel momento in cui Cesare rischia di esser travolto dal toro “un grido di donna partì da una delle finestre”. Alfonso attira l’attenzione del toro verso di lui,
“poi, quando la bestia fu a tre passi, fece un balzo di lato offrendogli invece del fianco la spada che affondò fino all’elsa nel corpo dell’animale. Il toro, fermato a metà della sua corsa, restò un istante immobile e fremente sulle quattro zampe, poi cadde sulle ginocchia, emise un muggito sordo e spirò.
Gli applausi scoppiarono da tutte le parti, tanto la stoccata finale era stata data con destrezza e rapidità. Cesare era rimasto a cavallo e cercava con gli occhi, invece di occuparsi di quello che stava succedendo, la bella spettatrice che aveva manifestato col suo grido un così vivo interesse per lui. La sua ricerca non fu infruttuosa poiché aveva riconosciuto una delle damigelle d’onore di Elisabetta, duchessa d’Urbino, fidanzata a Giovanni Caracciolo, capitano generale della repubblica di Venezia.”[2]
E poche pagine dopo sapremo che la bella damigella destinata al veneziano Caracciolo pagherà drammaticamente l’aver destato l’attenzione del duca Valentino: la farà rapire tenendola prigioniera per soddisfare i suoi piaceri sin quando, ormai non più interessato, la farà ritrovare cadavere nel Tevere.
Uno dei numerosissimi delitti della triade che così Dumas definisce: Rodrigo, Cesare e Lucrezia
“formavano la trinità diabolica che regnò per undici anni sul trono pontificio, come una parodia sacrilega della Trinità celeste.”[3]
L’elenco di misfatti e delitti sarebbe lunghissimo e anche difficile elencarne tutte le tipologie: incesto, stupro, rapimento, inganno, falsificazione di documenti, tradimento, corruzione, simonia, nepotismo, assassinio, avvelenamento, sottrazione di cadavere, fratricidio, uxoricidio, ecc. ecc.
Se nella storiografia, nella letteratura e nella cultura di massa, dai film ai fumetti, l’attenzione si è poi concentrata su Cesare e Lucrezia, Dumas mette bene in luce come nella “triade criminale” / “trinità diabolica” abbia un ruolo centrale il padre Rodrigo che sale al soglio con una prospettiva ben precisa di politica familiare.
Rodrigo (Alessandro VI)
Nato nel 1931 nel territorio di Valenza, dopo gli studi di diritto e una iniziale carriera di avvocato “che abbandonò per quella delle armi”.
“Ma dopo qualche prodezza per provare il suo sangue freddo e il suo coraggio, anche questa gli venne a noia. Proprio allora suo padre morì, lasciando una fortuna considerevole e Rodrigo decise di restare ozioso ispirandosi solo al suo estro e alla sua fantasia. A quest’epoca, diventò l’amante di una vedova che aveva due figlie. La vedova morì, lui prese le ragazze sotto tutela, ne mise una in convento e poiché l’altra era una delle più belle donne mai viste, se la tenne come amante. Era la famosa Rosa Vannozza, da cui ebbe cinque figli: Francesco, Cesare, Lucrezia e Goffredo; non si sa il nome del quinto.”[4]
Sembrava orientato a vivere di rendita ma tutto cambiò con la nomina di suo zio Alfonso che divenne papa col nome di Callisto III (1455-1458): questi lo volle a Roma nominandolo successivamente arcivescovo di Valenza e cardinale.
“Aveva fatto un po’ fatica ad accettare il cardinalato che lo incatenava a Roma e avrebbe preferito essere vicario generale della Chiesa, posizione che gli avrebbe dato maggiore libertà di vedere la sua amante e la sua famiglia. Ma suo zio Callisto gli fece balenare davanti agli occhi la possibilità di succedergli un giorno e, da quel momento, l’idea di essere il capo supremo dei re e delle nazioni si impossessò a tal punto di Rodrigo, che non pensò più che al fine che suo zio gli aveva fatto intravedere.” [5]
Trentaquattro anni dopo la morte dello zio e altri quattro pontefici (Pio II, Paolo II, Sisto IV e Innocenzo VIII) nel 1492 Rodrigo, sbaragliando (e corrompendo) gli avversari, ascese al “sacro soglio” assumendo il nome di Alessandro VI e da quella inattaccabile posizione riconobbe i propri figli illegittimi, li collocò nei vari centri di potere, ne organizzò (e disfò) matrimoni, emanando nei loro confronti ordini (anche scellerati) e comunque coprendone i misfatti. La storia della chiesa considera comunque il suo un pontificato di rilievo e innovatore.
Cesare (duca Valentino)
“Cesare Borgia apprese la notizia dell’elezione di suo padre all’università di Pisa dove studiava. La sua ambizione aveva talvolta sognato una simile fortuna, eppure la sua gioia fu smisurata. Era allora un giovane fra i ventidue e i ventiquattro anni, abile in tutti gli esercizi fisici e soprattutto nelle armi. Capace di montare a pelo i più focosi cavalli e di tranciare la testa a un toro con un solo colpo di spada, era però arrogante, geloso, subdolo e, secondo Tommasi, grande fra gli empi […] Tale era l’uomo a cui il destino aveva appena appagato ogni desiderio e che aveva come motto: «Aut Caesar, aut nihil», «O Cesare o niente».”[6]
Mentre il fratello minore, Giovanni, fu instradato al potere politico-militare, Cesare fu nominato dal padre Cardinale, nomina che non corrispondeva ai suoi auspici, più orientato alla vita civile, a festosi festini e alle imprese militari. Dopo l’uccisione del fratello Giovanni (che molti, Dumas compreso, hanno attribuito a un ordine di Cesare), preferì tornare allo stato laicale.
“Dopo la morte del fratello, Cesare aveva mostrato con tutte le sue azioni la scarsa vocazione per la vita ecclesiastica; quindi nessuno fu stupito quando, nel corso di un concistoro riunito da Alessandro VI, Cesare entrò e rivolgendosi a lui, cominciò a dire che fin dai suoi primi anni, per le sue doti e per il suo talento, si era sentito portato verso le professioni secolari, e che si era dato alla Chiesa, accettando la porpora, le altre cariche e l’ordine sacro del diaconato solo per obbedire a Sua Santità.”[7]
Ottenuto il benestare abbandonò la porpora e si dedicò alla sua avventura di conquista di un ampio ducato in Italia centrale. Rapida meteora che abbagliò molti, a partire da Machiavelli, ma che decadde rapidamente dopo la morte, e la protezione, del padre.
Dumas la ritrae a tinte fosche: “La sorella era degna campagna del fratello. Libertina per fantasia, empia per temperamento, ambiziosa per calcolo, Lucrezia bramava piaceri, adulazioni, onori, gemme, oro, stoffe fruscianti e palazzi sontuosi. Spagnola sotto i suoi capelli biondi, cortigiana sotto la sua aria candida, aveva il viso di una Madonna di Raffaello e il cuore di una Messalina, perciò gli [a Rodrigo] era cara e come figlia e come amante perché si vedeva in lei, come in uno specchio magico, con le proprie passioni e i propri vizi.”[8]
In realtà, nonostante questa premessa (e la copertina a lei dedicata dall’editore) in tutta la narrazione Lucrezia ha un ruolo minore e viene il dubbio che più che una protagonista efferata fosse piuttosto la vittima delle volontà del padre e del fratello. Riuscì poi a costruirsi una vita indipendente e un personale prestigio dopo la morte del padre e il declino e morte del fratello. Così ne chiude la vicenda Dumas:
“In quanto a Lucrezia, la bella duchessa di Ferrara, morì tra gli onori e il fasto, adorata dai suoi sudditi come una regina e cantata come una dea dall’Ariosto e dal Bembo.”[9]
[1] Alexandre Dumas, I Borgia, Sellerio, 2004.
[2] Pag. 198-199.
[3] Pag. 52.
[4] Pag. 39-40.
[5] Pag. 41-42.
[6] Pag. 45.
[7] Pag. 154-155.
[8] Pag. 52.
[9] Pag. 283.
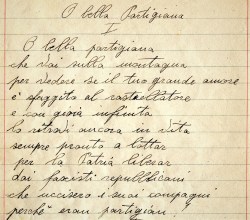
a cura del Centro di Documentazione della Casa della Resistenza**
Risalire all’origine dei canti partigiani non è operazione facile sia per il contesto “alla macchia” in cui sono nati che per le caratteristiche proprie di trasmissione orale con il suo continuo riadattamento da luogo a luogo, da banda a banda. Salvo poche eccezioni di testi scritti da uno specifico autore, sono stati sottoposti – sul piano melodico e testuale – a una costante “rielaborazione della tradizione”, iniziata nei mesi della Resistenza e proseguita nel dopoguerra e naturalmente tuttora in atto. Ne fa fede la canzone oggi più cantata – anche all’estero – della Resistenza: Bella Ciao della quale non è noto quanto (e, per alcuni, se) e dove sia effettivamente risuonata durante la Lotta di Liberazione, tanto che Cesare Bermani ha potuto inizialmente definirla una vera e propria “invenzione della tradizione” [1].
Grazie a una donazione[2]il nostro Centro è in possesso di un importante documento coevo: un quaderno dove, in 48 pagine, sono trascritte con cura 30 Canzoni Partigiane. È stato compilato tra il febbraio 1945[3] e i primi due o tre mesi dopo la liberazione dalla ventenne Maria Luisa Fontana (1924 – 2017); era residente a Intra ma la sua famiglia aveva stretti legami con il paese di Intragna, dove spesso stazionava, e con noti esponenti della Resistenza. Intragna è stata inoltre in più occasioni sede di comandi partigiani (Cesare Battisti, Valgrande Martire, e successivamente della Divisione Mario Flaim); Nino Chiovini ricorda anche il ruolo importante che avevano alcune staffette del paese[4].
Salvo due canzoni di diffusione nazionale (La guardia rossa e Fischia il vento[5]) le altre fanno tutte riferimento alle bande e al territorio locali: dal Verbano al Cusio e alla Valsesia. Tre sole sono di autori partigiani noti[6]: Marciar Marciar di Antonio Di Dio, La strada del Pian Vadaà e La volante Martiri di Trarego scritte da Nino Chiovini.
Un primo gruppo riporta gli inni di alcune formazioni: Valdossola, Cesare Battiti e Giovine Italia.
E tutto intorno ai monti
e alle vali del Verbano
ascolti un coro che nessun uguaglia
è il Battaglion Val d’Ossola
e si sente da lontano
la quarta banda
è la giovane Italia,
giovani forti ardenti ed italiani
son loro, sono i nostri partigiani.
Nazi-fascisti finiran nell’onde
del lago dove sono più profonde.
Gridan le voci, grida la mitraglia
i figli siamo noi
della Giovane Italia![7]
Un altro gruppo è dedicato a partigiani caduti. Due al giovane partigiano Lupo[8] (La canzone del Lupo e Lupo): “Oh Lupo sulla montagna / triste e breve è stata la tua campagna; La canzone a Romeo è dedicata al diciannovenne partigiano Mario Brasca caduto il 17 giugno ’44 sulla Marona: “Disse Luigi[9]/ un partigiano in pianto / Romeo riposa lassù sulla Marona / tra neve e ghiaccio”. Una quarta (La canzone a Franco) è dedicata a un partigiano, non identificato, ferito a morte in un trasferimento verso Gozzano per un recupero di armi. Non mancano le canzoni dedicate ai caduti negli eccidi di Fondotoce (Il canto dei 43 fucilati) e Trarego (I 7 martiri e quella sopra citata di Chiovini).
Un aspetto importante del documento è l’indicazione “Si canta sull’aria di …”, in calce alla maggioranza dei testi, che ci permette non solo di “rivivere” le canzoni ma di percepirne il clima e gli aspetti della cultura popolare di riferimento. Oltre ad alcuni inni patriottici di guerra e degli alpini (Piave, Monte Grappa) ben quattro fanno riferimento al repertorio fascista (Giovinezza e gli Inni dei Sommergibilisti, della X Mas e del Battaglione S. Marco) con un rovesciamento tematico dove ad esempio Giovinezza si trasforma in “Capitano capitano / che dal signore sei mandato / tutta Omegna ti saluta / inneggiando al tuo valor …”. In un caso il rovesciamento non è solo tematico, ma beffardo: sull’aria dell’Inno della X Mas ci si rivolge alle ragazze che hanno amoreggiato con i fascisti:
Piangeranno piangeranno
le ragazze di Verbania
se la Decima va via
resterà sol la borghesia
ma i borghesi non le vorran!
I temi melodici più consistenti sono però quelli riferiti alla musica leggera e ballabile composta e diffusa a livello popolare negli anni Trenta e primi Quaranta. Abbiamo ad esempio L’Olandesina[10] dove la storia del baleniere Morris, morto sul mare lasciando alla amata Ketty solo l’eco della sua canzone, si trasforma con poche variazioni nella Cusianina che “amava Bruno il suo bel partigian” morto in montagna. Recupero melodico e tematico ripreso anche in altre aree della lotta partigiana, ad esempio in Romagna (Santa Sofia) dove la bella Vanna piange il partigiano Stoppa[11]. Altre melodie di quegli anni richiamate sono La mia canzone al vento, Campagnola bella, Il tango delle capinere e Rosabella del Molise dove l’invocazione dell’innamorato “Rosabella dimmi sì sì sì” diventa “Patriota vieni giù giù giù / a salvar la gioventù”. All’allegro ritmo di polka della notissima Rosamunda abbiamo due versioni di Oh Fascista! quale irrisione dell’avversario (“tu mi fai morir / perché sui monti / tu non vuoi venir” oppure “ti ricordi / di quel mitra che ti ho fregato / disteso su quel prato / oh che felicità!”).
Non mancano qua e là anche note melanconiche e nostalgiche: in particolare con la canzone Nella notte che riprende la melodia di Una strada nel bosco[12]:
Le prime stelle in cielo brillano già
e un avamposto
veglia e all’erta sta …
Tace
la vallata ed il monte
solo l’eco risponde
col suo placido suon.
I partigiani allor
cantano con languor
cercando di non pensare più
agli affetti lontani!
* Pubblicato in forma leggermente ridotta sul n. 2/2020 di Nuova Resistenza Unita, pag. 12-13.
** Ringraziamo Arialdo Catenazzi “Ari” per l’aiuto nell’identificazione dei nomi di battaglia riportati nel documento.
—————
Indice delle canzoni
- Marciar Marciar [cfr. av popolo 141-142]
- Inno della IV Banda della Giovane Italia (si canta sull’aria del Piave)
- Canzone del B. [Battaglione] Val d’Ossola
- Capitano (Si canta sull’aria di Giovinezza)
- A mezzanotte va (Sull’aria del Ronda) [Tango delle capinere)
- La canzone del Lupo
- Lupo (si canta sull’aria di Vento) [La mia canzone al vento]
- La canzone a Franco
- La canzone della Banda Cesare Battisti (Monte Zeda)
- Oh Fascista! (Sull’aria di Rosamunda)
- Chiome (Sull’aria di Vento) [La mia canzone al vento]
- O bella Partigiana
- Il canto del partigiano (Sull’aria dell’Inno dei Sommergibili)
- Nella notte (Sull’aria di C’è una strada nel bosco)
- La canzone a Romeo
- Patriota vieni giù (Sull’aria di Rosabella dimmi di sì)
- Nella Valsesia (Sull’aria della Campagnola)
- Siam ribelli (Sull’aria di Battaglioni M.)
- La strada del Pian Vadaà
- Oh fascista! [altra versione. Sempre] (sull’aria di Rosamunda)
- Cusianina (Sull’aria di Olandesina)
- La guardia rossa
- Vinceremo (Sull’aria del Batt. S. Marco)
- Garibaldi (Sull’aria dell’Inno “Monte Grappa”)
- Inno del ribelle
- I 7 martiri (
di Trarego. O traditor) - Il canto dei 43 fucilati
- La volante Martiri di Trarego (Sull’aria del canto russo)
- Il canto del partigiano Russo (tradotto in italiano [Fischia il vento])
- Il canto per chi rapate saran! (Sull’aria del canto della Decima Mas)
Il PDF con l’intero quaderno è scaricabile > qui <
[1] Avanti popolo. Due secoli di canti popolari e di protesta civile, Istituto Ernesto De Martino, 1998, p. 144. Le più recenti ricerche dello stesso Bermani la avvalorano come canto diffuso fra i partigiani del centro Italia: cfr. C. Bermani, Bella ciao. Storia e fortuna di una canzone dalla resistenza italiana all’universalità delle resistenze, Interlinea, Novara 2020.
[2] di Tiziano Maioli, guida ufficiale del Parco Nazionale ValGrande, figlio dell’autrice.
[3] Il retro della copertina porta la data del 20-2-45.
[4] “Sadìn e Margherita”: Fuori legge???. Dal diario partigiano alla ricerca, Tararà 2012, p. 145.
[5] Qui titolata Il canto del partigiano Russo (tradotto in italiano).
[6] Nomi non riportati sul quaderno; i testi hanno non poche varianti anche se di poco peso.
[7] Seconda strofa dell’Inno della IV Banda della Giovane Italia (“Si canta sull’aria del Piave”).
[8] Renzo (Vincenzo) Calabrese di Intra (classe 1925), caduto a Unchio il 21 gennaio 1945.
[9] Luigi Fumagalli Cinema; nel suo diario partigiano racconta della morte di Romeo e cita quattro versi di questa canzone: P. De Toni – A. Catenazzi – E. Monti (a cura), Vite Partigiane, ANPI VCO 2013, p. 55-57.
[10] Su questa melodia anche la sopracitata canzone dedicata a Romeo.
[11] Cfr. https://www.antiwarsongs.org/canzone.php?id=51911&lang=it.
[12] Attribuita e cantata dal baritono Gino Bechi (1943) e implicitamente riferita ai bombardamenti alleati.

Nel 2019 esce, edito da Laterza, “Storia della Resistenza” di Marcello Flores e Mimmo Franzinelli, opera innovativa che affronta la storia complessiva della Resistenza italiana facendo tesoro degli studi più recenti a partire dalla svolta impressa da Claudio Pavone nel 1991 con Una guerra civile. Saggio sulla moralità nella Resistenza. Nel 2020 Franzinelli pubblica “Storia della Repubblica Sociale Italiana 1943-1945” opera che colma un vuoto sostanziale rispetto agli studi sul fascismo, in genere incentrati sul periodo precedente oppure, per il periodo di Salò, su singoli aspetti[i]. Due opere corpose – oltre 1300 pagine – che mantengono la stessa struttura (capitoli tematici in successione logica e cronologica, foto d’epoca e un testo-documento esemplare a conclusione di ogni capitolo) e la stessa metodologia: analisi estesa al medio periodo e costantemente intrecciata con le biografie di personaggi, noti e meno noti, che esplicitano le tematiche affrontate e ne illustrano le articolazioni non sempre convergenti. Due percorsi paralleli – Resistenza e fascismo repubblicano – e nello stesso tempo con dinamiche fra loro rovesciate.
“Abbiamo voluto raccontare la molteplicità della Resistenza, il suo essere costituita da tante spinte diverse, azioni differenti, partecipazioni ineguali ed eterogenee, ma convergenti – pur con motivazioni ideali e pratiche, individuali e collettive, dissimili – verso un unico fine, quello di riacquistare la libertà, sconfiggere il nazismo, disfarsi dell’eredità fascista che aveva oscurato per vent’anni l’Italia”. … “La Resistenza è stata molteplice, articolata, sfaccettata, è stata l’insieme di scelte e comportamenti differenti che si sono intrecciati e sommati in un arco di tempo molto compresso (venti mesi)”[ii].
Articolazione e diversità che si manifesta sin dall’inizio, anzi in più casi “prima dell’inizio” come nella vicenda della maestra trentina Clara Marchetto che copia nel 1940 la documentazione sulla corazzata Littorio per farla pervenire agli alleati, ma denunciata da un infiltrato sarà condannata dal regime all’ergastolo. Liberata nel ’44 dal Comando alleato sarà tra i fondatori del Partito Popolare triestino; denunciata dal democristiano Flaminio Piccoli nel 1949 per tradimento della Patria sarà di nuovo incarcerata e, connessa la libertà provvisoria, preferirà espatriare per non tornare in carcere.
Articolazione che riflette le diverse origini, molto spesso più sociali e territoriali che politiche; scelte per alcuni nate prima dell’8 settembre come per molti militari con l’esperienza traumatica della guerra all’estero, in Grecia e in Russia in particolare, che li ha distaccati dal fascismo, anche chi, come il cattolico Teresio Olivelli, che del fascismo e del culto della “razza italiana” era stato acceso sostenitore. Altrettanto articolato il supporto (il retroterra) che donne, operai, contadini, clero ecc. danno, in forme più o meno attive e convinte, al movimento partigiano.
Vi sono luoghi e situazioni che diventano implicitamente centri di formazione alla libertà.
“I partigiani nascono sulle cime montuose. Sono il frutto di una seminagione avvenuta nella seconda metà degli anni Trenta, quando una generazione di futuri promotori del ribellismo visse l’alpinismo come fattore identitario e stile di vita […] prima di impegnarsi nella Resistenza maturarono un’esperienza e un’etica alpinistiche di prim’ordine, premessa e coronamento della scelta antifascista quale ricerca interiore di libertà. Molti futuri partigiani si sono formati alla Scuola militare di alpinismo di Aosta, fondata nel gennaio 1934 e affidata alla direzione del tenente colonnello Luigi Masini. Al momento dell’armistizio Masini è generale e comanda la 3a Brigata Alpina; evita la cattura da parte tedesca, prende contatto con i primi ribelli di Brescia e di Trento, e nel 1944 assume il comando delle Fiamme Verdi (nel 1953 diverrà deputato per il Partito socialista). L’avvocato Ettore Castiglioni (1908), scalatore e importante studioso, autore di numerose guide alle Alpi, richiamato alle armi nel 1942 e assegnato quale istruttore alla Scuola militare di alpinismo di Aosta, mette a buon frutto le sue capacità per condurre al confine svizzero centinaia di ricercati politici e razziali (incluso il futuro presidente della Repubblica Luigi Einaudi), aiutato da una decina di suoi allievi alpini.”[iii]
Castiglioni fermato e internato dalle autorità elvetiche fuggirà senza attrezzatura né scarpe trovando la morte in montagna per assideramento. Atri caduti nati da questa esperienza sono Leopoldo Gasparotto ucciso dalle SS a Fossoli e il Colonnello bresciano Raffaele Menici che, data vita ad una formazione in Val Camonica collegata ai garibaldini, cadrà in un agguato tesogli da alcuni partigiani delle Fiamme verdi.
È questo uno degli episodi di scontro e violenza tra partigiani, come quello di matrice garibaldina commesso a Porzus[iv] o la uccisione sul Lago d’Orta del maggiore dei servizi USA William Holohan[v], episodi che una storiografia aggiornata, lasciate alle spalle le controversie legate al periodo della guerra fredda, non deve ignorare.
“Sono storie inevitabilmente amare […]. Storie rimaste troppo a lungo nell’ombra, anche per il timore di prestare il fianco ai denigratori della Resistenza […] In realtà danni assai maggiori ha prodotto un silenzio che di fatto ha amputato la complessità del movimento di liberazione nazionale, rendendolo monco e poco credibile agli occhi dei posteri.”[vi]
Se il movimento resistenziale si è alimentato di queste insorgenze dalle mille facce e, sia pur con contrasti, ha saputo convergere in un esito auspicato, inverso è il percorso della Repubblica Sociale: la storia di un tentativo irrisolto che conflitti interni, dipendenza dall’occupante germanico, esaltazione della violenza e razzismo portano a un progressivo sfaldamento.
“La RSI fu anzitutto il regno della discordia. È una storia contorta e complessa, dietro l’unità di facciata stanno linee divergenti, personaggi in rapporti conflittuali tra di loro.”[vii]
Innanzitutto il “pegno” pagato ad Hitler per la liberazione di Mussolini; il Reich il 1° ottobre annette tutto il nordest dal Trentino all’Istria e la Wehrmacht controlla direttamente tutto il territorio a sud di Roma a ridosso del fronte di guerra.
Pegno ribadito con il processo di Verona del gennaio ’44: “L’ambasciatore Filippo Anfuso (già legatissimo a Ciano) riferisce soddisfatto l’apprezzamento dei vertici nazisti per la portata simbolica delle sei fucilazioni:
«Non vi è dubbio che il processo di Verona abbia qui rivelato come l’Italia Repubblicana abbia tagliato i ponti col passato e come intenda essere vicino alla Germania in ogni modo e per sempre».[viii]
Una “repubblica” che non riesce a diventare Stato e che si frammenta in una pluralità e conflitti di competenze.
“Accanto e al di sopra di governo e Partito vi sono i Comandi germanici, ma pure i capi delle province, i comandanti di singoli reparti militari e dei nuclei di polizia più o meno regolari. La debolezza delle istituzioni centrali lascia spazio a potentati locali, in situazioni confuse e fluide, dentro le quali le visioni ideologiche cedono il passo alla tutela di interessi concreti. Salò è la capitale immaginaria di uno Stato dove la periferia conta più di quell’improbabile centro periferico.”[ix]
Uno sfaldamento crescente che miti quale quello della “fedeltà” o dei “ragazzi di Salò” non riescono a nascondere. Il gerarca Renato Ricci invia al fronte
“centinaia di giovani dai 16 ai 18 anni, considerati fascisti integrali pronti a battersi e a morire per l‘idea. […] Tra i lati peggiori e meno indagati vi è il fenomeno dei bimbi-soldati. Col ruolo di mascotte dispongono di piccoli ma efficienti fucili e pugnali. Partecipano ai rastrellamenti e sono spesso privi di freni inibitori; travolti immaturi nel turbine della guerra, la considerano naturale: torturare o uccidere il nemico è un gioco eccitante, legittimato dalla giustezza della causa e dal plauso dei camerati.”[x]
Uno “Stato” che vorrebbe dotarsi di un proprio esercito di leva come auspica il Ministro della difesa Graziani, senza ingerenza della Milizia e delle variegate bande in camicia nera. Per ottenerlo anche lui paga subito il pegno.
“Il 6 ottobre (1943) d’intesa coi tedeschi ordina il disarmo dei carabinieri romani rei il 25 luglio d’esser stati strumento del re e di Badoglio. Reparti paracadutisti, SS e camicie nere disarmano circa 2.000 carabinieri, destinati all’internamento e deportati in Austria, Germania e Polonia. Il 9 ottobre a Hitler e al comandante della Wehrmacht Graziani prospetta la costituzione di 25 Divisioni, ma gli viene concesso di allestirne quattro, meno di un sesto del suo obiettivo.”[xi]
Il tutto intriso di un razzismo che ha radici teoriche e pratiche nel ventennio.
“Il razzismo in camicia nera è autonomo da quello in camicia bruna: le discriminazioni contro i “meticci” in Eritrea e Somalia precedono di un quinquennio la svolta antiebraica del fatidico 1938. […] Il 18 aprile 1944 un decreto istituisce l’Ispettorato generale per la Razza, con sede a Desenzano del Garda, «alle dirette dipendenze del Duce» che verrà diretto da Giovanni Preziosi … colui che nel 1921 introdusse in Italia i «Protocolli dei savi anziani di Sion», amico dei tedeschi che lo avevano salvato e portato in Germania dopo il 25 luglio. Legato al filosofo Julius Evola (che si pregia di averlo quale «intimo amico e collaboratore») e ad altri intellettuali virulentemente antiebraici.”[xii]
E se, grazie alla amnistia di Togliatti (22.6.1946) e alla “Legge di clemenza” (7.2.1948) di Andreotti ben pochi e poco pagheranno per i crimini fascisti, nessuna condanna sarà inflitta per i reati razziali. “Ufficialmente dunque – per la magistratura della Repubblica italiana – la Repubblica Sociale non ha antisemiti condannati come tali.”[xiii]
Il senso profondo di questi due percorsi paralleli e inversi lo si trova nel “lascito morale della Resistenza”[xiv]esemplarmente rappresentato dalle oltre 600 lettere di condannati a morte raffrontato con le analoghe Lettere di caduti della RSI. Se in entrambi i casi forte è la dimensione personale e la preoccupazione per il dolore riservato ai familiari, ben diverso è l’orizzonte morale e politico di riferimento; nel primo caso orientato al futuro in uno scenario di libertà non solo agognato ma che si sente prossimo alla realizzazione, unito alla soddisfazione per avervi contribuito, nel secondo invece tutto orientato ad una “fedeltà” rivolta passato e intriso del modello assimilato del “Credere Obbedire Combattere” e della esaltazione della guerra come “verità della vita”.
Una citazione di Dietrich Bonhoeffer posta all’inizio del primo dei due volumi ci fornisce una efficace chiave di lettura per entrambi:
“Chi parla di soccombere eroicamente davanti a un’inevitabile sconfitta, fa un discorso in realtà molto poco eroico, perché non osa levare lo sguardo al futuro. Per chi è responsabile, la domanda ultima non è: come me la cavo eroicamente in quest’affare, ma: quale potrà essere la vita della generazione che viene. Solo da questa domanda storicamente responsabile possono nascere soluzioni feconde”.[xv]

* Pubblicato su Nuova Resistenza Unita (Anno XXI n. 2, II trimestre 2021, pp. 12-13).
Questo numero è dedicato, fra l’altro, al tema delle diseguaglianze (di ieri e di oggi) con contributi di Arianna Parsi, Enrico Fovanna, Stefano Montani, Paolo Crosa Lenz e Bruno Fornara, al ricordo di Claudio Perazzi (Paolo De Toni) e Donatella Berra (Carla Bonecchi).
Ricordo che è possibile abbonarsi a Nuova Resistenza Unita (Euro 11) o associarsi alla Casa della Resistenza (Euro 26, compresa la quota abbonamento) presso gli uffici di via Turati 9 a Verbania Fondotoce.
In alternativa con bonifico e mandando mail con copia della ricevuta e il proprio indirizzo postale a nuovaresistenzaunita@casadellaresistenza.it; il codice IBAN della Associazione Casa della Resistenza è: Banco Posta – IT19 Z076 0110 1000 0001 2919 288.
[i] Cfr. D. Gagliani, Brigate nere. Mussolini e la militarizzazione del Partito fascista repubblicano» (1999); L. Ganapini, La Repubblica delle camicie nere (1999) attento soprattutto alla articolazione del fascismo a livello locale; R. D’Angeli, Storia del Partito Fascista Repubblicano (2016) che sottolinea la centralità del PFR.
[ii] Storia dellaResistenza, p. XIVe p. 75.
[iii] Ivi, p. 298.
[iv] Ivi, p. 424-432.
[v] Ivi, p. 436-445.
[vi] Ivi, p. 436.
[vii] Storia della Repubblica Sociale, p. IX.
[viii] Ivi, p. 80.
[ix] Ivi, p. 102.
[x] Ivi, p. 179-183 passim.
[xi] Ivi, p. 315-316.
[xii] Ivi p. 409, 455-456 passim.
[xiii] Ivi, p. 468.
[xiv] Cfr. Storia della Resistenza p. 540-555.
[xv] Ivi, p XVI.

Il corso annuale 2020 per insegnanti organizzato dalla Casa della Resistenza era dedicato a “Fascismi e nuovi fascismi” e le lezioni dovevano tenersi presso l’Istituto Cobianchi di Verbania. Per le restrizioni che hanno poi portato al lockdown il corso si è interrotto dopo la prima lezione tenuta da Enzo R. Laforgia sulla scuola fascista e il Testo unico di stato (Come si diventa fascisti).
Il corso è stato riproposto quest’anno in modalità online e la prima lezione è stata tenuta da Angelo Vecchi (Senza rinnegare il passato. Storia e memoria nel neofascismo. 1946-1977). Il tempo trascorso mi ha permesso di integrare la mia lezione prevista per il secondo incontro (Dal fascismo repubblicano al neofascismo) con alcuni testi usciti nel frattempo (in particolare di Federico Finchelstein e Mimmo Franzinelli).
Dopo essermi raccordato alla prima lezione dell’anno precedente con esempi sulla scuola locale durante il fascismo ho poi dedicato sei slide preliminari al pubblico dibattito attuale sul fascismo per cercare di delimitarne il significato storico e politico. Riprendo in forma estesa questa parte del mio intervento.
Il dibattito sul fascismo si è arricchito recentemente di molti contributi storici, giornalistici ed anco letterari: sulla figura di Mussolini, sulle bugie che il fascismo veicolava su se stesso, sulle banalizzazioni e le “idiozie” che le ripropongono, sulle malefatte nascoste (affarismo, corruzione e mani sporche), sul perché in Italia non abbiamo fatto i conti con il fascismo e, parallelamente, sulla crisi che ha attraversato e attraversa l’antifascismo e in quali prospettive debba oggi porsi un antifascismo maturo e consapevole[a]. All’interno di questo dibattito più ampio mi soffermo sulle concezioni, alcune più ampie, altre più ristrette, di “fascismo”: quali e quanti sono stati a pieno titolo i fascismi e pertanto chi, propriamente, può esser definito fascista.
Siamo tutti (almeno un po’) fascisti: Michela Murgia
Il 21 agosto 2017 la scrittrice, blogger e polemista Michela Murgia pubblica sul suo profilo facebook un post dall’esplicito titolo «Piccolo discorso sul fascismo che siamo». Il post ha avuto ampia risonanza, con molti commenti e migliaia di condivisioni. Alcune delle sue affermazioni sono diventate vere e proprie parole d’ordine su siti e gruppi antifascisti presenti nei social network.
Questo l’inizio:
«A te che hai vent’anni e mi chiedi cos’è il fascismo, vorrei non doverti rispondere. Vorrei che nel 2017 la risposta a questa domanda la sapessimo già tutti, ma se me lo chiedi è perché non è così.
So perché me lo domandi. Credi che io sia intollerante se dico che il fascismo è reato e deve rimanerlo sempre. Credi che “se il fascismo e il comunismo hanno causato entrambi tanto dolore nel corso della storia devono essere considerati reato senza distinguo”.
È quindi colpa mia se me lo chiedi.”
Queste le affermazioni principali del “piccolo discorso”:
- Il fascismo non è un’ideologia, ma un metodo che può applicarsi a qualunque ideologia;
- non è il contrario del comunismo, ma della democrazia;
- il fascismo è un reato; come la mafia non è un’opinione politica;
- proprio come la mafia, non è né di destra né di sinistra;
- in democrazia il cosa ottieni non vale mai più del come lo hai ottenuto. Se i rapporti si invertono qualunque soggetto collettivo diventa un fascismo, persino il partito di sinistra, il gruppo parrocchiale, la bocciofila.
In conclusione “Nessuno è al sicuro, se non dentro allo sforzo di ricordarsi in ogni momento che cosa rischiamo tutti quando cominciamo a pensare che il fascismo è solo un’opinione tra le altre.”
L’anno successivo riprende la stessa tematica con un pamphlet dal titolo – e dal contenuto – provocatorio: “Istruzioni per diventare fascisti”[b]. Siccome la democrazia «è il metodo di governo peggiore», e«la sua alternativa più sperimentata – il fascismo – è un sistema di gestione dello Stato assai migliore» ci avvia con una sorta di manuale ad un’acquisizione completa dell’esser fascisti. E un test finale confermerà che in effetti (poco o tanto) lo siamo. Questo il percorso che dall’esser (più o meno convinti) democratici ci porta a diventare a pieno titolo fascisti:
- “Cominciare da capo”. Sostituiamo la parola leader (che discute e pertanto perde tempo) con capo che non è in discussione e non perde tempo.
- “Semplificare è troppo complicato”. In passato le opinioni critiche potevano esser messe sotto silenzio (repressione, carcere, confino) oggi con internet è più difficile; di fronte alla complessità la comprensione passa attraverso una semplificazione, operazione complicata e pericolosa che lascia spazio al dissenso, occorre allora banalizzare e i social sono uno strumento potente: qualsiasi opinione critica e dissidente può esser demolita con la banalizzazione.
- “Farsi dei nemici”. In democrazia il confronto è fra avversari, il fascismo deve crearsi dei nemici “perché il fascismo per porsi deve opporsi”.
- “Ovunque proteggi” contro ogni diversità interna ed esterna che suoni come minaccia: pressoché tutti “hanno qualcosa da perdere e se gli fai vedere che quel qualcosa è minacciato, si fideranno di chiunque si dimostri in grado di difenderlo”.
- “Nel dubbio mena”. In democrazia la parola è libera: che la tua parola sia violenta ed inciti alla azione.Il passaggio successivo è breve.
- “Voce di popolo”. Al popolo piace esser corteggiato. “Esaltare le qualità popolari è il primo passaggio per alimentare un genuino sentimento fascista nelle masse”.
- “Non ti scordar di me”. Più o meno tutti hanno nostalgia dei tempi passati e noi italiani abbiamo la fortuna di aver già vissuto il fascismo. E, se qualcuno ne ricorda gli orrori, sminuite, mettete in dubbio, negate, parlate d’altro (es. le foibe). Insomma occorre riscrivere la storia.
In una nota finale Murgia precisa che la sua non ha voluto esser una provocazione, un semplice gioco di inversione dei punti di vista perché
“Le cose che ho scritto, non tutte e non sempre, in qualche momento della mia esistenza, quelli più duri, superficiali, incazzati o ignoranti, anche solo per un istante le ho pensate, e credo che sia capitato a ciascuno di noi.”
In sostanza questo libello più che definire e denunciare il fascismo intende far capire quanto la democrazia sia oggi fragile e quanto il fascismo (inteso soprattutto come metodo antidemocratico) sia in grado di insinuarsi nella democrazia e corromperla dall’interno.
Nascono spontanee alcune osservazioni: è possibile ridurre il fascismo solo al metodo e affermare che non è (e non ha) una ideologia: una sorta di clava che può esser utilizzata da chiunque? E di conseguenza affermare che non è né di destra né di sinistra? È chiaro che, se così fosse, non avrebbe alcun senso ricostruire la storia politica del fascismo e del neofascismo: se l’oggetto di studio è (solo) un crimine il suo studio attiene unicamente alla storia criminale e alla cronaca nera.
La questione dirimente, come ho già sottolineato in un precedente post[c] che di seguito riprendo, attiene al quesito se in politica sia centrale e preminente la dicotomia destra/sinistra o quella fra autoritarismo e democrazia.
Una necessaria digressione: Sinistra e destra
Conviene richiamare il significato di destra e di sinistra non tanto quale collocazione lineare – spaziale delle forze politiche, ma nei contenuti caratterizzanti e nei valori di riferimento che i due concetti esprimono. Mi richiamo alla posizione di Norberto Bobbio che considera insuperabile la dicotomia e prioritaria rispetto al metodo.
“Nella contrapposizione fra estremismo e moderatismo viene in questione soprattutto il metodo, nell’antitesi fra destra e sinistra vengono in questione soprattutto i valori. Il contrasto rispetto ai valori è più forte che quello rispetto al metodo”. (Norberto Bobbio, Destra e sinistra, Donzelli 1994,p. 33)
L’antitesi fra destra e sinistra nel linguaggio politico risale ai tempi della Rivoluzione francese: durante la Costituente i favorevoli al diritto di veto incondizionato del Re sedevano a destra, i contrari a sinistra. Nella “topografia politica” questa dicotomia venne così a sostituire quella precedente di “alto e basso” dove destra subentrò all’alto (il potere tradizionale) e sinistra al basso (i molti senza potere). Molti studiosi ritengono che questo modo di rappresentare la dislocazione delle forze politiche non sia casuale ma fondata su tradizioni e archetipi profondi (es. quello religioso: “sedere alla destra del padre”; l’uso di “destro” “dritta”, “droit”, “right” per indicare la giusta diritta direzione, ma anche ordine, chiarezza). All’opposto “sinistra” e “sinistro” connotano minaccia, calamità, disordine, confusione.
Anche ricerche sociologiche svolte in più paesi indicano come la divisione sia percepita come fondamentale[d] nonostante la molteplicità voci che affermano “sia superata dai tempi”. Possiamo rappresentare questa dicotomia in una tabella di confronto fra i rispettivi valori e contenuti caratteristici[e]:
| Carattere fondante | Sinistra: Eguaglianza | Destra: Gerarchia |
Altre caratteristiche | Classi disagiate | Classi agiate |
| ” “ | Libero pensiero | Religiosità |
| ” ” | Discontinuità | Continuità |
| ” ” | Emancipazione | Difesa della tradizione |
| ” ” | Cosmopolitismo | Nazionalismo |
| ” ” | Pacifismo | Militarismo |
| ” ” | Logos (razionalità) | Mito e richiami irrazionali |
| Pensatore di riferimento | Rousseau: eguaglianza originaria dello Stato di natura che società e proprietà hanno corrotto | Nietzsche: diseguaglianza originaria che società e cristianesimo stravolgono con eguaglianza fittizia |
Va inoltre sottolineato come la dicotomia libertà/autoritarismo (come già ricordava Bobbio) non coincida con la dicotomia sinistra/destra: vi sono infatti destre democratiche come sinistre autoritarie e, naturalmente, viceversa.
Allo stesso modo, aggiungo, occorre sottolineare come vi siano ulteriori dimensioni della politica[f] che non coincidono con la polarità sinistra/destra e che la attraversano:
- individualità contrapposta a comunità[g]: vi è un individualismo di destra spesso coniugato al neoliberismo e uno radicale di sinistra promotore dei diritti delle differenze, così come il concetto di comunità può caratterizzarsi come chiusura identitaria basata su “sangue e suolo” come su uno spazio di condivisa ed egualitaria ricerca del bene comune;
- le attività economiche umane contrapposte alla difesa dell’ambiente: vi è infatti un ambientalismo di destra come di sinistra e sull’altro lato la difesa, spesso ad oltranza, del “progresso economico” può incontrare fautori su entrambi i lati dello schieramento politico.
- centralismo dello Stato contrapposto all’autonomismo dei territori: antitesi che ha attraversato anche la Resistenza dove a fianco del centralismo prevalente della Liberazione Nazionale propugnata dal CLN si è anche affiancato l’autonomismo federalistico elaborato dalla Carta di Chivasso; per venire ai nostri tempi dove un movimento come la Lega, chiaramente di destra, si sia caratterizzato originariamente come autonomistico (e talora anche separatista) per poi trasformarsi in un partito nazional-sovranista; oppure osservando come l’autonomismo e separatismo repubblicano catalano abbia una prevalenza di sinistra cui si contrappongono, oltre alla destra del Partito popolare e i movimenti esplicitamente nazionalisti e fascisti come gli eredi del falangismo franchista, anche – pur in maniera meno virulenta – il PSOE di Pedro Sánchez.
Ritornando alle perplessità relative alle affermazioni della Murgia, mi pare del tutto evidente, proprio a partire dalle caratterizzazioni che lei stessa attribuisce al fascismo (es. il ruolo centrale del Capo) e dalla accezione condivisa di destra e sinistra – che ho sopra cercato di sintetizzare – come questo, dal punto di vista sia storico che politico, sia indubbiamente un movimento politico di destra. Il che non vuol certo dire che tutta la destra sia fascista o che rappresentando una posizione politica il fascismo non possa essere anche un reato. Murgia stessa ci avverte (cfr. sopra) che, se da un lato è utile (anche se è non sempre facile) “semplificare”, quanto dall’altro sia invece pericoloso “banalizzare”.
Ci sono stati (e ci potranno ancora essere) più fascismi: Umberto Eco
Il 25 aprile del 1995 Umberto Eco, nel 50° della Liberazione, pronuncia davanti agli studenti della Columbia University un discorso in inglese sul fascismo e sui pericoli di un suo ritorno; pubblicato il 22 giugno successivo su “The New York Review of Books” verrà tradotto tre mesi dopo su «La Rivista dei libri» come «Totalitarismo fuzzy e Ur-Fascismo». Sarà poi pubblicato con il titolo «Il fascismo eterno» in «Cinque scritti morali» (1997) e recentemente riproposto isolatamente da La nave di Teseo (2018).
Nella prima parte del suo discorso, ricordato il ruolo dei soldati americani e di Roosevelt nella liberazione dei paesi europei dal nazifascismo, si sofferma sul rapporto fra il fascismo italiano e altri regimi e movimenti simili quali il nazismo, il falangismo e molti altri. Si sofferma in particolare sugli aspetti culturali e politici sottolineandone le differenze interne e le contraddizioni. In sintesi sottolinea che il fascismo italiano:
- Non aveva una ideologia monolitica (a differenza, ad esempio, del nazismo)
- Sul piano culturale e artistico al suo interno convivevano orientamenti diversi
- Sul piano politico ha potuto essere laico, anticlericale e cattolico tradizionalista, monarchico e repubblicano ecc.
- «Il fascismo fu certamente una dittatura, ma non era compiutamente totalitario»: la sua forma di dittatura può esser definita come un «Totalitarismo fuzzy» (sfumato, incerto).
Questi suoi confini incerti hanno fatto sì che il termine (a differenza dal nazismo, o dal falangismo) diventasse una sineddoche (pars pro toto) indicando regimi e movimenti che, pur differenti fra loro, mostrano una qualche «somiglianza di famiglia». È così possibile definire l’Ur-Fascismo (primigenio, persistente, eterno, ricorrente) indicandone una serie di caratteristiche che non compaiono mai tutte insieme ma la presenza di una o più di queste ci avvertono che siamo di fronte ad una delle tante forme di “fascismo ricorrente”: infatti «è sufficiente che una di loro sia presente per far coagulare una nebulosa fascista».
| Caratteristiche dell’Ur-Fascismo | |
| 1. Culto della tradizione: la verità è originaria, rivelata una volta per tutte, va semmai riscoperta e “coltivata”; non ci può essere avanzamento del sapere. | 2. Rifiuto del modernismo: l’Illuminismo, l’età della ragione, è visto come l’inizio della depravazione moderna (irrazionalismo). |
| 3. Culto dell’azione per l’azione: l’azione è bella di per sé mentre pensare è una forma di evirazione. La cultura è sospetta perché introduce elementi critici. | 4. Rifiuto dello spirito critico: per la cultura scientifica il disaccordo è strumento di avanzamento del sapere; per l’Ur-Fascismo è invece tradimento. |
| 5. Paura della differenza: l’Ur-Fascismo cerca il consenso esacerbando la naturale paura della diversità; è dunque razzistaper definizione. | 6. Appello alle classi medie frustrate: le crisi economiche e politiche producono disagio e incertezza che rendono questi ceti un possibile uditorio. |
| 7. Nazionalismo e xenofobia: per i ceti privi di identità sociale la “Nazione”, vittima di complotti esterni o interni (gli ebrei), ne fornisce il sostituto. | 8. Nemici ricchi e forti ma deboli nel contempo: con spostamento retorico disprezzati per ricchezza e potenza, ma destinati anche alla sconfitta. |
| 9. La vita è guerra permanente: non lotta per la vita ma “vita per la lotta”. Il pacifismo è collusione col nemico. Vi sarà una soluzione finale (Armageddon) | 10. Disprezzo per i deboli: elitismo popolare. Ogni cittadino appartiene al popolo migliore e i membri del partito sono i cittadini migliori. |
| 11. Ciascuno sia educato da eroe. Il culto dell’eroismoè strettamente legato alculto della morte quale migliore ricompensa di una vita eroica. | 12. Machismo: disprezzo per le donne e condanna per sessualità non conformista (omosessualità, castità). Le armi rappresentano un Ersatz (sostituto) fallico. |
| 13. Populismo qualitativo: la “voce del popolo” non si esprime in modo quantitativo (parlamentarismo) ma in una “volontà comune” che il “leader” sa esprimere. | 14. L’Ur-Fascismo parla la “neolingua”: basata su un lessico povero (e stravolto) ed una sintassi elementare volti a limitare il pensiero complesso e critico. |
Eco conclude la il suo discorso sottolineando come il fascismo possa ritornare anche se sotto forme non immediatamente riconoscibili:
«L’Ur-fascismo è ancora intorno a noi, talvolta in abiti civili … L’Ur-fascismo può ancora tornare sotto le spoglie più innocenti. Il nostro dovere è di smascherarlo e di puntare l’indice su ognuna delle sue nuove forme – ogni giorno, in ogni parte del mondo.»
Al netto della indubbia efficacia e ricchezza del contributo di Umberto Eco, non bisogna dimenticare che si trattava di un discorso destinato ad un pubblico specifico e non di una approfondita analisi storica e, proprio per questo, non mancano a mio parere alcuni aspetti problematici che provo di seguito a riassumere.
Innanzitutto è ancora oggi sostenibile che il fascismo italiano nel ventennio fosse sì autoritario ma non compiutamente totalitario e fosse privo di una propria ideologia definita? Parecchi studi, recenti e meno recenti, sostengono il contrario, a partire dal ruolo della scuola uniformata a un modello preciso con il Testo Unico di Stato, per non parlare degli strumenti coercitivi del regime contro ogni forma benché minima di dissidenza.
Analogamente non mi pare convincente la sottolineatura di Eco sulla diversità fra fascismo e nazismo: da questo punto di vista condivido la posizione dello storico tedesco Hans Woller[h] che parla di Mussolini come “il primo fascista” a cuoi Hitler si è ispirato; certo successivamente, per i reciproci rapporti di forza, le relazioni fra loro si sono in qualche modo rovesciate, influenzando il nazismo a sua volta il fascismo: una sorta di reciproca “sincronizzazione” di due totalitarismi non solo alleati ma sostanzialmente omogenei.
Ed infine “eternità” significa che c’è stato «fascismo prima del fascismo»? L’Ur-fascismo è un “fascismo eterno” o, sottolineando la specificità del termine tedesco (Ur)[i], un “modello”, una sorta di raffigurazione generale o, se vogliamo, un “prototipo” a cui il fascismo italiano ha dato vita e a cui i diversi fascismi si rapportano? Non mi pare che le due espressioni siano equivalenti.
Vi è stato un solo fascismo, quello del regime: Emilio Gentile
Emilio Gentile, storico, allievo di De Felice e sostenitore del fascismo italiano come «Modernità totalitaria»[j] nell’aprile 2019 pubblica «Chi è Fascista»[k], una «pseudo-intervista» nella quale, intervistando se stesso, interviene nel dibattito pubblico sul fascismo polemizzando in particolare con “il fascismo eterno” di Eco e con chi lo ripropone oggi. Non prende in realtà in considerazione la prima parte del discorso di Umberto Eco e in particolare la concezione del fascismo come un “Totalitarismo fuzzy”. La critica a Eco di Gentile si sofferma soprattutto sulla sua concezione di un “fascismo eterno”.
“Introdurre l’eternità nella storia umana, attribuire l’eternità a un fenomeno storico, sia pure con le migliori intenzioni, comporta una grave distorsione della conoscenza storica. … La pratica dell’analogia è molto diffusa nelle attuali denunce sul ritorno del fascismo, con un uso pubblico della storia in cui prevale la tendenza a sostituire alla storiografia – una conoscenza critica scientificamente elaborata – una sorta di “astoriologia”, come possiamo chiamarla, dove il passato storico viene continuamente adattato ai desideri, alle speranze, alle paure attuali.
Non ho ben compreso quando hai detto che la storia viene sostituita dalla “astoriologia”. Forse intendevi dire “astrologia”?
No, ho detto proprio astoriologia. Ho ritenuto opportuno coniare questo neologismo per definire un nuovo genere di narrazione storica, fortemente mescolata con l’immaginazione, che ha con la storia la stessa relazione che l’astrologia ha con l’astronomia. Col metodo dell’astoriologia, come avviene nell’astrologia, avvalendosi di una visione della storia come storia-che-mai-si-ripete-ma-sempre-ritorna-in-altre-forme, è facile scoprire analogie che dimostrano l’esistenza di un “fascismo eterno”, e fare pronostici sul suo periodico ritorno. Ma le analogie della astoriologia sono inconsistenti quanto le analogie dell’astrologia.”[l]
Gentile si sofferma poi sulle caratteristiche peculiari del fascismo italiano che, sostiene, è nato nel 1921 e non nel 1919 coi Fasci di combattimento,per cui il considerare il 2019 come centenario della nascita del fascismo rappresenterebbe, dal suo punto di vista, un falso storico. In sostanza identifica il fascismo con il “regime” di cui fornisce, nell’ultimo capitolo una «mappa storica».
Considera infine del “neofascismo” solo quello istituzionale rappresentato storicamente Movimento Sociale Italiano e da Alleanza Nazionale, “neofascismo” che si conclude, ed estingue con la sua confluenza nel Popolo delle Libertà (2009). Non prende in alcun modo in considerazione la galassia del neofascismo radicale ed extraparlamentare ed afferma che nessun partito attuale può esser definito “fascista” e non c’è alcun pericolo di un ritorno del fascismo.
L’antifascismo ha debellato il fascismo nel 1945 per cui entrambi (fascismo e antifascismo) appartengono al passato, “ma con una sostanziale differenza”: mentre il fascismo “è definitivamente debellato”, l’antifascismo, con l’unità di tutti i partiti della Resistenza, ci ha lasciato una “eredità vitale”, lo Stato repubblicano e la sua Costituzione.[m]
| Mappa storica del fascismo | |
| Dimensione organizzativa | Partito milizia. Movimento di massa (specie ceti medi) in stato di guerra contro gli avversari; usa ogni mezzo per creare un nuovo regime |
| Dimensione culturale | Pensiero mitico. Senso tragico e attivistico della vita. Mito della giovinezza: artefice di storia |
| Ideologia anti-teorica e pragmatica, espressa esteticamente con i miti e i simboli di una religione laica volta all’integrazione fideistica delle masse: creazione di un “uomo nuovo” | |
| Primato politica: comunità-nazione come unità organica; persecuzione di chi non si identifica | |
| Etica civile. Subordinazione totale del cittadino allo Stato: disciplina, virilità, spirito guerriero | |
| Dimensione istituzionale | Apparato di polizia: previene, controlla, reprime (terrore organizzato) dissenso e opposizione |
| Partito unico. Difesa armata regime (aristocrazia al comando) e mobilitazione delle masse | |
| Sistema politico: simbiosi fra regime e Stato ordinato in una gerarchia dominata dal “capo” | |
| Economa: organizzazione corporativa, soppressione libertà sindacale, collaborazione dei ceti produttivi sotto il controllo del regime, mantenendo proprietà privata e divisione in classi | |
| Politica estera: espansione imperialista e creazione di una nuova civiltà mondiale |
Non sono pochi gli aspetti problematici della posizione di Emilio Gentile. In primo luogo cristallizza il fascismo in un modello unico, quello italiano del regime, che in tal modo diventa irripetibile; ed anche in questa “modellizzazione” molti aspetti del fascismo italiano – quali le tendenze conservatrici, reazionarie e talora clericali – vengono sottaciuti. Anche la sua visione è in qualche modo “astorica” in quanto non valuta come i movimenti politici – e il fascismo nel caso specifico – si trasformino nel tempo. Non a caso fa decorrere il fascismo dal 1921: restringendo l’arco temporale il “modello” (la “mappa”) diventa più omogenea al suo interno e di conseguenza irripetibile.
In questo modo i regimi e i movimenti esplicitamente fascisti diffusisi in Europa e – come vedremo – nel resto del mondo, non vengono in alcun modo presi in considerazione. Allo stesso modo ignora l’esistenza e il pericolo dei movimenti radicali neofascisti e neonazisti.
Ed infine, siccome il fascismo storico (l’unico esistito) è stato sconfitto nel 1945 e i suoi epigoni nostalgici si sono dissolti nel 2009, per Gentile oggi l’antifascismo non avrebbe più ragione di esistere.
I molteplici fascismi diffusosi tra le due guerre mondiali in ogni parte del mondo hanno padri ed eredi: Federico Finchelstein
Federico Finchelstein[n] è uno storico di nazionalità argentina, docente di storia negli Stati Uniti. Studioso della storia politica dell’America latina, dei fascismi nel nord e sud del mondo (fascismo transatlantico/transnazionale) e dei loro rapporti con il populismo. Di recente l’editore Donzelli ha pubblicato la traduzione di due suoi importanti saggi che “entrano” a pieno titolo nel pubblico dibattito sul fascismo: Dai fascismi ai populismi[o] e Breve storia delle bugie dei fascismi[p].
Secondo Finchelstein per conoscere cosa è stato e cosa è il fascismo serve una analisi storica (diacronica) e globale (transnazionale) che lui effettua sia sulla base delle sue conoscenze sulla storia latinoamericana e del fascismo, che attraverso una ampia rassegna della storiografia, in particolare extra-europea. Cita al proposito lo storico indiano Benjamin Zachariah:
“la ricerca sul fascismo tende a ignorare la letteratura extra-europea per motivi di imbarazzo, di specializzazione professionale o di (in)competenza, oppure perché la considera come un elemento secondario nella storia delle idee fasciste”[q]
Il fascismo nacque in Italia nel 1919, manel periodo fra le due guerre mondiali la politica violenta, antidemocratica e razzista che il movimento italiano rappresentava “fece la sua comparsa simultaneamente in tutto il mondo”: non solo in Europa (falangismo, salazarismo, nazismo, ustascia, ecc.), ma in America latina (nacionalismo in Argentina, integralismo in Brasile, leopardos in Colombia …), in India, in Cina, in Giappone, in Africa, nei paesi islamici …
“Il fascismo era transnazionale ancor prima che Mussolini chiamasse così il proprio movimento ma quando diventò un regime, nell’Italia del 1922, il termine «fascismo» ricevette un’attenzione su scala mondiale, e acquisì significati diversi nei vari contesti locali. Ciò non significa che le influenze italiane (o francesi, o più tardi tedesche) non fossero importanti per i fascisti transnazionali. Ma solo in alcuni casi ci si limitò a una semplice imitazione. I fascisti transnazionali rimodellarono l’ideologia fascista per adattarla alle proprie specifiche tradizioni nazionali e politiche. […] Il fascismo assunse diverse colorazioni, connesse a differenti significati. Come osserva lo storico del fascismo giapponese Reto Hoffmann, i movimenti fascisti «indossavano un arcobaleno di camicie» – color acciaio in Siria, verde in Egitto, blu in Cina, arancione in Sud Africa, oro in Messico – e queste varianti dicono molto sugli specifici adattamenti nazionali di quella che chiaramente era un’ideologia globale. A questa connessione fra ideologia e vestiario si potrebbe aggiungere il classico bruno in Germania e, ovviamente, il nero in Italia, l’azzurro in Portogallo e in Irlanda, il verde in Brasile. Ispirandosi a un rifiuto globale dei valori democratici universali, il fascismo mostrava una tavolozza ideologica chiaramente collocata all’estrema destra dello spettro politico.”[r]
Il fascismo “transnazionale” nelle sue diverse espressioni, non nasce nel vuoto ma in quello che potremmo chiamare “lo spirito dei tempi”: alle sue origini troviamo innanzitutto la tradizione del pensiero irrazionalistico ed anti-illuminista che ha impregnato movimenti reazionari e/o populisti già dalla fine dell’Ottocento e, fattore dirompente, l’esperienza violenta della prima guerra mondiale, “l’avvento di una nuova epoca di guerra totale. L’ideologia fascista emerse infatti per la prima volta nelle trincee della prima guerra mondiale. … Questo ideale guerresco, e il connesso concetto di militarizzazione della politica, trascesero i confini europei e si diffusero anche in paesi lontani e diversi come l’India, l’Iraq e il Perù”.[s]
Il fascismo si presenta così come risposta “moderna” alla crisi della democrazia e del capitalismo: una “modernizzazione reazionaria” antiliberale e antisocialista, il «lato oscuro della modernità». Le sue caratteristiche ricorrenti si possono così riassumere:
- Abbandono del pensiero politico reazionario assolutistico (il potere dall’alto) a cui si sostituisce una concezione rivoluzionaria della sovranità popolare non basata sulla rappresentanza democratica ma sulla delega e sulla identificazione del popolo con il Capo. Ritroviamo ovunque questa triade: il Capo espressione diretta della “volontà del popolo”, i suoi diretti seguaci (il partito-milizia) e il popolo-nazione.
- Il popolo-nazione non è concepito come una realtà sociale differenziata al suo interno (come «demos») ma etnicamente come realtà nazionale omogenea (come «ethnos»); di conseguenza chi non è identificabile (o non si identifica) con il popolo nazione non ne fa parte, è nemico o “anti-popolo”. Il razzismo è componente intrinseca di tutti i fascismi.
- Centralità ed esaltazione della violenza sia come mezzo per realizzare le proprie finalità – distruggere la democrazia per realizzare uno Stato totalitario[t], opprimere e sopprimere i nemici sia interni (l’antipopolo) che esterni (nazionalismo e colonialismo) – che come fine: la sua è una funzione sacrale e rigeneratrice che va coltivata in quanto tale.
- La politica non è concepita come «ratio» ma come soggettività estetica: il fascismo, attraverso il mito, i simboli e il rito pubblico che rivitalizzano la tradizione e l’identità di un popolo, diventa qualcosa che «si vede» e viene vissuto.
“… la prassi del fascismo non si collegava a una politica della quotidianità o a un’estetica mondana, concentrandosi piuttosto su una serie di rituali e spettacoli politici il cui scopo era oggettivare la politica fascista e assicurarle un fondamento nelle esperienze vissute. Queste prassi presentavano il fascismo come qualcosa che poteva essere visto, e implicavano la partecipazione diretta e il contatto con gli altri, trasformando le idee in realtà vissuta.”[u]
- La qualità deve sostituire la quantità: questo vale per la rappresentanza del popolo che non deve essere meramente “quantitativa” (la “maggioranza numerica”) ma “qualitativa”, espressione profonda delle esigenze di un popolo che solo il Capo e il suo partito sanno esprimere. Lo stesso vale per la modernità superando l’economicismo meccanico e quantitativo del liberalismo.
“I fascisti volevano sostituire una modernità ritenuta meccanica, ripetitiva e inconsapevole con una modernità «qualificata» in cui il fascista potesse domare la materia e l’economia. I fascisti concepivano la loro modernità nei termini di un «dominio dello spirito e del politico», ponendo al centro delle loro preoccupazioni un’«etica della guerra» e un violento senso virile e comunitario.”[v]
- La verità non si determina empiricamente ma è espressa dal Capo e non può esser messa in discussione; la stampa deve assoggettarsi alle verità “di regime” e i nuovi mass media (radio e cinema) diventano il veicolo delle «menzogne ideologiche».
“…. Il fascismo produceva una «verità» che era nazionalistica e allo stesso tempo assoluta. Privata di connotazioni plurali, essa escludeva qualsiasi forma di dissenso, e diventava l’esito esclusivo di rapporti di potere gerarchici. Contestando le tradizionali definizioni della verità, i fascisti insistevano sul significato nascosto della verità stessa, che per loro era un segreto rivelato nel potere e tramite esso. (…)
Di conseguenza, la politica fascista aveva un carattere mitologico. Nel fascismo, la forma suprema di verità non richiedeva conferme empiriche: semmai, emanava da un’affermazione di tipo intuitivo di concetti ritenuti espressione di miti metastorici, che il capo incarnava. Questa dissociazione fra analisi politica e realtà fu uno sviluppo fatale, un esito della ricerca fascista di una forma suprema di autenticità politica che potesse trascendere la ragione. In questo senso, i fascisti non solo mentivano, ma ingannavano se stessi, cadendo, come rilevò Adorno nel 1951, sotto l’«incantesimo» della «falsità».”[w]
Che rapporto c’è tra fascismo e populismo?
Secondo Finchelstein è pressoché impossibile dare una “definizione” di populismo, perché indica una serie di movimenti molto diversi fra loro e che nel tempo hanno subito notevoli trasformazioni e oscillazioni, in alcuni casi anche fra destra e sinistra. L’elemento di connessione con il fascismo riguarda in particolare il rapporto fra popolo e capo che ne rappresenta simbioticamente la volontà: “il leader è non solo la voce del popolo ma anche un individuo dai tratti messianici e illuminato, predestinato a incarnare il potere”. Per approfondire il fenomeno è più opportuno “un approccio che permetta una comprensione in termini storici di ciò che il populismo ha rappresentato nel corso del tempo”. Prescindendo dai precursori a cavallo fra Ottocento e inizio Novecento, Finchelstein individua due modelli
- Dopo la sconfitta nel 1945 del nazifascismo il populismo, particolarmente in America latina, accetta la democrazia, pur interpretata in modo autoritario, e rifiuta la violenza sia come metodo di conquista del potere sia come valore in sé. In alcuni casi, come nel peronismo argentino, diede vita anche a movimenti orientati a sinistra.
“Innanzi tutto, il populismo è una concezione autoritaria della democrazia, che dopo il 1945 ha riformulato l’eredità del fascismo per associarlo a diverse procedure democratiche. È per questo motivo che costituisce una forma di post-fascismo, che procede a una rielaborazione del fascismo per adattarlo a un’epoca democratica.
Ciò significa che il populismo non è il fascismo. Il fascismo è stato storicamente contestualizzato soprattutto come una forma di dittatura politica, che spesso emerge di fatto all’interno della democrazia con l’intento di distruggerla. Storicamente, il populismo ha fatto il contrario. Spesso è scaturito da altre esperienze autoritarie, comprese le dittature, e nella maggior parte dei casi ha alterato o distorto i sistemi democratici, sminuendone le qualità, ma senza mai, o quasi mai, arrivare al punto di distruggerli.”[x]
- Dopo il crollo dell’URSS e nei tempi più recenti si assiste ad un riavvicinamento del populismo al fascismo; in particolare viene ripresa la concezione del popolo come «ethnos» e di conseguenza il razzismo che inevitabilmente porta anche alla violenza.
“ … i primi populismi … cercarono di allontanarsi dall’«eredità fascista», mentre «nei populismi di oggi, più recenti, di estrema destra, invece, vediamo l’affermazione dell’idea contraria, ossia l’utilizzo di xenofobia e razzismo per connettere il popolo con il potere, come dimostra chiaramente, fra gli altri, il caso di Donald Trump. Pertanto questi populismi attuali, non dico che si siano riconvertiti in fascismo, ma si avvicinano al fascismo, riprendono alcuni temi forti del fascismo … Se si guarda al fenomeno in senso ampio, ci troviamo di fronte ad una storia del populismo che, in un primo momento, si allontana dal fascismo, riformulandolo in chiave democratica … e, in un secondo momento, oggi, per la precisione, dimostra di voler tornare a quel fascismo.”[y]
Un inciso nostrano: la fiamma mussoliniana
I simboli hanno un grande significato in politica perché permettono ad una collettività di identificarsi; questo vale in particolare per i fascismi dove, come ricorda Finchelstein, l’elemento mitico e simbolico prevale su quello razionale e programmatico. Limitandoci al contesto italiano i movimenti neo-fascisti e neo-nazisti, per motivi evidenti, utilizzano solo in privato e/o singolarmente la simbologia ufficiale di riferimento: fascio e svastica. Vi è comunque tutta gamma di simboli nordici o presunti tali (ed es. l’ascia bipenne[z]), pagani, runici oppure la croce celtica che, introdotta nella simbologia della destra francese dal collaborazionista filonazista Jacques Doriot, fu rilanciata in Italia negli anni ’60 e ’70 da movimenti neofascisti collaterali al Movimento Sociale[aa].
Ma veniamo a quello che è il simbolo tradizionale del neofascismo italiano per così dire “istituzionale”: la cosiddetta “fiamma tricolore”.
Nel 1945, dopo la Liberazione e la sconfitta della Repubblica Sociale buona parte dei quadri del Partito Fascista Repubblicano si danno alla clandestinità e un certo numero trova rifugio a Roma; Pino Romualdi, già vice segretario del PFR, dà vita ad una struttura ufficiosa di coordinamento denominata “Senato” e in vista del Referendum istituzionale(2.06.46) tratta sia con i monarchici (Umberto II) sia con i rappresentanti dei partiti repubblicani garantendo ad entrambi neutralità e rispetto del risultato in cambio di una successiva concessione dell’amnistia che sarà poi emanata il successivo 22 giugno dal Ministro di Grazia e Giustizia Palmiro Togliatti[bb].
Può così costituirsi ufficialmente il Movimento Sociale Italiano (12.11.1946) su iniziativa di Pino Romualdi, Giacinto Trevisonno,Giorgio Almirante Arturo Michelini e altri.
Il suo simbolo venne forgiato da Giorgio Almirante e nel suo significato ufficiale era costituito dall’acronimo incorniciato del neonato Movimento Sociale Italiano da cui si ergeva una fiamma tricolore richiamante – in realtà abbastanza vagamente – l’emblema degli Arditi della Prima guerra mondiale: un richiamo patriottico e una scelta stilistica (ad es. i caratteri delle lettere) che solo vagamente richiamava l’epoca del ventennio e le sue origini.
Se questo era il suo significato ufficiale, ve ne era uno “nascosto”, in realtà ben noto sia all’interno che all’esterno del partito neofascista. L’acronimo, inserito in quella sorta di catafalco, a ben vedere non è tale in quanto l’ultima lettera, la “I”, non è seguita, come le due precedenti, dal punto di abbreviazione; non si tratta di un refuso – così rimarrà sino alla fine del MSI – ma dell’indicazione che non di una lettera inziale trattasi, ma appunto di una lettera finale; a quel punto non ci vuol molto a leggere le tre lettere come una abbreviazione di “MusSolinI e interpretare la fiamma che sorge dal sarcofago del duce come il suo spirito eterno a cui si rinnova fedeltà.
La fiamma tricolore rimarrà infatti quale simbolo delle successive formazioni neofasciste: Alleanza Nazionale, Movimento Sociale Fiamma Tricolore e da ultimo l’attuale Fratelli d’Italia.
Alcune brevi osservazioni
Richiamavo all’inizio la necessità di un antifascismo maturo ovvero che sappia riprendere finalità e valori della Resistenza per coniugarli nel mondo odierno, il che richiede una corretta ed aggiornata e non riduttiva lettura della Resistenza e nel contempo la consapevolezza di quanto il fascismo abbia inciso in profondità, nazionalmente e internazionalmente, dalla prima alla seconda guerra mondiale e di quanto i suoi epigoni siano diffusi e ricorrenti. Limitarsi a visioni riduttive oppure utilizzare i termini (storici, politici, sociali) in forma puramente connotativa quali sorta di etichette da affibbiare a ciò che “mi piace” o “non mi piace” non solo è fuorviante ma limita la nostra “capacità di presa” sulla realtà.
Riflettere sulla denotazione, sul significato storico di ciò che il fascismo è stato – senza però cristallizzarlo ad un modello storicamente dato, in quanto i movimenti politici come le ideologie e i movimenti culturali si trasformano nel tempo e nei diversi contesti – non solo ci permette di “ri-conoscerlo” ma soprattutto di affrontare intellettualmente e politicamente i suoi epigoni e le sue, non sempre facili da riconoscere, modalità attuali di manifestarsi.
Evitando forme riduttive e talora fuorvianti. Ne cito una per farmi capire.
«Il fascismo non è una opinione ma un reato» oppure «… non è una idea ma un reato», sorta di slogan che non solo nasconde una fallacia (ciò che è opinione/idea non è reato – ciò che è reato non è una idea/opinione), ma implica una sorta di disarmo intellettuale. È come affermare che non serve una battaglia culturale e ideale contro il fascismo, ma è sufficiente richiamare la magistratura al suo dovere. Il fatto che, sulla base della nostra Costituzione e legislazione, il fascismo sia un reato, non ci esime da una battaglia culturale, ideale e politica.
E ritorno all’inizio di questo dibattito, a quel «fascismo che siamo» da cui eravamo partiti. Fuorviante non solo nel considerare il fascismo solo come “metodo” ma anche nell’intendere quel “siamo” individualmente come “ognuno di noi”: ovvero, questa era la conclusione, siamo tutti – oggi come oggi – (almeno un po’) fascisti.
Io proporrei un «fascismo che siamo» intendendolo collettivamente: il fascismo che siamo come collettività nazionale non solo perché l’Italia è stata fascista ma soprattutto perché non ha mai (non abbiamo mai) veramente fatto i conti con il fascismo. Se in Germania una riflessione dapprima filosofica a partire da Karl Jaspers[cc] e poi politica sulla “colpa tedesca” si è progressivamente imposta, da noi né sul piano della riflessione etica e filosofica né politica i “conti” non sono mai stati fatti.
Un esempio e un auspicio: a Berlino nella ex sede della Gestapo è collocata la “Topographie des Terrors” sui crimini compiuti in Germania e all’estero dal nazismo e dalla Wehrmacht. Quando anche da noi vi sarà una analoga “Topografia del terrore” sui crimini del fascismo e dell’esercito italiano compiuti nelle colonie, nella ex Jugoslavia[dd] e in altri paesi europei, allora potremmo dire che del “fascismo che siamo” abbiamo cominciato a rielaborarne concretamente la colpa. Per il momento siamo molto “bravi” a denunciare i crimini altrui nascondendo sotto lo slogan “italiani brava gente” le nostre colpe nazionali per cui nell’immaginario collettivo la nostra presenza militare ad esempio nei Balcani è più legata a un film quale Mediterraneo che a quanto la ricerca storica ha e sta documentando.
Bibliografia
Bobbio Norberto, Destra e sinistra. Ragioni e significati di una distinzione politica, Donzelli, Roma 1994
Canali Mauro – Volpini Clemente, Mussolini e i ladri di regime. Gli arricchimenti illeciti del fascismo, Mondadori, Milano 2019
Colombini Chiara, Anche i partigiani però …, Laterza, Roma-Bari 2021
Consonni Manuela, L’eclisse dell’antifascismo, Laterza, Roma-Bari 2015
Eco Umberto, Il fascismo eterno, La nave di Teseo, Milano 2017
Filippi Francesco, Mussolini ha fatto anche cose buone. Le idiozie che continuano a circolare sul fascismo, Bollati Boringhieri, Torino 2019
Filippi Francesco, Ma perché siamo ancora fascisti? Un conto rimasto aperto, Bollati Boringhieri, Torino 2020
Finchelstein Federico, Dai fascismi ai populismi. Storia, politica e demagogia nel mondo attuale, Donzelli, Roma 2019
Finchelstein Federico, Breve storia delle bugie dei fascismi, Donzelli, Roma 2020
Gentile Emilio, Chi è fascista, Laterza, Roma-Bari 2019
Giovannini Paolo – Palla Marco (a cura), Il fascismo dalle mani sporche. Dittatura, corruzione, affarismo, Laterza, Roma-Bari 2019
Gobetti Eric, E allora le foibe?, Laterza, Roma-Bari 2020
Greppi Carlo, L’antifascismo non serve più a niente, Laterza, Roma-Bari 2020
Luzzatto Sergio, La crisi dell’antifascismo, Einaudi, Torino 2004
Murgia Michela, Istruzioni per diventare fascisti, Einaudi, Torino 2018
[a] Su queste tematiche cfr. la bibliografia posta in calce.
[b] Einaudi, Torino 2018, pp. 97.
[c] A Zurigo un intervento su “Fascismo ieri e oggi” (25 ottobre 2017)
[d] J.A. Laponce, Left and Right. The Topography of Political Perception, University of Toronto, 1981.
[e] Ho ripreso e rielaborato da “L’opposizione destra-sinistra. Riflessioni analitiche” di Anna Elisabetta Galeotti in Franco Ferraresi (a cura), La destra radicale, Feltrinelli, Milano 1984, pp. 253-275.
[f] Ho sviluppato questa tematica in un post del 2013: Nuove dimensioni per la politica?
[g] Cfr. due mie precedenti contributi: Il bisogno di comunità e L’orizzonte della comunità ai tempi di Internet.
[h] Hans Woller, Mussolini, il primo fascista, Carocci, Roma 2018.
[i] Cfr. i termini Urbild [prototipo] e Urdeutsch [tipicamente tedesco].
[j] Cfr. EmilioGentile (a cura), Modernità totalitaria. Il fascismo italiano, Laterza, Roma-Bari 2008.
[k] Laterza, Bari-Roma 2019.
[l] Ivi, p. 6-7.
[m] Ivi, p. 125.
[n] Informazioni su di lui anche sul sito dell’editore Donzelli (qui) e naturalmente su Wikipedia edizione inglese (qui la versione italiana del traduttore automatico).
[o] Dai fascismi ai populismi. Storia, politica e demagogia nel mondo attuale, Donzelli, Roma 2019.
[p] Breve storia delle bugie dei fascismi, Donzelli, Roma 2020.
[q] Dai fascismi ecc. cit., p. 85.
[r] Ivi, p.46-48.
[s] Ivi, p. 60.
[t] Totalitario (e totalitarismo) comporta abitualmente una valutazione e accezione negativa: Mussolini invece “se ne appropriò, trasformandolo da aggettivo politico di segno negativo a concetto (positivo) dotato di una propria pregnanza simbolica” (ivi. P. 70).
[u] Ivi, p. 66.
[v] Ivi, p. 104.
[w] Breve storia delle bugie cit., p. 48.
[x] Dai fascismi ecc. cit., p. 17.
[y] Fondazione Giangiacomo Feltrinelli: Fascismo e populismo. Conversazione con Federico Finchelstein.
[z] L’ascia bipenne o labrys, spesso ritenuta norrena ma in realtà di origine cretese, fu adottata come simbolo da Ordine Nuovo e altri movimenti neofascisti /neonazisti (es. M.P.N. Movimento patria nostra).
[aa] In particolare fu il simbolo ufficiale del primo Campo Hobbit (maggio 1977); nel secondo campo (giugno 1978) più direttamente controllato dalla direzione del Movimento Sociale, per decisione di Almirante, il simbolo venne vietato; ricomparve nel terzo campo (luglio 1980) per iniziativa dei dissidenti di Terza Posizione; i due leader di quest’ultimo movimento, Roberto Fiore e Gabriele Adinolfi, saranno successivamente protagonisti rispettivamente di Forza Nuova e Casa Pound.
[bb] L’amnistia Togliatti troverà una ulteriore espansione il 7.02.48 con la «Legge di clemenza» (Andreotti) che reintegrava in toto il personale amministrativo del fascismo.
[cc] Cfr. Karl Jaspers, La questione della colpa. Sulla responsabilità politica della Germania, Cortina, Milano 1996.
[dd] Sui crimini italiani nella ex Jugoslavia qualcosa si sta effettivamente muovendo, grazie al lavoro di alcuni giovani storici come Eric Gobetti e all’Appello per un riconoscimento ufficiale dei crimini fascisti durante l’invasione della Jugoslavia da parte dell’esercito italiano lanciato dall’Istituto nazionale Ferruccio Parri.

La ricca personalità di Gino Vermicelli è nota in molte sfaccettature della sua attività e dei suoi scritti: il giovane migrato in Francia e militante del PCF, il partigiano “Edoardo” commissario politico in Ossola nella II Divisione garibaldina Redi, dirigente politico nel dopoguerra del Fronte della gioventù e di seguito del PCI ad Agrigento e Novara; dirigente sindacale a Verbania. Dagli anni sessanta organizzatore del movimento cooperativo novarese. Collaboratore di numerose testate nazionali e locali e, dal 1969, cofondatore del gruppo politico-editoriale de Il manifesto; autore del più bel romanzo sulla resistenza ossolana, Viva Babeuf! Ed inoltre pacifista (Assopace), antimilitarista (Proletari in divisa), e naturalmente molto altro, non dimenticando – come ha voluto rimarcare in calce al suo romanzo – l’apicoltore o, come ha ricordato nella autobiografia postuma, l’albergatore a Rimini[1].
Di Vermicelli cultore e divulgatore di temi ecologici si è invece parlato poco. Eppure due dei suoi primi contributi sul quotidiano Il manifesto[2] affrontano proprio questi temi: i limiti dello sviluppo messi in evidenza dal rapporto del MIT- Club di Roma (1972) e il ritardo della politica italiana – e della sinistra in specie – ad affrontare queste tematiche; anche uno dei suoi ultimi scritti[3] riprende questi temi.
Ma è nella sua produzione novellistica che il narratore Vermicelli soprattutto esprime questa sua sensibilità. Si tratta di nove “favole ecologiche” – pubblicate in parte sulla rivista letteraria stresiana Microprovincia[4] e in parte postume[5] – che in modo indiretto, con il linguaggio leggero della favolistica, l’assunzione di punti di vista immaginari e molta ironia, affrontano i temi del degrado ambientale, della follia dello sviluppo incontrollato e “insostenibile”, del difficile equilibrio fra attività umane, tecnologia ed ambiente. Il messaggio implicito è che, se vogliamo davvero ricostruire un equilibrio ecologicamente sostenibile, oltre a progetti e studi approfonditi e politiche che se ne facciano carico, è necessaria una educazione che parta dai primi anni di età: favole ecologiche rivolte ai bambini ma molto utili anche per gli adulti. Le due che seguono[6], scritte tra il 1985 e il 1986 – le ultime ad esser pubblicate – assumono rispettivamente il punto di vista delle bottiglie abbandonate dall’incuria dell’uomo e quello di volpi britanniche nel loro conflittuale rapporto con la “civiltà” umana dagli anni trenta del secolo scorso ai primi decenni post bellici.
____________________
Dalla parte delle bottiglie [7]
Se non avete mai visto una bottiglia incarognita è perché non sapete guardare le bottiglie.
Osservatele bene, in qualche discarica abusiva (o anche autorizzata), tra detriti di muratura, sacchetti di plastica, vecchi scatoloni e residui alimentari più o meno marcescenti; osservatele, vi dico, e vi accorgerete che quelle hanno raggiunto il livello della disperazione senza ritorno.
Dopo averle osservate così frammiste ad ogni tipo di sudiciume, riflettete. Immaginate che una di quelle fosse stata una bottiglia di Barolo del 1972, o di Dolcetto del 1978 o anche solo di Lambrusco dell’ultima vendemmia. In ogni caso sempre si tratta di bottiglie piene d’orgoglio e di dignità, con una loro personalità, sottoposte ad un’umiliazione senza pari.
Non mi si venga a raccontare che faccio confusione tra contenitore e contenuto; le due cose sono strettamente legate, interdipendenti. Lo immaginate voi uno che dal vinaio chiedesse:
– Mi dia settantacinque centilitri di Chateauneuf du Pape.
No, non può succedere, per essere intesi di bottiglie bisogna parlare. Il contenuto è vincolato al contenitore per tutta la comune esistenza.
Immaginare l’abisso di vergogna e di disperazione in cui precipita una bottiglia che passa da un giorno all’altro dallo scaffale dei vini pregiati al secchio dell’immondizia non è difficile. Ma non è il solo caso.
Vi sarà capitato un giorno d’estate di imbattervi, in qualche prato di montagna o anche di collina, nei residui dei “pic-nic” dell’ultimo “week end”. Osservate le bottiglie abbandonate contro il tronco di una grossa pianta: vi appariranno smarrite. Esse non sanno se sono state dimenticate oppure abbandonate di proposito. Possono essere anche bottiglie di acqua gassata o di bibite varie, oltreché di vino, ma l’espressione è la stessa ed è di smarrimento. Non si danno pace perché continuano a sperare che qualcuno si ricorderà di loro e tornerà a raccoglierle, ma poi, passando i giorni e non succedendo niente eccole lì, sempre più avvilite. Cosa possono fare, delle bottiglie, sotto un albero in un prato? È una situazione assurda e quelle si avviano verso la follia. Nel qual caso rotolano e si nascondono nell’erba, si rompono sotto gli zoccoli del bestiame al pascolo e talvolta feriscono qualche animale o anche qualche turista dei “week-end” degli anni successivi che non abbia avuto l’accortezza di guardarsi bene attorno prima di sedersi.
Le bottiglie più dure riescono a non perdere il ben dell’intelletto ma egualmente, se abbandonate a lungo, si incanagliscono e finiscono col compiere atti di teppismo. Personalmente ho potuto osservare il comportamento di una bottiglia di Nebbiolo lasciata sui bordi di un’autostrada. Era rimasta lì per settimane a rimuginare la sua rabbia, fino a quando, a seguito di un temporale, riuscì a rotolare di alcuni decimetri verso la carreggiata. Il destino volle che quel giorno si formassero degli incolonnamenti e che il solito marpione decidesse di fare il furbo superando tutti sulla corsia di emergenza. Non l’avesse mai fatto! La bottiglia come un kamikaze gli scivolò sotto la ruota anteriore destra facendogli secca la gomma e annullandogli ogni velleità di fare ulteriormente il furbetto.
Ora, è questo teppismo delle bottiglie abbandonate che maggiormente preoccupa le autorità. Ad esempio si sono formate bande che si dedicano alla “guerriglia dei bassi fondali”, che è un tipo di guerriglia specifico delle volgari cocci aguzzi e si dispongono in agguato sui bassi fondali nei pressi delle spiagge, al mare, ai laghi o nei fiumi. Succede sempre che qualche sprovveduto, ignaro dello stato di guerra, nella stagione dei bagni vada a camminarvi sopra. A quel punto quello è una uomo (oppure una donna o un ragazzo) ferito, e non sarà un uomo (oppure donna o ragazzo) morto solo grazie alla puntura antitetanica, se avrà l’accortezza di farsela fare.
Le vittime di questa piccola guerra detta “dei bassi fondali” sono ogni anno migliaia, senza contare quelli che vengono colpiti (più esattamente tagliati) da cocci che si erano nascosti nella sabbia e da quelli che si erano mimetizzati nell’erba.
Contro queste forme di terrorismo delle bottiglie vi è chi propugna la linea dura: proibizione assoluta di fare i bagni dove i fondali sono sospetti e divieto totale di camminare scalzi sull’erba o sulla sabbia. Io devo dire che sono più propenso alla linea morbida. Sono con il partito della trattativa. Cosa chiedono le bottiglie? Le loro rivendicazioni sono ragionevoli, ascoltatele:
1) Visto che la nostra nascita è costata lavoro, fatica e … petrolio (un litro per ogni chilo di vetro), è ingiusto condannarci ad una vita assurdamente effimera.
2) Ogni bottiglia vuota dovrà essere raccolta, lavata, sterilizzata e riutilizzata. La gioia di poter sempre ritrovare un contenuto e fare una nuova esistenza non ci deve essere negata.
3) Quelle fra di noi che dovessero subire disgrazie e risultare sbrecciate, incrinate o rotte, dovranno avere il diritto di essere riportate in vetreria per essere rifatte con tutte le regole dell’arte vetraria.
Il rispetto della dignità delle bottiglie sarà ricambiato da queste con il rispetto per i piedi, le mani, le natiche e le gomme degli umani.
A me non sembrano proposte estremistiche. Così stando le cose, lo confesso, io sono dalla parte delle bottiglie.
Le volpi di Bristol [8]
La colpa, oppure il merito (a seconda dei punti di vista) è stato di una vecchia volpe zoppa conosciuta da quelle parti sotto il nome di Foxtour. Il fatto è che a Bristol le volpi ora vivono in città. Ma questa è una storia che merita di essere raccontata dall’inizio.
Una volta, ma tanto, tanto tempo fa, le volpi del sud ovest dell’Inghilterra stavano tranquillamente al gioco, il gioco consisteva nel fatto che gli uomini mangiavano le volpi per cui queste si sentivano in diritto, quando ci riuscivano, di mangiare le galline, i conigli e le oche degli uomini. Questi, se erano poveri, facevano i bracconieri usando tagliole e lacci che normalmente le volpi scoprivano ed evitavano; ogni tanto però riuscivano a catturare qualche volpe distratta, “fuori di testa”, come si dice, cosa che succede anche fra quei canidi. I ricchi invece organizzavano grosse battute con trombe, cavalli, cani e valletti. Ma ai ricchi non piace soffrire e le grandi cacce alla volpe si facevano solo se il tempo era bello, non vi era nebbia, non vi era fango, non faceva troppo caldo e nemmeno troppo freddo. Le grandi cacce avvenivano dunque raramente.
Alle volpi sembrava normale che gli uni cercassero di mangiare gli altri e viceversa; la fame è fame e le leggi della natura sono quelle che sono. In realtà, all’inizio del ventesimo secolo, quando anche i bracconieri cominciarono ad avere dei fucili, pensarono che si barava un po’ al gioco, ma non si preoccuparono più di tanto; l’astuzia non è mai mancata alle volpi ed usandola bene anche un cacciatore con arma da fuoco può essere reso innocuo, o quasi.
Quel che forse non sapete è che le volpi, sul finir dell’inverno, se le notti sono chiare, si radunano nelle radure dei boschi. In quegli incontri non solo nascono trame amorose (anche le volpi usano procreare), ma avvengono scambi di informazioni e anche di pettegolezzi. Così, in una chiara notte dell’inizio di marzo del 1932 si diffuse una notizia che doveva in parte cambiare il comportamento di quegli animali. L’informazione fu riportata da una femmina delle campagne di Bath, una volpe conosciuta con il nome di Foxpett a causa della sua fama di pettegola sempre ben informata. La storia Foxpett la raccontò così:
“Lo sapete che gli uomini non ci mangiano più? Vi è ormai tale abbondanza di cibo tra gli uomini che mangiare volpi è considerato cosa bizzarra e ripugnante, roba da maniaci…”
“Ma come?” interloquì subito un giovane volpacchiotto appena arrivato dalle colline dette Cotswold Hills, “come non ci mangiano più? Dalle mie parti ci cacciano maledettamente, come prima se non di più!“
“Lo so bene” rispose sussiegosa la vecchia Foxpett, “ma non ci cacciano per mangiarci, lo fanno per le nostre pelli. Le femmine degli uomini amano adornarsi con pellicce di volpi. Per quelle ci cacciano, non per mangiarci …“
Quella notte nella radura vi fu un gran trambusto e la riprovazione si diffuse poi sia in pianura che in collina. L’idea di un comportamento tanto innaturale suscitò collera ovunque. È da allora che le volpi si sono lasciate andare, come è nella logica delle cose malvagie, ad atti di rappresaglia altrettanto odiosi. Infatti, è a partire da quegli anni che le volpi commettono stragi. Quando riescono ad entrare in un pollaio uccidono non solo i pennuti che intendono mangiare, ma li fanno secchi tutti; ammazzano proprio tutti, galli, galline, oche e tacchini vengono sterminati non per fame ma per vendetta.
Come si sa, la vendetta non ha mai risolto niente né portato alcun bene. Gli uomini continuarono a cacciare le volpi per poter conciare le loro pellicce. Si dice che fu in quegli anni che nacque l’espressione “fare la pelle”. Per evitare che fosse loro “fatta la pelle” le volpi dovettero mettere in atto un numero infinito di astuzie ed infine ne escogitarono una decisiva: la rogna.
Vecchie volpi rognose ve ne erano sempre state, ma poche. Prima di questa vicenda venivano accuratamente evitate dalle altre che, incontrandole, si fermavano sì a conversare, ma a debita distanza. Dopo la diffusione della moda dei “renard” le volpi rognose furono invece particolarmente ricercate dalle loro consorelle e, maschi o femmine che fossero, in ogni caso amorevolmente abbracciate e coccolate, con insistenti strofinamenti di cute. Nel giro di due anni tutte le volpi del sud ovest dell’Inghilterra furono “colpite” da quella malattia che gli uomini chiamano scabbia. I cacciatori considerarono quel fatto una sciagura poiché quel male, facendo perdere il pelo a quelle bestie ne annullava il valore. Invece, dal punto di vista delle volpi, la rogna fu una benedizione del cielo. Meglio, mille volte meglio essere spelacchiate che spellate.
Vi fu poi un periodo di pace per le volpi delle campagne di Bristol. Alla fine degli anni trenta molti cacciatori furono spediti altrove per sparare non alle volpi ma ai loro simili e i canidi ne approfittarono per procreare e moltiplicarci in grande quantità. È pur vero che in quei tempi i pollai erano custoditi come fossero banche ma, in assenza degli uomini cacciatori, si moltiplicarono anche lepri, conigli, scoiattoli, ghiri, quaglie e pernici che, in aggiunta a grilli, cavallette frutti e bacche assicuravano comunque cibo alle volpi, nel sud ovest dell’Inghilterra come altrove. Ma i tempi della goduria dovevano finire.
Una notte di febbraio del 1948, nella radura di un bosco poco distante da Bristol si diffuse una notizia terribile. A portarla questa volta non fu la vecchia Foxpett, ormai morta da tempo, ma sua nipote, chiamata Foxpettter, che nel darla appariva sì preoccupata, ma soprattutto piena di sé per essere stata la prima ad averlo saputo.
“Gli uomini ci hanno dichiarati animali nocivi; i cacciatori potranno spararci quando vogliono e chi porterà una nostra coda al guardiacaccia riceverà due sterline…”
Fra le volpi l’indignazione fu pari alla paura. Le proteste di quelle bestiole si levarono al cielo.
“Nocive noi!” esclamò una volpetta dalla coda spelacchiata, “ma se lo sanno tutti che i soli, i veri nocivi sono loro…”
“Ora diranno che siamo state noi ad inquinare il Severn…” ribatté un’altra dal gannito stridulo.
“E a incendiare i boschi …”
“E a rovinare le colline per fabbricare cemento e mattoni …”
“E a scavare la pianura per estrarre sabbia …”
“E ad ammorbare l’aria col fumo delle ciminiere…”
Il raduno delle volpi del febbraio 1948 si concluse in una grande confusione, con quegli animaletti pieni di rabbia. Si racconta che è da allora che i veterinari delle campagne hanno dovuto fare i conti con una nuova malattia; la rabbia delle volpi, appunto. Molti però pensano che quella sia solo una leggenda.
Solo il vecchio Foxtour non perse la calma. Quel volpone era stato impallinato, una volta, in gioventù e da allora claudicava, insomma era un po’ zoppo. Avendo perso alcuni punti in lestezza era riuscito a campare sviluppando ulteriormente quel ben dell’intelletto che è l’astuzia. Per tutte le volpi dei dintorni di Bristol il vecchio Foxtour era un maestro di furbizia. Della sua abilità si parlava molto, d’inverno, nelle tane sotto la neve.
L’intelletto di Foxtour aveva però un limite; funzionava solo quando la bestiola aveva fame. Dopo un pasto abbondante il volpone si ritrovava del tutto ottuso. In quello stato riusciva solo a molestare le femmine oppure a rincorrere la sua coda, girando in tondo. Proprio per questo suo tic lo chiamavano Foxtour. Al terzo giorno di digiuno, invece, la volpaccia diventava un portento.
All’inizio di marzo, quell’anno, nevicò sul sud ovest dell’Inghilterra. Brutt’affare per le volpi in cerca di cibo e grossa pacchia per i cacciatori in cerca di volpi. Al terzo giorno di digiuno, puntualmente, a Foxtour venne l’ispirazione: “Per evitare che il cacciatore ti trovi devi andare da dove parte“. Si avviò quindi verso Bristol, dove giunse a notte fonda e subito scoprì che a quell’ora, nelle strade, sono allineati grossi bidoni pieni di rifiuti, quindi di vettovaglie.
Il fatto che quei contenitori fossero già frequentati dai gatti che si ritenevano titolari di tutti i diritti non lo impressionò molto. Gli bastò sollevare leggermente il labbro perché alla vista delle sue zanne i felini abbandonassero il campo, cioè i bidoni.
Foxtour capì che gli bastava esplorare alcune pattumiere, un’ora di lavoro al massimo, per risolvere il problema del cibo quotidiano, ma prima doveva trovare un posto sicuro dove nascondersi durante il giorno. Individuò i ruderi di una fabbrica abbandonata e quella gli sembrò la residenza ideale per una volpe solitaria. Ma il volpone non aveva ancora scoperto tutto.
Fu infatti nella sua seconda uscita notturna che Foxtour doveva imbattersi in una brutta avventura; attorno alle pattumiere vide aggirarsi un cane randagio più grosso di lui. La nostra volpe dovette battere in ritirata e stare rintanata tre giorni di seguito nella sua fabbrica prima che gli venisse l’idea giusta. Al terzo giorno, come sempre l’ispirazione arrivò:
” Se una volpe incontra un cane, la volpe scappa. Se un cane incontra tre volpi, il cane scappa…”
Quella notte Foxtour se ne tornò in campagna per convincere due graziose volpette che conosceva a scendere in città con lui, e per farlo, raccontò loro la storia delle pattumiere. Quel che Foxtour non sapeva è che una di quelle femminucce se l’intendeva con un tipaccio chiamato lnt-Fox; insomma una spia. Appena informata quella volpaccia vendette la notizia in tutta la contea e già a maggio le volpi, a Bristol, erano decine.
Così è andata la storia, ora quei canidi dalla folta coda si sono sistemati in città, chi nei cunicoli delle fabbriche abbandonate, chi nelle cantine di vecchi tuguri, chi ha scavato tane nei parchi e chi ha trovato un angolino comodo in qualche cimitero. Hanno occupato la città, poi gli uomini li hanno presi in simpatia dichiarandoli animali protetti.
È una pacchia? Non troppo: Le volpi sono fatte per vivere libere nei boschi e nei campi e forse là qualcuna vorrebbe ritornare. Ma come fare? Le vecchie volpi pioniere sono morte da tempo e quelle nate in città non sanno come si fa per uscirne. Una sola potrebbe guidarle alla fuga. È un volpacchiotto chiamato Foxtoursix, il più furbo dei volpacchiotti. Solo che riesce a mettere in funzione tutta la sua intelligenza solo dopo tre giorni di digiuno, e ciò, a Bristol, non può proprio succedere.
[1] Babeuf, Togliatti e gli altri. Racconto di una vita, Tararà, Verbania 2000, p. 179-180.
[2] Il progresso impazzito (25.8.1972) e Rinascita, il manifesto e l’ecologia (5.11,1972).
[3] Il secondo fronte. Grazie alla ‘globalizzazione’ si aggrava il degrado ambientale. “La Scintilla”, febbraio 1998.
[4] La cometa di Halley (1985); Una storia incredibile (1986); Il nordest della Baviera (1987); Il vizio di pensare (1988); La congiura delle automobili (1990).
[5] Il satellite dubbioso e L’oro dell’alchimista edite con l’autobiografia (cfr. nota 1), Dalla parte delle bottiglie (Il Cobianchi, 2000) e Le volpi di Bristol (Nuova resistenza Unita, n. 4, 2020). Da quest’ultimo numero della rivista ho ripreso anche questa mia introduzione.
[6] Ringrazio le figlie Laura e Maura per l’autorizzazione a pubblicarle su questo blog.
[7] Dattiloscritto, datato 1986. Pubblicato sulla rivista “Il Cobianchi” nel 2000.
[8] Dattiloscritto, non datato. Presumibilmente del 1985 o 1986. Pubblicato su Nuova Resistenza Unita n. 4 2020.

Era la parola sorretta dalla memoria che suppliva agli scritti, non solo nella trasmissione delle testimonianze e della cultura delle comunità montane, ma in altre circostanze, quali le contestazioni, le liti, la perpetuazione delle usanze civili e religiose. (“A piedi nudi”)
… campeggia, quasi a voler essere personaggio e imporre una sua presenza, la selvaggia e quasi mitica Valle del Fiume Grande dei nostri predecessori di cinque e più secoli or sono, la Val Grande partigiana e martire, in quel periodo testimone di episodi abbietti e di eventi esaltanti, di avvenimenti tanto drammatici da rasentare l’irrealtà, da sembrare incredibili. (“Val Grande partigiana e dintorni”)
Un Parco Letterario
Sabato 24 ottobre 2020, con le firme dei Presidenti della Rete dei Parchi Letterari, del Parco Nazionale ValGrande e della Casa della Resistenza, si è costituito il Parco Letterario Nino Chiovini che, ventiseiesimo in Italia e primo nel territorio piemontese, viene dedicato al “partigiano, storico e scrittore verbanese, figura chiave della ricerca etno-antropologica, storico-geografica, socio-economica della Val Grande e del suo territorio, nonché scrittore dalla riconosciuta valenza letteraria”[1].
Riprendo, rielaborandolo ed ampliandolo, l’intervento che a nome della Casa della Resistenza ho preparato per l’occasione. Pochi giorni prima una caduta fatale in montagna ci aveva privato di Erminio Ferrari che della cifra umana e letteraria di Nino Chiovini è stato il più coerente interprete e prosecutore, per cui è stato spontaneo, nel mio come in molti degli altri contributi, accostare le due figure.
Tutta la storia è storia locale
Un filo diretto di continuità, come persona e come scrittore, lega Erminio Ferrari – di recente tragicamente scomparso – con Nino Chiovini; in particolare aveva introdotto nel 2002 le riedizioni di due opere di Chiovini: Mal di Valgrande (la precedente era del 1991) e Valgrande partigiana e dintorni che risaliva al 1980.
Nella prefazione di quest’ultima Erminio Ferrari, dopo aver sottolineato il nesso fra il lavoro di Chiovini e quello di Nuto Revelli, citato in epigrafe al saggio introduttivo del volume (Guerriglia nel mondo dei vinti), e di Claudio Pavone, l’autore di Una guerra civile[2] aggiungeva:
Revelli-Chiovini-Pavone: non siamo qui, s’intende, a stabilire gerarchie di valori tra le opere né, all’opposto, a illuminare di luce riflessa (quella del professore) lo storico di periferia; il parallelo serve, casomai, a rilevare come, pur da una collocazione defilata, il fare storia di Nino Chiovini fosse nel solco della più seria e accorta ricerca.
Perché è questo che conta: non esiste storia locale. Di “locale” possono esservi semmai il valore di una “storia”, o le capacità, le fortune, di un autore; mentre, come hanno dimostrato storici superlativi del nostro tempo, anche di uno sputo di terra si può narrare una storia che parla al mondo. In questo senso si è anche detto, ribaltando la prospettiva, che tutta la storia è storia locale; e allora sì siamo d’accordo. Ed è certo che quella di Nino Chiovini lo era con questo significato.[3]
Il discorso in forma più articolata lo si ritrova nella prefazione di “Mal di Valgrande”: la Storia locale, sottolinea Erminio, “non è narrazione di avvenimenti puri e semplici”, non è pura erudizione (quest’ultima semmai è il “vizio infantile” della storia cosiddetta locale). E richiama lo storico Fernand Braudel e Plinio Martini, scrittore elvetico particolarmente amato da Chiovini, che ne Il fondo del sacco:
fa chiedere all’io narrante “Ora io non so se la storia di un paese di cinquecento anime possa avere un significato”. Che è un po’ come chiedersi se abbia significato la vita di ognuno. La storia impegna chi la “fa”, chi la indaga, in questa ricerca di senso, e forse la storia locale ancora di più della grande storia del mondo. Perché nelle periferie dei grandi eventi universali si misura la loro portata, leggendola nei luoghi e su volti ben noti allo studioso. Che a sua volta vi si specchia e si interroga.[4]
Una dimensione etica
Erminio ricorda anche come Nino, parlando di “Cronache di terra Lepontina” gli avesse detto che “Lo interessava, e scopriva la possibilità di scrivere ‘una storia di base, non solo politica o storia di potere. Una storia economica finalmente e una storia morale”.[5]
Una storia morale e pertanto una scrittura morale. Vorrei cercare, sia pur per sommi capi, di approfondire questa dimensione etica, non solo degli scritti, ma dell’intera figura di Chiovini, che è stata figura ricca e poliedrica di attività ed esperienze; per citarne alcune: lo studente attento ad accogliere in pieno periodo fascista gli insegnamenti più critici dei suoi insegnanti del Cobianchi, il neo diplomato perito chimico, il giovane alpinista, l’antifascista che opera a Cuggiono prima dell’8 settembre con altri giovani ispirati da don Giuseppe Albeni, il partigiano Peppo con una sua particolare visione della guerra di movimento legata al piccolo gruppo esperto e coeso, l’insegnante, solo per un breve periodo subito dopo la guerra, ma che ne avrebbe per certo avuto la “stoffa” come dimostrerà nella sua magistrale lezione del marzo 1983 all’Università della terza età di Verbania su “Fascismo antifascismo e resistenza nel Verbano”[6], il tecnico della Rhodiatoce e rappresentante sindacale che dà il suo contributo di competenze tecniche alle rivendicazioni operaie, il politico e amministratore nel Comune di Verbania, e naturalmente il ricercatore, lo storico della resistenza del Verbano e della civiltà rurale montana, il precursore del Parco Nazionale della Val Grande, l’amante e il conoscitore approfondito del territorio locale e del mondo naturale. Su ognuna di queste peculiarità si potrebbe ricucire il filo del suo percorso di scrittura. Ad esempio il chimico di cui si trova evidente traccia nella accuratezza terminologica e nell’asciutto rigore del suo scrivere che spesso ci riecheggia la qualità stilistica di un altro chimico: Primo Levi.
Personalmente ho conosciuto Nino, che chiamavamo Peppo col suo nome di partigiano, durante le lotte della Rhodiatoce, sfociate nell’occupazione del marzo 1969 e nel successivo ciclo di lotte durate per oltre un decennio. Ricordo in particolare una Assemblea aperta del 1979 con le operaie in Cassa integrazione che, a differenza dei colleghi maschi, erano state escluse da un recente accordo con l’azienda dal rientro nei reparti; assemblea cui erano anche presenti sindacalisti, tecnici ed esterni. Chiovini ha introdotto e gestito l’assemblea. Mi aveva colpito la sua capacità di dar parola, di far parlare queste donne anche di fronte a interventi più paludati di sindacalisti, tecnici e politici.
La moralità del “dar parola”
Ecco il “dar parola”: questo mi sembra lo specifico tratto della moralità degli scritti, e non solo degli scritti, di Nino Chiovini. Dar parola che non è solo “passare il microfono” ma richiede modalità, anche tecniche, specifiche e una “cura”, un prendersi carico, un raccogliere e una capacità di predisporre l’ascolto. Dar voce chi non l’ha più, a chi di solito non è ascoltato, a chi è stato messo da parte. Dar voce alle persone, ma anche ai luoghi perché portano i segni delle precedenti generazioni e ci parlano, ci possono parlare, se il nostro orecchio e la nostra mente sono attrezzati, attraverso le tracce disseminate nel territorio.
Il paesaggio da Chiovini non è visto e descritto in un’ottica estetizzante; nella Presentazione di “Mal di Valgrande” questa visione morale del territorio è esplicita: il fascino che esercita quella valle, “la sua originale natura” diventa chiave di lettura per intendere il sentire degli alpigiani, contesto che illumina il testo delle testimonianze raccolte. “Questo libro” afferma nell’introduzione:
È fondato sulle testimonianze orali e rappresenta la mia gratificante rappresentazione scritta di vicende udite — e registrate — da persone, alcune delle quali hanno raggiunto il riposo perenne e vivono solo più nel ricordo di una parte di quelle viventi. Per me, che non contrassi uno specifico rapporto affettivo con la Val Grande connaturato all’esperienza degli alpigiani, ma di cui confesso di apprezzare i molteplici aspetti della sua originale natura dominata da percettibili grandi silenzi e remoti suoni celati entro smisurati spazi, tanto da indurmi a periodiche escursioni specie nella parte alta, e di essere pure affascinato dall’alto grado e dalla qualità dell’intervento umano effettuato nel passato, specie nelle sue aree estreme, è stato importante cimentarmi nell’interpretazione dei sentimenti che animarono gli alpigiani che operarono entro quella valle, senza nostalgìe e conscio che la realtà da affrontare è quella odierna.[7]
Mal di Valgrande
Possiamo considerare “Mal di Valgrande” il ponte, non cronologico, ma contenutistico, fra le due trilogie delle opere principali di Chiovini: la trilogia partigiana (I giorni della semina, Val Grande Partigiana e dintorni, Classe IIIa B. Cleonice Tomassetti vita e morte) e quella della “civiltà rurale montana” (Cronache di terra Lepontina, A piedi nudi. Una Storia di Vallintrasca, Le ceneri della fatica). Nella Presentazione Nino esplicita le modalità di questo “dar parola” e il debito metodologico (oltre che tematico) con Nuto Revelli, così come il ruolo fondamentale dell’amico Giuseppe Cavigioli, “mediatore” come lo è stato Dalmasin Giraudo per Revelli. E prima ancora, sul Colophon, riporta, paese per paese (Colloro, Cuzzego, Miazzina, Premosello, Rovegro, Trontano) i 24 nomi dei testimoni[8]: in qualche modo gli autori originari di quanto tra anteguerra, guerra e dopoguerra, possiamo oggi ascoltare della vita e dei ricordi di questi “contadini di montagna”.
L’incrocio fra le due tematiche – resistenza, civiltà rurale montana – tematizzato criticamente nel saggio introduttivo di Valgrande partigiana e dintorni[9], in queste pagine emerge direttamente da più testimonianze. Fra tutte la più intensa quella di Silverio Dinetti (Avevo dodici anni)[10] sull’eccidio dell’Alpe Casarolo del 22 giugno 1944 durante il rastrellamento della Valgrande. Dapprima Chiovini inquadra il contesto e la figura del testimone:
Gli alpigiani di Premosello e di Colloro, che da pochi giorni avevano ricominciato l’annuale monticazione estiva nei corti dell’alta Val Grande, si trovano senza volerlo nel mezzo di quella bufera che non li risparmia. Anch’essi terrorizzati e perseguitati dalle truppe nemiche, che non perdonano loro l’aiuto prestato ai partigiani, non per questo cessano di stare dalla loro parte, pagando un alto prezzo di sangue, distruzioni, saccheggi.
Quel 22 giugno, soldati tedeschi e fascisti compiono un eccidio di partigiani e di contadini all’alpe Casarolo. È di ciò che accadde in quel luogo, quel giorno, la precisa circostanziata testimonianza di Silverio Dinetti di Colloro, a quel tempo pastorello dodicenne, unico testimone di tutte le fasi della strage compiuta. L’ho raccolta il giorno di San Gottardo, festa patronale di Colloro, il 5 maggio 1980.
Silverio Dinetti, divenuto operaio-contadino, di giorno lavorava alla Sisma di Villadossola; per il resto della giornata faticava a Colloro, accudendo con la moglie al bestiame — una mucca, capre, pecore — e lavorando la terra. Questo suo secondo lavoro lo preferiva al primo: socialmente utile in tutta compiutezza e a lui congeniale. [p. 113-114]
Ci avverte poi come il suo dar parola sia mediato dalla trascrizione in lingua oltreché dal passaggio dal parlato allo scritto: l’implicito invito è di immedesimarci con mente e sentimento nella situazione di ascolto dell’operaio-contadino che nella sua parlata locale rievoca la traumatica esperienza di trentasei anni prima, di quella “giornata di bel tempo” quando aveva compiuto dodici anni da due giorni appena:
L’originale racconto di Silverio, che ho necessariamente tradotto in lingua corrente, tentando senza successo di conservargli la sua efficacia e la sua proprietà, è infinitamente più vivo; non soltanto io non sono in grado di scrivere in dialetto ossolano, ma non ho la capacità di riprodurre l’impressione che mi hanno fatto la precisione e le reiterate ripetizioni di alcuni particolari ormai indelebili nella sua memoria. [p. 115]
La trilogia Partigiana
Senza richiamare il nome non è possibile “dar parola” e quando Verbano, giugno quarantaquattro del 1966[11] otto anni dopo viene ampliato e arricchito dando vita a I giorni della semina[12], l’opera ancor oggi più completa sulla resistenza locale, a conclusione del testo vengono riportati i nomi degli oltre 320 caduti della resistenza del Verbano, la loro età e la data e il luogo ove hanno deposto il loro seme di cui noi abbiamo il dovere di raccogliere i frutti. Quella “cronaca di una sconfitta”, quel dramma del rastrellamento dentro la Val Grande è ricostruita con una scrittura asciutta e senza fronzoli, lapidaria così come sono le lapidi che ricordano i nomi dei caduti ed è doveroso “farne il conto” quale debito ai noti e ai molti ignoti. Altrettanto doveroso ricordare la determinazione di riprendere la lotta dei rimasti in vita quandanche “per la maggior parte in precarie condizioni fisiche”.
Le perdite partigiane sono molto gravi: quasi trecento morti! Sette tra la popolazione civile, diciotto-venti della Giovine Italia, 34 della Cesare Battisti e 220-240 del Valdossola. Il numero dei caduti appartenenti al Valdossola non può essere stabilito che per differenza tra la forza ufficiale precedente al rastrellamento e il numero dei superstiti. In molti casi il riconoscimento dei cadaveri rinvenuti è risultato impossibile; in altri casi i corpi non sono stati ritrovati e sono ancora oggi celati in luoghi pressoché inaccessibili o fuori mano; alcuni si presumono morti d’inedia, nascosti in anfratti. Si tenga presente, infine, che nei giorni immediatamente precedenti il rastrellamento, l’afflusso dl nuove reclute ai distaccamenti partigiani fu particolarmente intenso e parte di esse, non registrate al loro arrivo, sono cadute rimanendo spesso anonime. Ovviamente il maggiore numero dei morti si registra tra le reclute, ossia tra i meno preparati fisicamente, moralmente e militarmente.
Le baite incendiate sono 208; cinquanta case dell’abitato di Cicogna sono state distrutte o danneggiate dall’inutile bombardamento; tre rifugi alpini (alla Bocchetta dl Campo, al Pian Cavallone e al Plan Vadàa) sono stati distrutti e un altro (la Casa dell’Alpino ad Alpe Prà) danneggiato. Rimangono in vita circa centosessanta partigiani (dei quali cinquanta più o memo feriti), per la maggiore parte in precarie condizioni fisiche. Undici di essi sono riparati oltre il confine svizzero. Pressoché nessuna defezione si verifica tra i superstiti: anzi, riprenderà immediatamente l’afflusso di nuovi volontari ai centri cui hanno fatto capo i sopravvissuti.[13]
E, racconto inframmezzato al resoconto del rastrellamento e della ritirata partigiana, si snoda la vicenda tragica della “madre di Gianni”[14] che “con le scarpe dal mezzo tacco e con il cuore che pare le voglia uscire dal petto, sale faticosamente accanto al figlio”. È il 12 giugno quando, dopo quattro giorni di faticosa traversata,
il gruppo di partigiani rimasto nel bosco del vallone di Finero, di cui fanno parte oltre a Scalabrino, gli inglesi Frank e Pitt, Gianni e sua madre, sono risvegliati dal fragore del combattimento di Pian di Sale. Non appena è l’alba Scalabrino, tirandosi dietro una decina di compagni (tra cui i due inglesi) e una mitragliatrice Breda ’37, parte in direzione della lontana Val Grande. Rimangono Gianni e sua madre che è mal ridotta, più altri cinque-sei. Gianni scende sulla mulattiera in riva al torrente e si apposta; come passa un vecchio alpigiano, lo abborda e gli spiega della madre sofferente, chiedendogli se può accompagnarla a Finero e magari tenerla in casa per qualche giorno: l’uomo accetta. Gianni torna dalla madre e l’accompagna dal vecchio. Poche parole di commiato dette sottovoce, gli sguardi carichi d’affetto e di speranza, l’ultimo abbraccio convulso; poi senza voltarsi a guardare e a testa china, ognuno s’incammina per opposte direzioni.[15]
Opposte direzioni di cui il destino ha beffardamente invertito le sorti: il figlio, che ha voluto salvare la madre da un rientro obbligato nella valle percorsa dalle truppe nazifasciste, si salverà mentre sua madre la ritroviamo il 27 giugno su di un “autocarro che si ferma in un prato al margine delle strada appena fuori Beura [che] trasporta otto uomini e una donna destinati alla fucilazione”. Se prima il racconto intercalato della “madre di Gianni” aveva implicitamente dato voce alla testimonianza del figlio, ora Chiovini vuol “dar parola” anche a lei, nel momento stesso del martirio:
La madre di Gianni è preparata a morire; e lì in piedi, calma all’aspetto, ma angosciata dentro per il figlio che «Dio mio fa che sia vivo!». E il ragazzo che le sta accanto, il ragazzo che singhiozza di rabbia, le parrà un po’ suo figlio. E la carezza che gli si allunga nell’attimo in cui sente il comando del fuoco, si trasforma nell’antico gesto materno di protezione, inutile contro la scarica che li trapassa. Dopo di loro, gli altri sette. A Beura, Val d’Ossola, il 27 giugno 1944.[16]
Se ne I giorni della semina la parola data dall’autore a “i morti e i vivi” del rastrellamento di giugno, è perlopiù mediata dalla scrittura dell’autore, in Val Grande partigiana e dintorni è invece data direttamente. Chiovini ha infatti raccolto e pubblicato quattro “storie di protagonisti” scritte da loro stessi, accompagnandole da una introduzione e corredandole di essenziali note:
Gli interventi operati nei riguardi dei testi originali sono limitati all’indispensabile: quel tanto che li rendesse comprensibili a sufficienza laddove ho presunto che occorresse. Nessun episodio, giudizio o testimonianza espressi dai quattro autori sono stati modificati o soppressi […]. La mia principale preoccupazione è stata, insomma, quella di conservare la sostanza, la genuinità e l’originalità dei testi …[17]
Il primo scritto, L’infermiera Maria[18] “è delle quattro storie, l’unico che viene redatto per essere reso pubblico”; qui Chiovini propriamente ridà voce in quanto il testo era stato letto dalla stessa Maria Peron, poco dopo la Liberazione, ai microfoni della neonata Radio Verbania Libertà. In una dozzina di pagine, volutamente essenziali, abbiamo “dalla sua stessa voce”, la vicenda straordinaria di questa partigiana senz’armi che da infermiera di Niguarda diventa “medico di Brigata” in ValGrande per curare e dare conforto e cure sia “ai suoi ragazzi” che agli alpigiani.
Dalle suore ottenni un altro vestito da contadina e un gerlo; così acconciata potei circolare liberamente – nonostante che i nemici fossero informati che un’infermiera partigiana circolava nella zona e le dessero la caccia – riuscendo a procurare ai miei ragazzi delle castagne e un po’ di latte. [p. 37]
Costituita la brigata Valgrande Martire, il lavoro sanitario divenne sempre più intenso sia per l’ampliamento delle zone delle operazioni e l’ingrossamento della formazione, che per le cure che andavo sempre più praticando anche alle popolazioni della montagna, praticamente prive di assistenza sanitaria. [p. 40]
La sezione successiva (Il comandante[19]) è dedicata a Dionigi Superti di cui pubblica una Relazione sul rastrellamento del giugno 1944, probabilmente non destinata alla pubblicazione ma che “non sembra servire ad altro che a fissare sulla carta alcuni appunti”. Non si tratta solo di render noto uno testo inedito sul rastrellamento della Valgrande del “comandante partigiano di maggior rilievo nel Verbano Cusio Ossola” “dopo la morte di Filippo Beltrami a Megolo” ma di una riabilitazione che corregge il giudizio in parte negativo ne I giorni della semina e soprattutto, dopo l’esperienza dell’Ossola libera, l’ostracismo da parte delle altre formazioni e del CLN che gli hanno impedito il rientro in Italia dalla Svizzera con accuse poi dimostratesi infondate. Un “Partigiano vero e saggio” amato dai suoi uomini, con buone capacità organizzative e “che ha saputo conservare un ottimo rapporto con la popolazione”, come ribadirà in un articolo su Resistenza Unita[20] dopo la sua morte a Madrid e il rientro delle spoglie in Italia. La parola essenziale di Superti ci offre una cronistoria “in diretta” di quei giorni di giugno:
All’alba del giorno 12 vengo informato che gli alpigiani di Premosello stanno fuggendo con il bestiame perché colà sono arrivate colonne di truppe tedesche e fasciste; dispongo subito perché in caso di attacco i feriti e i disarmati siano inviati in luoghi sicuri e perché tutte le pattuglie in servizio si portino alla bocchetta di Campo a cui farò affluire altri reparti. Dati questi ordini mi rimetto in marcia con gli uomini che con me erano partiti dal confine svizzero, per portarmi al posto 12, sede del comando … [p. 56]
Il terzo scritto, il più ampio fra i quattro[21], è di un ossolano di famiglia contadina, Alfonso Comazzi: si tratta di ricordi personali destinati ai figli e agli amici; Chiovini ne era casualmente entrato in possesso e, rintracciato l’autore, “pian piano guadagno la sua fiducia: fatico a convincerlo, infine acconsente ma vuole che siano tolte alcune frasi, qualche nome, anche quello del milite fascista che l’ha picchiato a sangue”.
È una storia straordinaria, raccontata con “il ritmo di un soggetto cinematografico”. Classe 1924, per non esser arruolato nella Repubblica Sociale riesce a farsi assumere con un suo amico dalla Todt[22], ritrovandosi senza volerlo con la divisa della Wermacht ma, spirito ribelle, inizia una vicissitudine di fughe, catture e fughe che lo riportano in Ossola dove, a Tappia, viene arrestato in una azione di rastrellamento.
Mi conducono nella piazzetta al centro del paese, mi fanno levare le stringhe delle scarpe, poi mi portano in una stradetta poco fuori dell’abitato. Ci sono due ufficiali tedeschi e due fascisti; mi vedono addosso la cintura dell’esercito tedesco e me la tolgono: si accorgono che la croce uncinata della fibbia è stata limata e cominciano ad usarla come frusta contro di me. Dopo pochi colpi sono irriconoscibile. […] Mi picchiano ancora, continuamente; poi non ricordo più niente. Quando rinvengo mi trovo grondante di sangue dalla faccia; vedo che molte case del paese sono in fiamme. Vicino a me c’è Pierino, anche lui è malconcio; da lui vogliono sapere chi sono, ma continua a sostenere che non mi conosce, anche se siamo amici e compaesani. [p. 83-84]
Finirà in carcere a Domodossola, destinato alla fucilazione quale disertore della Wermacht; il giorno prestabilito verrà invece scarcerato dai partigiani che hanno liberato Domodossola. Automaticamente arruolato farà parte prima della Cesare Battisti e, conclusa l’esperienza dell’Ossola libera, dopo un internamento in Svizzera, rientrerà nei partigiani garibaldini sino alla liberazione.
Intanto le formazioni si sono ingrossate: la 83° brigata Comoli, comandata da Mirco, fa parte della 2° divisione Garibaldi Redi, comandata da Iso e Pippo Coppo. Credo che la Redi sia la più organizzata di tutta l’Ossola; abbiamo persino una divisa, uguale per tutti, partigiani e comandanti. E nessuno ha più dell’altro, e se c’è da mangiare c’è per tutti, se si salta il pasto è così per tutti. [p. 101]
La avventura di questo “modesto figlio dell’Ossola, che più andava in cerca della tranquillità, più se ne allontanava” si conclude il successivo due maggio, il suo “ultimo giorno di partigiano”:
“… il mattino dopo consegno le armi al mio comando e me ne torno a casa mia e stavolta per sempre”. [p. 103]
Con l’ultimo scritto[23] rientriamo in Val Grande, nei giorni del rastrellamento: sono i “Ricordi partigiani” di Gianni Cella; nel 1910, a sei anni, aveva perso una gamba tranciata da un vagone merci. Cresciuto, dopo la morte del padre, in orfanatrofio accumulò sentimenti di ribellione che, nonostante la menomazione, lo portarono alla decisione di diventare partigiano combattente salendo in Val Grande nel marzo del 1944. Nonostante la sua stampella riuscirà a sfuggire al rastrellamento con un ripiegamento all’interno dell’impervia valle che ha dell’incredibile.
Io che ero uno degli ultimi della colonna, visti cadere parecchi compagni falciati dalle raffiche e a mia volta travolto dai superstiti che retrocedevano, pur di non cadere vivo in mano dei tedeschi, mi gettai rotolando per una ripidissima scarpata; poteva essere la fine ma fui assistito dalla fortuna e caddi in una pozza del ruscello. L’acqua attutì la mia caduta e mentre infuriava la sparatoria, sebbene intontito e quasi privo di forze, mi aggrappai disperatamente a un masso e cominciai a salire la sponda opposta. Ero scorticato in molte parti del corpo e quasi esausto, ma la volontà mi diede la forza di risalire e di scomparire nel bosco; per fortuna nella caduta non avevo rotta né perduta la stampella, altrimenti la situazione sarebbe diventata tragica per me. [p.116]
Sarà poi tra i partigiani che entrano il 10 settembre nella Domodossola liberata e, per prima cosa, andrà all’ospedale a far riparare “la mia stampella che a forza di camminare si era di molto accorciata”.
Quando, nel 1981, il Comune di Verbania, su proposta del Comitato Unitario per la Resistenza e in accordo con le istituzioni scolastiche, decide di titolare la Scuola Elementare di Intra alta a Cleonice Tomassetti, le “parole” dell’ultimo giorno della vita e il comportamento fiero della donna che sfilava nella prima fila dei “quarantatré” verso Fondotoce, erano ampiamente note: abbiamo la testimonianza di Carlo Suzzi subito dopo la Liberazione, poi più volte rilasciata[24], e il toccante diario del giudice Emilio Liguori, che – già noto a Chiovini e da lui ripreso nel 1966 in Verbano, giugno quarantaquattro e poi ne I giorni della semina – , viene per la prima volta integralmente pubblicato l’anno precedente[25].
Questo il noto passo di Liguori:
Lo spettacolo che stava per essere ammannito fu subito intuito dalla donna, alla quale ho accennato sopra. Costei si levò in piedi e con fare spontaneo, senza forzare il tono della voce, direi quasi con amorevolezza, rivolta ai compagni di sciagura pronunciò queste testuali parole: «Su, coraggio ragazzi, è giunto il plotone di esecuzione. Niente paura. Ricordatevi che è meglio morire da Italiani che vivere da spie, da servitori dei Tedeschi».
Aveva appena finito di parlare che, infuriato, le fu addosso un soldato germanico, che doveva capire un poco d’italiano e che del senso delle parole pronunciate era stato messo al corrente da un militare italiano. (Quale schifo il contegno servile verso i padroni tedeschi dei nostri militi! Non di tutti per fortuna, perché ne vidi più di uno fremere di rabbia osservando ciò che di orribile si compiva intorno a lui). La donna fu colpita atrocemente da più di uno schiaffo e da uno sputo sul viso. Non si scompose; incassò impassibile, e poi fiera e con aria inspirata, quasi trasumanata, disse parole che, per mio conto, la rendono degna di essere paragonata a una donna spartana, o meglio ancora ad una eroina del nostro risorgimento: «Se percuotendomi volete mortificare il mio corpo, è superfluo il farlo: esso è già annientato. Se invece volete uccidere il mio spirito, vi dico che la vostra è opera vana: quello non lo domerete mai!».
Poi rivolta ai compagni: «Ragazzi, viva l’Italia, viva la libertà per tutti!», gridò con voce squillante. Anima grande! So (per avermelo confidato un poliziotto, un bolzanese, che accompagnò il triste corteo fino al luogo dove avvenne l’esecuzione e vi assistette) che, durante tutto il tragitto di circa nove chilometri da Intra a Fondotoce, essa continuò a conservare una calma ed una serenità incredibili in una donna: e tale calma e serenità seppe, per virtù dell’esempio, comunicare agli altri suoi compagni di sventura. Avanzò per prima verso i carnefici, guardandoli fieramente negli occhi. Le sue ultime parole furono: «Viva l’Italia!».[26]
Ma di chi erano quelle parole? Non bastava correggere il nome dalle storpiature più volte occorse[27], bisognava restituire a quelle parole la figura autentica della donna che le ha pronunciate superando le mitizzazioni più o meno ufficiali (la maestra milanese, staffetta partigiana, moglie incinta di un comandante partigiano …) e quelle romantiche della donna matura salita in montagna per raggiungere il suo giovanissimo innamorato[28]. Nasce allora, frutto di una attenta ricerca, Classe IIIa B. Cleonice Tomassetti. Vita e morte che, raccogliendo le testimonianze di chi l’aveva effettivamente conosciuta, ci consegna la storia di una donna di origine contadine, travolta da dolorose vicende a cui ha sempre saputo reagire con scelte coraggiose e inusuali nel contesto socio-culturali del periodo.
La sua parola decisa ci viene restituita dal sarto, comunista e avventista Eugenio Dalle Crode: Nice quando sente l’affermazione di Sergio Ciribi
“Vado in montagna con i partigiani”
… disse “Allora, ci vengo anch’io”. Lei, le decisioni le prendeva così, all’improvviso.[29]
Tramite le parole di Giorgio Guerreschi, sopravvissuto, ritroviamo la parola di Nice, e il suo accento romanesco, quando, salita con i due giovani compagni in Val Grande per unirsi ai partigiani, a Corte Bué, si accorsero “di essere capitati dentro un rastrellamento”.
Mentre stava ancora diluviando, sentimmo sparare in lontananza; […] scorgemmo gruppi di soldati tedeschi e fascisti che si avvicinavano alla baita in cui ci trovavamo. Erano ancora lontani e facemmo in tempo a nascondere il fucile tra le erbacce, dietro la baita, e a discutere sul modo di giustificare la nostra presenza. Scartata l’idea di dire che stavamo facendo una gita e bugie consimili, decidemmo di dire la verità, cioè che eravamo venuti in montagna per unirci ai partigiani, ma che non li avevamo trovati.

I soldati erano ormai vicini e avanzavano con le armi spianate; una parte di loro erano SS italiane; altri erano soldati dell’esercito tedesco, ma avevano lineamenti asiatici, mentre i loro ufficiali dovevano essere tedeschi. Alla baita giunsero per primi gli italiani, che ci assalirono e cominciarono a picchiarci alla cieca, urlando che eravamo partigiani, poi arrivarono gli altri; un soldato mongolo mi disse: “Russland“. Un altro scoprì il fucile dietro la baita e addosso a noi piovve un’altra razione di pugni e pedate.
Poi si calmarono e cominciarono a interrogarci; noi dicemmo, come d’accordo, la verità, ma capimmo subito che non eravamo creduti. Allora la donna, che ci vedeva come ragazzini, disse che noi non avevamo colpa, che era stata lei a convincerci a salire in montagna. “Sono ancora ragazzi, la colpa è soltanto mia“, aggiunse. Non è vero che si inginocchiò davanti all’ufficiale; anzi, a un certo punto cominciò a inveire in romanesco contro di lui, mandandolo a quel paese. Era una donna decisa.[30]
E allora Chiovini ci invita a riascoltare le sue note parole rievocate dal giudice nel loro autentico e profondo significato:
Delle sue reiterate esortazioni ai compagni di supplizio, la prima – in quella tetra cantina – le frutta l’affronto di altre percosse e di uno sputo sul viso. La sua sferzante e precisa risposta è quella che avrebbe dato un vecchio saggio in pace con la vita. Anche Nice è in pace con la vita, ma non è un vecchio saggio: è una donna umiliata, dal corpo annientato. Ecco perché la sua risposta rivela una coscienza etico politica, insospettata in una “serva di locanda”.
Infine, quel viva l’Italia che, in perfetta lucidità grida alto nell’istante in cui è raggiunta dalla morte. Che non è tanto contrapposizione e invettiva agli uccisori, quanto messaggio programmatico e di speranza, affinché si realizzi una società italiana in cui si riesca a vivere in maniera diversa e equa, in cui abbia cittadinanza la dignità umana, in cui la donna non sia più umiliata in quanto donna; come invece fu lei, troppe volte, fino alla fine.[31]
La trilogia della “civiltà rurale montana”
È in Cronache di terra lepontina[32] che Chiovini elabora e tematizza la nozione di “civiltà rurale montana”; la genesi e lo sviluppo di questo suo studio è esplicitata nel capitolo conclusivo:
Era cominciata come indagine sulle vicende che opposero la comunità di Malesco a quella di Cossogno. Strada facendo, soprattutto attraverso la riesumazione e la decifrazione dei documenti della lite conservati nell’archivio comunale di Malesco, si è trasformata in ricerca sulla vita di quelle comunità rurali montane verbanesi e vigezzine tra il XIII e il XIX secolo e si è infine tradotta in osservazioni sulla civiltà rurale di quei luoghi.[33]
La contesa che per oltre cinque secoli ha contrapposto le due comunità per l’utilizzo degli alpeggi in alta Val Grande (Val Portaiola), “avari pascoli tra i milledue e i duemila metri di quota”[34], era nata in seguito a due atti di compravendita del 1251 e del 1304, diversamente interpretati dalle due parti. La contesa ha avuto momenti aspri e in particolare, nel 1355, un eccidio – non si sa fino a che punto reale o leggendario – all’Alpe Campo di sette maleschesi, e si è formalmente conclusa con un atto notarile siglato a Domodossola nel 1888. La vicenda permette di mettere in luce i rapporti fra i due comuni e il rapporto fra la “piccola storia” di due comunità montane e la “grande storia” che quella terra ha attraversato, ad esempio nel 1798 con il conflitto fra i repubblicani cisalpini e le “truppe dell’assolutista re di Piemonte e di Sardegna” quando “gli alpeggi della Val Portaiola videro transitare nella neve alta e ospitarono 400 repubblicani” in cerca di salvezza verso la Svizzera e che invece furono sopraffatti e sottoposti, a Domodossola e in più località a plurime fucilazioni. Una sorta di anticipazione di quello che avverrà in quelle vallate 146 anni dopo perché talvolta la storia si ripete e non sempre “in farsa”.
Due comunità quella di Cossogno e quella di Malesco che, dopo quell’accordo di fine Ottocento, avranno sviluppi diversi: la prima, storicamente più estesa, abbiente e popolata, vedrà progressivamente un declino economico e demografico con l’abbandono dell’economia montana (agricola, zootecnica, forestale) e l’assorbimento nell’orbita di Intra e Pallanza (poi Verbania), la seconda ha saputo sia pur parzialmente mantenere una economia agricola e zootecnica successivamente affiancata dal turismo e dal frontalierato – che ha in gran parte sostituito l’emigrazione – con un discreto sviluppo sul piano economico e demografico.
Questo iter storico, frutto di un impegno profuso negli archivi,lo si ritrova nella seconda parte dell’opera (La contesa), ma Chiovini non si accontenta di ricostruire gli eventi (la cosiddetta “storia evenemenziale”). Vuole dar luce – metaforicamente “dar parola” – alla vita quotidiana delle popolazioni che hanno colonizzato e praticato le terre alte valgrandine con una ricerca etno-antropologica del tutto originale su quella che lui stesso definisce “civiltà rurale montana” perché
è altrettanto utile e importante sapere come si dipanava il corso della vita in quel periodo, che essere informati sugli sviluppi, sulle responsabilità e sugli esiti della secolare contesa.[35]
Civiltà rurale che, nei suoi tempi lunghi, viene indagata, e presentata al lettore nella prima parte del libro, a partire dai primi insediamenti paleolitici sino al suo recente declino con un’ottica pluridisciplinare che unisce conoscenza geografica del territorio, archeologia, storia, toponomastica, cultura materiale, geologia, botanica, economia, diritto, analisi linguistica – e molto altro – con una rigorosa sintesi. In questo (ri)dar parola a “una civiltà estinta” centrale diventa l’analisi delle parlate locali a cui è dedicato un capitolo[36] perché la lingua può lasciar tracce spesso più durature di altre attività umane.
Le collettività rurali montane, pur essendosi caratterizzate come mondo subalterno, quindi culturalmente dipendenti e nel contempo parzialmente estranee alla società che fioriva nella valle padana, e che tra il XIV e il XIX secolo si trasformò da feudale in capitalistica, espressero complessivamente valori culturali autoctoni, sia pure con differenti radicamenti, con analoghe caratteristiche lungo tutto l’arco alpino.
Anche nel nostro territorio, letteralmente a ogni piè sospinto, esistono ancora tracce, testimonianze, sopravvivenze anche corpose di un patrimonio culturale accumulato e sedimentato nel corso di un millennio di vita da una società oggi inarrestabilmente in via di estinzione, sia pure non ancora consumata e tanto meno registrata anagraficamente.
Su tutte le testimonianze culturali si ergono i dialetti parlati (più precisamente, sopravvissuti) nei nostri villaggi montani, dalla Valsesia al Mottarone al Cusio all’Ossola al Verbano alle valli locarnesi, dialetti risalenti a un’unica origine e diventati più o meno dissimili nel lessico e nella pronuncia a causa delle reciproche separatezze. (p. 93)
Viene velocemente ripercorso l’iter di queste parlate dal ceppo originario celtico con gli innesti leponzi, latini, barbarici e tardo medievali in un rapporto di autonomia e talvolta di scambio reciproco fra “dialetto” e lingua ufficiale. Il dar parola in questo caso non è solo scelta “morale”: diventa vera e propria metodologia. Perché ciò che rimane di quella civiltà oltre le tracce materiali – sempre più residuali – sono appunto le parole. Ma si tratta di parole che da un lato vanno riscoperte, riportate alla luce e dall’altra fatte rivivere nel loro pieno significato. Metodologia che, qui esplicitata, percorre tutto il lavoro di Chiovini di ricostruzione nel lungo periodo della civiltà montana, sia nella sua progressiva espansione dai centri abitati a valle agli alpeggi in alta quota, che nell’analisi delle sue componenti etno-antropologiche.
… a partire dal XII secolo […] nei documenti conosciuti dell’epoca ricorre sempre più spesso il termine di runca, ossia terra dissodata di recente, voce derivata dal latino classico runco, runcare (sterpare, dissodare), giunto alla soglia dei nostri giorni nel medesimo significato con il verbo dialettale runcàa e con i toponimi derivati, che indicano luoghi del territorio utilizzato con precise caratteristiche; Runch, Runchett, Runcàsc, Runcutìn, ossia luoghi coltivati, a media/breve distanza dal centro abitato.[37] …
Nei dialetti alto novaresi, per indicare gli alpi si usano i termini di curt (mediato dal latino cohors inteso come spiazzo o radura) e di alp di origine celtica, insieme a quello di munt (monte) usato prevalentemente nell’alto Verbano per indicare gli alpi maggengali o primaverili, mentre quelli di piazza e di culma sono riservati agli alpi posti a ridosso di un colle.[38]
Possiamo, grazie alla toponomastica, ad esempio individuare l’origine quali “località in cui … venivano concentrate o confinate le greggi di capre” nel nome di molte località del Verbano e dell’Ossola derivati dai vocaboli dialettali di cavra e crava[39], come del duro lavoro di terrazzamento dei declivi nei vocaboli piaggia, campèi o pinezz[40].
La cultura materiale della civiltà montana è fondata sul legno e sulla pietra, le baite ne sono la testimonianza più duratura ed è grazie all’idioma locale che possiamo conoscerne e capire le diverse funzioni e il lavoro tecnicamente ingegnoso che hanno richiesto.
La bàita nel dialetto maleschese è chiamata casera (nome comune a tutta l’Ossola), mentre nel dialetto cossognese è la Casina, diminutivo/dispregiativo dell’italiano casa e del dialettale cà. Le bàite, anch’esse in origine costruite sommariamente per minime esigenze, come elementari ricoveri di fortuna […] fino a diventare, dopo il XVI secolo, i fabbricati utilizzati annualmente per la monticazione estiva, praticata fino a pochi decenni or sono.
Le bàite sono, di norma, costruzioni di modeste proporzioni, con vani alti non più di due metri. A seconda della loro utilizzazione, si dividono in «bàite da fuoco» (casér da fógh) e «baite per il bestiame» (casér dìi besti). Le prime, quasi sempre a un piano e sprovviste di soffitto sotto il tetto, venivano utilizzate per il lavoro domestico: cucinare e lavorare il latte; se la bàita era dotata di un piano superiore, quest’ultimo era adibito a rudimentale camera da letto; ma le bàite a due piani erano rare; in Val Grande poi, un lusso sconosciuto. Le «baite per il bestiame» erano quasi sempre a due piani, separate da un rudimentale assito, in cui il piano inferiore fungeva da stalla e quello superiore, comprendente anche il sottotetto, fungeva da fienile e da camera da letto, in cui il letto era il fieno medesimo.[41]
L’evoluzione delle lingue ha leggi simili a quelle biologiche: il distanziamento temporale e spaziale crea barriere (fra lingue / fra specie) comunicative e di reciproca fecondità. Come vi sono lingue che hanno mantenuto la loro trasparenza per parecchi secoli (e l’Italiano è una di queste) mentre altre, le cosiddette lingue giovani, a fatica si rapportano oltre i due o tre secoli, lo stesso vale per le culture. Il lavoro culturale sul passato, quando non è solo erudizione, è proprio quello di mantener viva (o di rivitalizzare) questa trasparenza che non solo ci dà conoscenza, comunicazione con il nostro passato, ma soprattutto fecondità di continuo rinnovabile. Da questo punto di vista gli scritti di Chiovini sono preziosi ed esemplari.
Nella “trilogia partigiana” un “volume” (Classe IIIa B) era dedicato a una eccezionale figura femminile (Cleonice Tomassetti) che solo grazie alla ricerca e alla scrittura di Chiovini riprende vita e implicitamente parola, emergendo dal silenzio a cui sarebbe stata altrimenti condannata. Lo stesso avviene, in questa seconda trilogia, con Sofia Benzi la cui epica vita di montanara, grazie alla memoria mediatrice del figlio Antonio è raccolta e ricostruita nelle pagine di “A piedi nudi”[42], quella che molti, a buon titolo, ritengono la sua opera letterariamente più intensa.
Il “dar voce” in questa opera viene più volte esplicitato: “Antonio, dialettalmente chiamato con il diminutivo Tugnìn … è il narratore di questa storia di Vallintrasca”[43]. Antonio Ruschetti, classe 1918, viene conosciuto da Chiovini all’interno della Rhodiatoce: operaio “nato a Caprezzo, ma che soltanto per metà era di Caprezzo, e per l’altra metà – quella materna – di Cicogna” mal si adattava, lui che era stato contadino, boscaiolo e cameriere, alla vita chiusa, monotona e gerarchizzata della fabbrica. Chiovini lo reincontra anni dopo, entrambi in pensione, e Antonio “mentre si mangiava … attorno al tavolo di un rifugio alpino” incomincia a raccontare con “fervida memoria … la storia della prima parte della sua vita … una storia personale e corale che andava riscoprendo il mondo scomparso.”
Quel giorno stesso presi i primi appunti […]. Successivamente prese forma un progetto: quello di perseguire la ricostruzione di alcuni aspetti della vita di allora nelle due valli Intrasche, attraverso la rappresentazione scritta di quella storia insieme personale e collettiva. Gli strumenti principali sarebbero stati, oltre alla fondamentale testimonianza di Antonio (mio «io narrante»), verificata fin dove era possibile attraverso confronti e documenti, quelli individuati in seguito: un succinto diario redatto da suo padre in gioventù […] e, più tardi, le notizie, le date, i nomi, i fatti che cominciai a strappare ai fascicoli degli archivi, alle collezioni dei giornali d’epoca, alle apparentemente aride pagine dei registri anagrafici parrocchiali e comunali che elaborai trasformandoli in alberi genealogici […] fino a farne parziale chiave di lettura della vita di villaggio.[44]
Quello che ne emerge è la narrazione, storicamente documentata, di una sorta di saga familiare: I Benzi originari di Giardinetto (Alessandria) trasferitisi a Cicogna, i Morandi, carbonai in Val Pogallo, provenienti da Torricella (Canton Ticino) e i Ruschetta, famiglia di Intragna i cui “rampolli” erano usi a “sciamare per il mondo in cerca di lavoro e di mitica fortuna”[45].
Saga famigliare che ha in Antonio il suo ultimo rappresentante e in sua madre, Sofia Benzi, il personaggio emblematico.
Sofia, nome di regine e principesse bizantine e Romanoff, era la quintogenita della famiglia di Pà Iachìn [Giacomo Benzi] e di Maria Boldini. Per la verità, l’atto di nascita dell’8 dicembre 1875 porta – non è possibile sapere se per errore o per una vampata di stramba esibizione di erudizione paterna – il più sofisticato nome di Soffida, ma fin dalla nascita la bimba fu chiamata con quello più semplice di Sofia, che finì per imporsi anche nei documenti anagrafici, dopo che divenne sposa e madre. Sofia, come le sorelle, crebbe contadina. Contadina e analfabeta, come le sorelle. […]
Sofia si stava trasformando in un’avvenente ragazza dai bei capelli castani leggermente ondulati nei giorni di festa, mediante l’artificio dell’acqua zuccherata. I suoi capelli non erano tanto lunghi, perché per la prima volta nel corso dell’adolescenza e per la seconda volta nella prima gioventù, li aveva venduti. Tagliati dall’uomo che una volta all’anno faceva il giro dei villaggi per acquistare i capelli dalle ragazze; li pagava bene …[46].
Sofia sposerà Stefano (Stévan) Morandi e andrà a vivere a Tregugno, un corte maggengale, sull’altro versante del rio Pogallo rispetto a Cicogna, e avrà da lui cinque figli (uno morto in tenera età) conducendo una vita da alpigiana con trasferimenti stagionali nei corti più in quota. Nel settembre 1913 “alla Soliva, nel fienile in cui dormivano i due sposi e i loro quattro figli”[47] a soli 37 anni Stévan muore di infarto tra le braccia della moglie. Ad aggravare la sua condizione di vedova con quattro figli – il maggiore, Giuseppe, aveva dieci anni – l’anno successivo un fulmine colpisce la stalla carbonizzando le due mucche di sua proprietà.
La situazione sembra poter cambiare quattro anni dopo: complice una capra che aveva cambiato gregge il Sacumàn (Giuseppe Ruschetti) vedovo di 52 anni, residente a Caprezzo, la conosce e “quando la donna sorrise di cortesia … all’uomo sembrò ringiovanire di colpo”; rimasta incinta del vedovo che si era fermato in alpe qualche giorno, si sposeranno mesi dopo ed è dalla loro unione che nasce appunto Antonio.
Il trasferimento di Sofia e dei suoi figli nel paese di Caprezzo non durerà molto: il secondo marito, uomo fatto di legno coriaceo, possidente fattosi da sé anche grazie a ricorrenti periodi di lavoro all’estero, si rivelerà presto un marito e padre padrone autoritario e violento. Prima i figli di prime nozze e poi la stessa Sofia lo abbandoneranno tornando a Tregugno. Una vita di alpeggio senz’altro più dura e povera di quella in paese, scelta da Sofia, allora quarantaquattrenne, con libera consapevolezza per il resto dei suoi giorni.
Antonio dopo un periodo di alternanza fra madre e padre, avrà con lei rapporti saltuari sempre meno frequenti e confronti non facili con i fratellastri sia di parte paterna che materna. E se il rapporto con la madre è stato per lui avaro di affetti sia per i sempre meno frequenti momenti di vicinanza che per il disagio interiore provocato dal conflitto fra i due genitori, da lei ha senz’altro ereditato la sua intensa capacità narrativa. Tredicenne, sale a Tregugno per portare un cesto di fichi alla madre e vi si ferma due giorni.
La sera del primo giorno la Sofia, riprendendo una vecchia abitudine che i figli ben conoscevano, la trascorse a raccontare al figlio, che provava piacere persino a riascoltare vicende già conosciute, storie tramandate da sua madre, ricordi d’infanzia e di gioventù (in fondo ai quali riaffiorava inevitabilmente la reminiscenza del suo Stévan), in cui manifestava le sue doti di narratrice, assecondata da un’eccezionale memoria, l’esercitata memoria degli analfabeti.
L’esercizio della memoria, che per analfabeti e semianalfabeti suppliva all’impossibilità di servirsi della scrittura, sia per scrivere sia per leggere, era l’antico strumento, utilizzato e affinato sin dal primo affermarsi della civiltà rurale montana (analogamente, ma più largamente che nelle altre società rurali) per trasmettere di generazione in generazione — mediante la parola, unico veicolo della comunicazione — le cronache e la storia del villaggio e della famiglia, le tradizioni, i costumi, le credenze, gli aneddoti, ossia tutto ciò che rappresentava quell’umile cultura.[48]
Capacità narrativa e viva memoria che rivive per noi tramite Chiovini che ne ha “raccolto la parola”.
Antonio ha trasfuso in ogni pagina (di questa storia di Vallintrasca), fino a quest’ultima, il ricordo del passato suo e della sua generazione …
Quel mondo scomparso rappresentava la riconosciuta e accettata civiltà della fatica quotidiana, del lavoro realizzato da mani con le palme di cuoio; la civiltà dei sentieri e delle mulattiere selciate e lastricate, dei geometrici terrazzamenti e, in fondo, dell’ottimismo collettivo, simboleggiato dal rituale saluto di congedo — alégher, allegri — che si scambiavano i suoi abitanti.[49]
E di questo mondo della fatica quotidiana, Sofia morta a 72 anni precipitando da una rupe mentre trasportava “scalza, naturalmente”, una gerla d’erba appena tagliata era la
plebea regina vissuta di lavoro, di dedizione, di devozione, e fino alla morte povera d’affetti, di gioie, di fortuna. E sempre, fino alla morte, sorretta dall’inobliabile memoria di una breve stagione d’amore.[50]
Con Le ceneri della fatica, edito postumo nel 1992, l’anno successivo alla sua scomparsa, se geograficamente Chiovini ci fa discendere di latitudine e di altitudine dagli alpeggi dell’alta Val Grande delle Cronache, e da quelli di Tregugno e della Soliva (A Piedi Nudi) per approdare al paese collinare di Ungiasca sovrastante l’attuale Verbania, questo apparente scostamento territoriale corrisponde ad un completamento e approfondimento della tematica delle due opere precedenti di cui questo lavoro
è fratello e parte integrante – un contributo alla conoscenza della civiltà rurale montana, al principio e durante la sua parabola discendente nel Verbano, e riferibile a un territorio ben più vasto di quello qui messo a fuoco.[51]
L’occasione che ha spinto l’autore è dovuta all’acquisizione di “due plichi di documenti (… per un totale di 181) concernenti abitanti ungiaschesi, in date comprese tra il 1695 e il 1850” a cui si aggiunge un duplice interesse tematico ed affettivo.
Tematico in quanto l’abitato di Ungiasca, presumibilmente nato come alpeggio maggengale di Unchio (come anche il toponimo suggerisce), divenuto a partire dal secolo XI “centro abitato permanente autonomo” e successivamente collegatosi “amministrativamente e canonicamente al più importante luogo di Cossogno” mantenendo comunque fino al 1815 “un’originale e caparbia autonomia”, rappresenta un esempio tipico di villaggio di Vallintrasca, con una sua vita e cultura comunitaria incentrata sulla attività agro-pastorale e collocato a metà strada tra quelli maggiormente isolati e poveri più in quota come Cicogna e Scareno e i borghi rivieraschi di Intra e Pallanza proiettati verso uno sviluppo commerciale, artigianale e successivamente industriale.
Affettivo perché quel paese è “stata la culla dei miei avi paterni” ed è da lui direttamente conosciuto e frequentato nelle abitazioni e nelle persone, sia nel paese che nei suoi corti maggengali e di monticazione estiva, in particolare quelli del Vréi (la conca d’Aurelio) a cui era salito la prima volta, a dieci anni, con suo padre in una mattina di estate, lasciandogli un ricordo indelebile.
Laddove il sentiero abbandonava il terreno boscoso, in quel punto alternato a estesi affioramenti rocciosi, mi ritrovai al principio del vasto terreno prativo della conca.
Mai avevo veduto in montagna tanto prato in una sola estensione. Prato costituito da tante «pezze» quanto erano i proprietari, denunciate dai tagli operati in tempi successivi o ancora intonse con erba e fiori svettanti verso l’alto. E, sparsi su quell’immensa mappa verde, i corti che mio padre andava menzionando mano a mano giungevano a tiro d’occhio. Nomi di corti che mi erano diventati familiari a Ungiasca, ma che ora prendevano corpo: corti con le minuscole casere ombreggiate da alberi d’alto fusto, per lo più frassini e noci. […]
Durante il pasto, consumato sullo spiazzo prospiciente il corte, assieme al racconto dei suoi ricordi salienti e più radicati, legati a quel luogo in cui fu iniziato alla mansione di pastorello durante il giornaliero pascolo del bestiame bovino, mio padre andava narrando episodi e aspetti della sua vita in quel corte, strettamente legata a quella della sua famiglia e delle altre famiglie della comunità ungiaschese e di tant’altre.[52]
Le tre diverse tipologie di fonti – quella documentale dei plichi acquisiti, arricchita dalla ricerca presso archivi comunali, parrocchiali e familiari, quella orale del padre e delle altre testimonianze raccolte[53], quella personale di esperienze e ricordi – si fondono in un unico percorso tematico. Se possiamo affermare che Chiovini (ri)dà qui voce a testimoni riemersi dagli antichi documenti e a quelli da lui ricercati e intervistati, il dar voce e parola principale mi sembra di poter affermare sia quello conferito ad un soggetto collettivo: la comunità ungiaschese che ci parla di sé, della sua storia e nel contempo esemplarmente testimonia nascita, fasi di crescita e successivo tramonto della civiltà rurale montana.
…dopo la vittoria dei comuni lombardi sul Barbarossa (1177) e la pace di Costanza (1183), la disgregazione del sistema feudale era giunta anche nelle nostre terre. Gli abitati collinari e montani andavano assumendo le caratteristiche di loci (lögh nella forma dialettale), mentre gli abitanti, già servi della gleba, affrancati dai tributi e dalle prestazioni gratuite dovuti al feudatario, si trasformavano in appartenenti a comunità autogestite attraverso proprie leggi (consuetudini e statuti) e istituti autonomi (assemblee vicinali e consigli di credenza), che si fondavano sulla lavorazione della terra e sull’allevamento del bestiame. Pur esistendo frange di possessi individuali di origine allodiale, prevalevano nettamente il possesso e l’uso comune della terra esterna alla cintura villica e del bestiame.
Era quindi in atto, similmente a quanto avveniva in tutti i territori dei due versanti dell’arco alpino e delle valli prealpine, la nascita e l’esistenza di un nuovo tipo di vita sociale e produttiva, che si differenziava da quelle sorte e in formazione nei comuni urbani e nelle campagne di pianura e di collina, per una larga autonomia dai centri di potere temporale tradizionale e di nuova formazione, tranne quelli di matrice spirituale rappresentati dalla chiesa cristiana. Quella società viene denominata civiltà rurale montana.
I territori verbanesi in cui si sviluppò quel tipo di civiltà furono quelli delle due valli Intrasche, dell’area collinare intrese.[54]
Una società essenzialmente basata su una economia di sussistenza, senza quasi differenziazioni sociali al suo interno e con la netta prevalenza della gestione collettiva dei beni (terre, bestiame), delle attrezzature (mulini, torchi, forni …) e dei lavori di trasformazione e manutenzione del territorio (terrazzamenti, irrigazione, rete viaria …). Nel rapporto con Intra e Pallanza con cui sono fitti gli scambi di prodotti si viene a costituire dalla fine del sec. XII una unità amministrativa territoriale, la “Comunità d’Intra Pallanza e Vallintrasca”, comprendente, oltre i due borghi lacustri, i sedici villaggi dei due rami della Vallintrasca[55] disposti nelle rispettive valli del San Bernardino e del San Giovanni. Comunità con un Podestà intrese ma con effettiva larga autonomia alle singole comunità di villaggio (i luoghi). Se l’autorità politica e soprattutto quella religiosa erano collocati a Intra, Chiovini sottolinea la netta preminenza demografica degli abitanti di Vallintrasca rispetto a Intra e Pallanza: si arriverà a un equilibrio fra le due popolazioni solo verso la metà dell’Ottocento[56].
Alla originaria fase di prevalenza della proprietà comunitaria subentra dalla metà del Cinquecento una seconda fase della società rurale montana: da comunitaria a parcellizzata “con l’acquisizione di campi, prati e persino corti, da parte di singoli nuclei familiari” (i ‘particolari’), mantenendo comunque gli organismi della comunità e la gestione collettiva con particolar riguardo alle aree boschive e ai pascoli. Tale processo di suddivisione proprietaria arriva a conclusione nel secolo successivo.
Le conseguenze più evidenti furono la sostituzione di parte del bestiame ovino con quello bovino, ritenuto più adatto e più redditizio in quel nuovo tipo di economia agricola e zootecnica. Ciò causò l’aumento di prodotti caseari e una diminuzione della produzione di lana e di carne ovina.[57]
La documentazione su Ungiasca permette di far luce sulla cultura, di quella e di analoghe comunità, che era egualitaria fra i diversi “fuochi” familiari, ma con nette divisioni rispetto ai “forensi” che venivano a collocarsi ai confini dei paesi, e all’interno delle famiglie allargate con ruoli distinti fra maschi e femmine, fra adulti e meno adulti, fra il capofamiglia che partecipa alle Vicinanze e gli altri. Era una cultura fondata sulla fatica quotidiana ma a suo modo equilibrata con periodi di riposo normativamente fissati: oltre alle domeniche le numerose feste religiose. La religione rappresentava infatti non solo un orizzonte di senso condiviso ma anche un potere normativo e giurisdizionale in una società composta in grande prevalenza – in totalità per le donne – da analfabeti per cui
l’anziano nel campo della memoria storica e della propagazione dello scibile connessi a quella società, esercitava da secoli un ruolo importante. Egli era un riconosciuto detentore del sapere, da cui derivava un’indiscussa autorità, che si tramutava in potere non codificato, ma esercitato e accettato, e che si palesava nel suo richiesto intervento quale autorevole testimone, arbitro, estimatore, narratore.
Il rapporto tra istituzione religiosa e popolazione verbanese nel XIV secolo era molto stretto e nel contempo anomalo. Era un legame religioso culturale su cui tuttavia prevaleva quello di consapevole dipendenza da un riconosciuto potere che aveva valore politico. La vita religiosa era semplice: si fondava sulla quotidiana preghiera e su alcune pratiche religiose rituali private e pubbliche.[58]
Una società normata da regole rigide, ma consapevolmente accettate, volte a mantenere l’equilibrio al proprio interno e con l’ambiente circostante.
Per quanto attiene il legname da ardere, va ricordato che veniva usato quasi esclusivamente per cuocere i cibi e per le esigenze di lavorazione casearia, e solo eccezionalmente per esigenze di riscaldamento di locali d’abitazione. Il patrimonio boschivo comunitario era stato sottoposto fin dal principio della formazione della società rurale montana a vincolo statutario o consuetudinario. […]
In generale, alla proibizione di tagliare legna nei boschi comunitari e a quella di produrre carbone — se non per comprovate necessità comunitarie e con il divieto di cederlo a forensi — si accompagnava la concessione di raccogliere legna morta, ma della quantità trasportabile all’abitazione in un solo viaggio giornaliero.[59]
Equilibrio che si riflette su un paesaggio “parecchio diverso da quello attuale”:
Quel che si presentava agli occhi dell’uomo del Seicento e del Settecento — e che da quell’epoca registrò una lenta involuzione fino alla metà del nostro secolo, per poi nel giro di tre decenni degenerare rapidamente a partire dalle fasce più esterne — era un paesaggio variegato e ordinato in cui, durante la stagione estiva predominavano il biondo chiaro dei campi di cereali e il verde rigoglioso e uniforme dei prati, che lasciavano spazio qua e là alle isole verde cupo di boschetti e gerbidi diligentemente tenuti sgombri da arbusti infestanti e da fogliame secco; o alle chiome maestose dei castagni da frutto, sotto cui vegetava un modesto fondo prativo. Le minuscole costruzioni rurali, sparse con avveduto criterio su quel territorio, testimoniavano la quotidiana operosità di persone e la compresenza del bestiame domestico.
Era, in conclusione, un paesaggio in cui l’effetto della mano dell’uomo era avvertito in modo continuo, sistematico, persino ossessivo, in cui quasi nulla sembrava crescere al di fuori della sua volontà: la produzione di beni era diventata la regola, la distruzione e lo spreco non trovavano spazio.[60]
Involuzione successiva del paesaggio che riflette il declino della cultura rurale montana sottoposta a spinte demografiche, migratorie, economiche e normative che la portarono ad una progressiva dissoluzione laddove la crescita economica ed industriale a valle non solo ha comportato, dalla metà ottocento in poi, una invertita distribuzione della popolazione fra montagna e cittadine rivierasche, ma un modello di sviluppo incompatibile con quello comunitario della civiltà rurale montana.
…era lo sviluppo industriale in atto che metteva a nudo e acutizzava antiche dignitose povertà, che scardinava i precedenti equilibri tra lavoro manuale e reddito, di fronte alle cui conseguenze gli abitanti dei villaggi erano completamente inermi, indotti ad abbandonare quanto restava delle loro attività e ad accettare il nuovo modello di sviluppo e le sue regole, o a consentire che quel modello minasse alle radici le loro possibilità di sopravvivenza sempre più stentata, fino a cancellare dalla montagna verbanese le strutture di quell’antica esperienza di vita.
Nei riguardi di quel crepuscolo e di quel tramonto la montagna verbanese fu completamente sola: la sua civiltà si stava estinguendo tra la generale indifferenza.[61]
Declino che ha subito una drastica e definitiva accelerazione con le distruzioni dell’ultima guerra e successivamente con l’espansione economica industriale del dopoguerra. Anche laddove “le fiamme dei rastrellatori” non hanno lascito il segno, come nei corti ungiaschesi dell’Alpe Aurelio, la trasformazione fu inevitabile, in molti casi l’abbandono totale dei campi invasi da “erica, felci e rovi” e con le casere progressivamente ridotte a rovine, in altri con “una modifica di destinazione d’uso” quali baite per i soggiorni di fine settimana ed estivi.
Nella conca d’Aurelio, l’ultimo baluardo della monticazione estiva, che resisteva solitario da una decina d’anni, cadde nel 1985, quando l’Ursulìn di Ungiasca «caricando» per l’ultima volta il curt Barnàrd con il bestiame ridotto a una mucca in menopausa, un asino divenuto recalcitrante al basto e a qualche pecora, simbolicamente scrisse l’ultima lettera della parola «fine» a un’epoca e a una civiltà divenute da tempo anacronistiche.[62]
Se in questo ampio lavoro di ricostruzione storica e testimoniale Chiovini ha voluto (ri)dar parola ad una società “fondata sul sentimento di solidarietà … e sull’operosità non competitiva … una società che fece onore al genere umano e a quello della natura che la ospitò”, ha inteso dare la parola anche a noi, nel senso che più volte, anche esplicitamente, ci interpella:
Che ci ha insegnato, che suggerimenti di fondo, di valore universale, ha espresso quella società rispetto a quella in cui viviamo? Non sembra intelligente eludere la risposta. [63]
Non sembra intelligente e nemmeno, aggiungerei, eticamente lecito “eludere la risposta” in particolare per noi che oggi viviamo anche il declino della successiva società industriale la quale, dopo aver promesso generale benessere, ci consegna un lascito di crescenti disuguaglianze sociali nonché di diffuso degrado e inquinamento ambientale a cui non sono estranee le odierne nuove malattie ed epidemie. Dovendo decidere in sostanza, per riprendere il significato profondo espresso da Chiovini nella titolazione e nella sua esplicitazione in premessa, se ci riferiamo alle Ceneri della fatica di quella cultura montana dei nostri avi unicamente come residuo cui possiamo anche esprimere ammirazione e nostalgia, oppure le leggiamo in profondità quale
“sedime fecondo che si posò sulla superficie della condizione umana come su di un terreno arato e insieme raffiguranti la memoria storica enciclopedica da custodire, da esaminare, da interpretare, affinché ci aiuti a scegliere i percorsi, ci faciliti il cammino sopra questa terra nel corso delle rispettive vite, nell’intento di individuare e di perseguire gli scopi della più accettabile natura umana.”[64]
L’altra trilogia
Ho sinteticamente ripercorso le due note trilogie di Chiovini; ve ne è anche una terza, quella delle opere che non ha voluto pubblicare in vita. Il diario partigiano “Fuori legge???”, uscito a puntate su Monte Marona[65] ma che poi, nonostante l’invito di Calzavara, non ha voluto raccogliere in volume, lo struggente racconto “La volpe”[66] e “Piccola storia partigiana della banda di Pian Cavallone”[67]. Sono opere che hanno direttamente al centro, sia pur con modalità di scrittura diverse (il diario, il racconto, la documentata ricostruzione critica), la figura stessa dell’autore. Si è detto di un riserbo, caratteristico della personalità di Chiovini, a parlare, anche indirettamente di sé. Io penso vi sia anche altro: “dar parola” è nettamente diverso dal “prender parola” e probabilmente Nino considerava questi scritti in qualche modo esterni all’orizzonte morale delle sue opere principali. Eppure se li andiamo a rileggere anche qui ritroviamo in alcuni passaggi e sezioni gli stessi tratti della moralità del “dar parola”.
Ad esempio, in Fuori legge???, la voce piangente di Nord, giovane partigiano originario di Vicenza, cui segue il passo, quasi manzoniano, dell’“Addio Albergo del Pian Cavallone” oramai avvolto dalle fiamme appiccate dai reparti fascisti della Legione Tagliamento.
Addio, Albergo del Pian Cavallone! Hai finito di ospitare i cenciosi soldati di un esercito senza capo, senza Stato Maggiore, senza artiglierie, senza direttive, spesso senza pane, senza armi.
Ti amavamo perché ricordiamo quando ci riparavi dal freddo, dalla tormenta. Ti amavamo perché lì, abbiamo indurito i muscoli, abbiamo trovato un senso della vita. Ora non sei altro che macerie e muri arrostiti dal fuoco, anneriti dal fumo, come ce ne sono a Milano, a Berlino, a Londra, a Cassino, dovunque sono passate le Divisioni vittoriose o le disordinate colonne in ritirata; dovunque è passata la guerra che vince sul vinto e sul vincitore: su gli uomini e sulle cose. La guerra perde soltanto di fronte a chi la odia, a noi. Dinanzi a Guido che preferiva starsene a casa a pescare, davanti a Bagat, che dice di essere salito perché non vuole andare in guerra, innanzi a Gabri che avrebbe voluto frequentare il Politecnico.[68]
E queste parole non possono non risuonarci dentro quando, andando al Rifugio, passiamo davanti ai resti dell’Albergo e a quella persiana metallica traforata dalle mitragliate fasciste. Oppure, se saliamo da Scareno all’alpeggio della Rocca, non possono non tornarci in mente le parole, gli scambi di informazioni ed anco e le facezie di quel gruppo eterogeneo di partigiani sopravvissuti al rastrellamento che lì si è radunato e, in attesa di poter ricostituire la formazione, si raccontano a vicenda le loro storie e le loro speranze[69].
Analogamente quando scendiamo da Trarego a Promé non può non ritornarci a mente il racconto de La Volpe che ci fa rivivere, come “in diretta”, quel 25 febbraio con gli occhi e il sentire del partigiano sopravvissuto, del “ragazzo”, che era allora Chiovini, e nel contempo lo sconcerto della popolazione locale di fronte a quell’eccidio e a quell’orrenda profanazione dei corpi, espresso con tipico riserbo dal montanaro che lo ha ospitato, il quale all’incalzare, il giorno successivo, delle domande del ferito risponde quasi a monosillabi.
Il braccio si è trasformato in una ridicola salsiccia violacea. La donna lo guarda con apprensione e si sente disarmata.
In quella entra l’uomo che torna dal lavoro:
Salute! Come va? Il ragazzo – risponde con un gesto amichevole del braccio sano.
Anche l’uomo si china ad esaminare il braccio e il suo viso cotto dal sole mantiene quell’aria imbarazzata di quando è entrato.
– Si sa qualcosa di preciso? – Gli chiede il ragazzo.
– Dicono che i fascisti se ne sono andati.
– No, no – incalza – dei miei compagni, dico.
– Mah… dicono che ci sono dei morti…
– Quanti? – Il ragazzo cerca di far l’indifferente per indurre l’uomo, che evidentemente sa, a vuotare il sacco.
Questi per poco sta in silenzio; poi, senza guardarlo, sbotta:
– Nove.
– Ma chi lo ha detto? e nella voce del ragazzo c’è ancora speranza.
– La gente.
– Li han visti?
– Si.
– Dove?
– Lo sai dove.
[…]
Il ragazzo si scuote per chiedere ancora:
– Siete proprio sicuro?
L’uomo risponde di si con il capo, perché il groppo gli serra la gola.
– Allora bisogna che vada – decide il ragazzo.
– Dove?
– Al comando.
– È meglio che stai qui fino a domani sera.
– No, no. Vado stasera. Se m’insegnate la strada per arrivare fino a …, poi il resto lo so.
– Senti – risponde l’uomo che ora pare più vecchio – qui puoi stare finché vuoi. Nessuno ti manda via; hai bisogno di riposare; poi, nel braccio devi aver dentro qualcosa.
– No, devo andare; così potrò anche farmi guardare il braccio.
L’uomo capisce che è inutile insistere; poi è troppo preso a frenare le lacrime. A mezzogiorno, invece di mettersi a mangiare con gli altri muratori, ha attraversato la valle ed è salito a vedere i ragazzi morti, che la gente del paese vicino aveva trasportato con le scale al cimitero inondato di mazzi di bucaneve e di sempreverde. Davanti ai loro corpi martoriati pensava: «speriamo che nessuna delle loro mamme veda come sono ridotti». E a piangere non aveva vergogna, perché lì tutti piangevano.
Tornando incrociò un pattuglione di militi e si sentì come se non avesse il denaro per comprare una medicina indispensabile a un suo figlio malato.
Il partigiano è pronto per la partenza: fuori si è già fatto buio. In cucina beve una tazza di caffelatte caldo, poi saluta cominciando dalla donna. La ringrazia e lei continua a cantilenargli materne raccomandazioni, infine l’abbraccia. L’uomo gli si avvicina con il sorriso mesto e sottomesso di chi, da generazioni, vive con poca speranza:
– Ciao; e ricordati che i fascisti non sono razza da stare sulla terra – poi gli stringe in fretta la mano e se ne va verso la camera, pentito d’aver detto uno sproposito. [70]
Ed infine, se non abbiamo letto la “Piccola storia partigiana della banda di Pian Cavallone”, come faremmo oggi a conoscere, al di là del nome poi assunto dalla Divisione che ha riunito tutti i partigiani del Verbano “di ogni colore”, la figura e il percorso di vita di Mario Flaim che lo ha portato dalla nativa Rovereto al rifugio del Pian Cavallone “in divisa di tenente degli alpini” con “una quindicina di uomini” e le sue parole di cristiano intransigente con cui ha rivendicato la sua scelta di combattere il fascismo, non escludendo la possibilità del martirio? Parole, che Flaim aveva espresso in una conferenza agli operai cattolici di Sant’Angelo Lodigiano “quando la sua decisione di partecipare alla lotta di liberazione è già operante”, a cui Chiovini ridà voce e delle quali riporto alcuni brevi stralci.
Così vogliamo andare verso la nostra patria: chini, in ginocchio, e chiederle perdono. Ecco dinnanzi a te i tuoi figli; essi ti colpirono, essi ti hanno tradita, ma pur anch’essi hanno sofferto per te, per te hanno lanciato la loro vita al di là della morte. Chiudi nelle profondità misteriose ogni amarezza e accogli sul tuo altare, in segno di riparazione feconda, il sangue di quelli che sono morti mormorando il tuo nome. […]
Mobiliteremo le nostre energie, raccoglieremo con devozione l’esempio luminoso dei grandi che resero illustri le antiche nostre tradizioni, e sorgerà ancora su tante rovine, su tanto disperato sacrificio un nuovo spirituale rinascimento che irradierà di sé tutte le genti. Solo una preghiera io depongo ai tuoi piedi, Cristo, mentre piangi sopra Gerusalemme. Fa che questo avvenga per virtù nostra italiana, per faticosa opera nostra. […]
Credo che non tornerò. Fate che le mie ossa riposino in questa terra Barazina, dove arrivai come un vinto e donde riparto soldato. Per la mia tomba chiedo alla vostra pietà qualche umile fiore, che sia bianco, però.[71]
Flaim cadrà durante il rastrellamento della Val Grande il 17 giugno sulla Marona nel tentativo di rallentare l’avanzata delle truppe tedesche e il suo corpo sarà ritrovato “sulle balze occidentali sottostanti la cima” con altri dieci caduti di cui quattro restati senza nome. A Mario Flaim “simbolo dell’unità” di tutte le anime della resistenza è oggi titolato il Palazzo sede del Consiglio comunale di Verbania e la piazza adiacente.
Una mission per il Parco letterario
Se il “dar parola”, il “dar e ridar voce” rappresenta la specifica ed intrinseca moralità che impregna la totalità delle opere di Chiovini, il neonato Parco Letterario intestato a suo nome non può limitarsi al pur fondamentale compito di una offerta culturale ed escursionistica innovativa, ma deve anch’esso impregnarsi dell’assunto morale di questo “dar parola” sia a chi oggi non c’è più, ma ha lasciato cospicue tracce sul nostro territorio – i resti dell’oramai scomparsa “civiltà rurale montana, i cippi e i monumenti dei caduti della lotta partigiana –, sia a tutti coloro che ancor oggi gravitano a ridosso della Val Grande, in comunità spesso marginalizzate dai principali flussi economici e comunicativi.
Una mission che impegna i due enti, Parco Nazionale della Valgrande e Casa della Resistenza, che lo hanno progettato e istituito in accordo con la Società Italiana del Paesaggio, a coinvolgere non solo come fruitori, ma come soggetti attivi, turismo culturale ed escursionistico e comunità locali nella costruzione di una memoria viva e di continuo rinnovata.
Bibliografia degli scritti di Nino Chiovini
“Io di politica non me ne voglio interessare” in Monte Marona n. 7, 23.05.1945, Verbania (firmato Peppo)
“… e tu a che partito sei iscritto?” in Monte Marona n. 9, 7.06.1945, Verbania (firmato Peppo)
“Vola” in Monte Marona n. 12, 21.06.1945, Verbania (firmato Peppo)
“Fuori Legge ??? Diario di un partigiano nel Verbano”, 36 puntate in Monte Marona, Verbania, dal n. 15 del 6 ottobre ’45 al n. 54 del 10 luglio del 1946 (firmato enneci); riedizione parziale delle puntate 17-23 (dal 12 giugno al 29 giugno 1944) in Resistenza Unita n.6, giugno 1989
“25 Febbraio. Volante ‘Cucciolo’ a Trarego” in Monte Marona n. 34, 20.02.1946, Verbania (non firmato)
Verbano, giugno quarantaquattro, Comitato della Resistenza, Verbania 1966, p. 71
I giorni della semina 1943 – 1945, Comitato per la Resistenza nel Verbano, Comune di Verbania 1974, p. 140 (riedizioni come I giorni della semina: Vangelista, Milano 1974, 1979 e 1995, p. 155; Tararà, Verbania 2005, p. 159 con prefazione di Oscar Luigi Scalfaro)
“Nino Chiovini sulle trattative e sulla liberazione dell’Ossola” in Resistenza Unita n. 3, marzo 1974, Novara (lettera firmata)
“Fondotoce fra passato e presente” in Resistenza Unita, supplemento al n. 5, maggio 1979, Novara
“Sulle sponde del Ticino nell’inverno del ’43”, in Resistenza Unita n. 1, gennaio 1980, Novara
“Due giorni prima avevo compiuto dodici anni” in Resistenza Unita n. 6, giugno 1980, Novara (ripubblicato in Mal di Valgrande)
Val Grande partigiana e dintorni. 4 storie di protagonisti, Margaroli, Verbania 1980, p. 123 (riedizione: Comune di Verbania – Comitato della Resistenza, Verbania 2002, p. 126 con prefazione di Erminio Ferrari e un ricordo di giuseppe Cavigioli)
Classe IIIa B. Cleonice Tomassetti. Vita e morte, Comitato per la Resistenza nel Verbano, Comune di Verbania, 1981, p. 66 (riedizione parziale in Resistenza Unita n. 6, giugno 1992; ristampa nel 1994); nuova edizione di Tararà, Verbania 2010 (a cura di Gianmaria Ottolini, prefazione di Maria Silvia Caffari, annotazioni storiche di Mauro Begozzi e Gianmaria Ottolini)
“Il ’44 sulle sponde del Lago Maggiore” in Novara n. 1/81, Camera di Commercio di Novara, 1981
“Note sul battaglione partigiano Taurinense in Jugoslavia” in Novara n. 2/81 Camera Commercio di Novara, 1981
“Quando stava per sorgere l’alba di un mondo nuovo. Nel Verbano”, in Resistenza Unita nn. 4/5, aprile-maggio 1981, Novara
“Partigiani e ‘sfrusitt’ nell’Alto Novarese” in Ieri Novara Oggi, n. 5, Novara 1981, p. 117-140
“Precisazione”, in Resistenza Unita n. 11, novembre 1981, Novara (a proposito della manifestazione di Pala di Miazzina)
“La divisione ‘Garibaldi’ in Jugoslavia” in Resistenza Unita n. 12, dicembre 1981, Novara
Quando la morte non ti vuole di E. Liguori, Alberti, Verbania 1981 (curatore e prefatore)
“Ho conosciuto Nicola Mari” in Resistenza Unita nn. 4/5, aprile-maggio 1982, Novara
“Partigiani all’estero” in Resistenza Unita nn. 4/5, aprile-maggio 1982, Novara
“Per non gridare alle pietre” in Resistenza Unita n. 6, giugno 1982, Novara (firmato n.c.)
“In biblioteca. Quando la morte non ti vuole” in Resistenza Unita n. 9, settembre 1982, Novara
A Trarego per la libertà, Comune di Verbania 1982 (ristampa 1995)
Il Verbano tra fascismo antifascismo e resistenza, Comune di Verbania, 1983, p. 22 (dispensa per L’Università della terza età)
“Storie d’anteguerra in Val Grande” in Verbanus n. 4, Alberti, Verbania 1983 (ripubblicato in Mal di Valgrande)
“Formazioni partigiane e popolazione dell’Alto Novarese durante il rastrellamento del giugno 1944”, in Novara Provincia 80, n. 2, Novara 1984
“Un altro modo di scrivere di Resistenza. Ancora su ‘Viva Babeuf!’ di Gino Vermicelli”, in Il VCO, n. 10 del 19.5.1984, Verbania, p. 9
“Mario Flaim: sulle montagne del Verbano un testimone della fede e della libertà” in Il Verbano, 9.06.1984, Verbania; tratto dall’inedito “Piccola Storia partigiana della Banda di Pian Cavallone” (cap. VI – VIII), pubblicato con la presentazione, e intercalato da commenti, di G. Cacciami
“Otto giorni di libertà a Cannobio” in Il VCO, 6.10.1984, Verbania
“Andare a sachìtt” in Novara n.1/84, Camera di Commercio di Novara, 1984 (ripubblicato in Mal di Valgrande)
Gli alpini dell’Intra in Jugoslavia: Piero Zavattaro Ardizzi e i suoi uomini in quindici mesi di guerra partigiana in Montenegro e in Bosnia di G. Scotti: schede biografiche e note di N. Chiovini, Comitato per la Resistenza nel Verbano, Verbania 1984, p. 113
“I corti di Velina” in Novara n.4/85, Camera Commercio di Novara, 1985 (riedizione: Alberti, Verbania 1986; ripubblicato in Mal di Valgrande)
“A Verbania Borghese si arrende” in Resistenza Unita nn. 4/5, aprile-maggio 1985, Novara
“25 aprile” in Il VCO, 24 aprile 1985
“8.9.1943 nella Francia meridionale. In quei giorni ad Albertville” in Resistenza Unita nn. 1/2, gennaio-febbraio 1986, Novara
“Di nome vipera” in Eco Risveglio Ossolano del 20.02.86, Domodossola 1986
“Dialetti delle valli Anzasca e Intrasca. Studio inedito del XIX secolo di Giuseppe Belli e di altri autori”, in Novara n. 2/86 e 4/86, Camera di Commercio di Novara, 1986
Cronache di terra lepontina. Malesco e Cossogno: una contesa di cinque secoli, Vangelista, Milano 1987, p. 202 (riedizione: Tararà, Verbania 2007, p. 190)
“La liberazione di Cannobio nei documenti dell’Archivio Centrale dello Stato” in Novara n. 2/87, Camera di Commercio di Novara, 1987 (con A. Mignemi)
“Giugno 1944. Rastrellamento in Valgrande. Cronaca di una sconfitta” in Resistenza Unita n. 6, giugno 1987, Novara
“Appunti di storia sociale della Val Grande”, relazione al Convegno Val Grande ultimo paradiso, Verbania 19.09.1987
“Ricordo di Dionigi Superti. Un partigiano vero e saggio” in Resistenza Unita n. 3, marzo 1988, Novara
“Spigolando in biblioteca. Le aquile delle montagne nere” in Resistenza Unita n. 7, luglio 1988, Novara
A piedi nudi. Una storia di Vallintrasca, Vangelista, Milano 1988, p. 186 (riedizione: Tararà, Verbania 2004, p. 195)
“Ungiasca perduta” in Verbanus n. 9/88, Alberti, Verbania 1988
“Medaglia di Bronzo a Gastone Lubatti. Ma perché non d’oro?” in Resistenza Unita n. 11, novembre 1988, Novara
“Addio alle armi”, in Le Rive n. 1/89, pp. 56 – 58, Domodossola 1989 (ripubblicato in Mal di Valgrande)
“Cuggiono: un paese nella Resistenza” in Resistenza Unita n. 10, ottobre 1989, Novara, disponibile in rete: http://win.ecoistitutoticino.org/resistenza/cuggiono-nascita-della-resistenza.htm – ultima visita 1.02.2020 –
“Giuseppe Bosco Bagat” in Resistenza Unita n. 10, ottobre 1989, Novara
“Incisioni rupestri nell’area Verbano-Cusio” in Bollettino Storico per la Provincia di Novara n. 1/90, pp. 143 – 152, Novara 1990 (con A. Biganzoli)
“Grandiccioli: montagna fra i laghi” in Le Rive n. 1/90, pp. 54 – 55, Domodossola 1990
“Intra, Pallanza e il retroterra montano” intervento al convegno “Comuni, Province e disegno del territorio”, Verbania 23-24 marzo 1990, trascrizione a c. A. Mignemi, disponibile c/o ISRN, non pubblicato
“Verbania minore” in Le Rive n. 3-4/90, pp. 54 – 77, Domodossola 1990
“La storia del Lin” in Le Rive n. 5/90, pp. 41 – 44, Domodossola 1990
“Il ‘racconto’ di Nino Chiovini, in Il Cobianchi, Verbania 1990, pp. 34 – 38
“Impressioni e ricordi. Da Cannobio a Domodossola” in Resistenza Unita n. 10, ottobre 1990, Novara
“Il borgo di Sant’Ambrogio” in Le Rive n. 2/91, Domodossola 1991
“Da Villa Caccia Piatti a Villa Pos: due secoli di storia” in Le Rive n. 5/91, Domodossola 1991
Mal di Valgrande, Vangelista, Milano 1991, p. 141 (riedizione: Tararà, Verbania 2002, p. 184 con prefazione di Erminio Ferrari)
Le ceneri della fatica, Vangelista, Milano, 1992, p. 256 (riedizione: Tararà, Verbania 2019, p. 239)
“La volpe” in Verbanus n. 18, Verbania 1997, pp. 354-368; riedito in: Istituto Cobianchi, Memoria di Trarego, Verbania 2003, pp. 154-164 (nuova ed. Tararà, Verbania 2007, pp. 160 – 169)
Fuori legge ??? Dal diario partigiano alla ricerca storica, Tararà, Verbania 2012, p. 271 (prefazione di Gianmaria Ottolini; postfazione di Mauro Begozzi)
Piccola storia partigiana della banda di Pian Cavallone, Tararà, Verbania 2014, p. 127 (note iniziali di Lidia Chiovini; introduzione di Gianmaria Ottolini)
[1] Dalla presentazione del progetto “Parco Letterario “Nino Chiovini” – Luoghi e memoria: il Patrimonio etno-antropologico e la Resistenza come fattori di conoscenza, di partecipazione e di produzione culturale”. Il Progetto completo è visionabile > qui < .
[2] Una guerra civile. Saggio storico sulla moralità nella Resistenza, Bollati Boringhieri, Torino 1991. Il titolo è editoriale, quello originario dell’autore è nel sottotitolo. Per un approfondimento cfr. > qui < .
[3] In Nino Chiovini, Val Grande partigiana e dintorni. 4 storie di protagonisti: Maria Peron, Dionigi Superti, Alfonso Comazzi, Gianni Cella, 2a edizione per conto del Comune di Verbania – Comitato della Resistenza, Verbania 2002, p. 9 – 10. Evidenziazioni mie.
[4] In Nino Chiovini, Mal di Valgrande, 2a edizione, Tararà, Verbania 2002, p. 8. Evidenziazioni mie.
[5] Ivi, p. 12.
[6] Comune di Verbania, 1983, p. 22 (dispensa per L’Università della terza età). Riportata in Fuori legge ??? Dal diario partigiano alla ricerca storica, Tararà, Verbania 2012, p. 203-237.
[7] Ivi, p. 23.
[8] In Nino Chiovini, Mal di Valgrande, Vangelista, Milano 1991, p. 6. La seconda edizione (cfr. nota 4) non riporta questo elenco di 24 testimoni.
[9] Guerriglia nel mondo dei vinti, in Valgrande partigiana cit. p. 15 – 31. Il saggio inizia con questa citazione di Nuto Revelli che anticipa la problematicità tematizzata del rapporto fra i due mondi: i partigiani da un lato e i contadini di montagna, dall’altro.
“Forse in quel mondo di poveri, dove la paura e la solidarietà si confondevano, eravamo più padroni che ospiti. Forse chiedevamo troppo. Era la guerra che soprattutto contava. ‘A questa gente, dicevamo, penseremo poi’.” (Il mondo dei vinti, Einaudi, Torino 1977, pag. XX).
[10] Mal di Valgrande, ed 1991, p. 113 – 119.
[11] Edito a cura del Comitato permanente Verbanese della Resistenza e del Circolo Nuova resistenza con il patrocinio del Comune di Verbania nel XX della Repubblica e nel XXII anniversario di Fondotoce.
[12] I giorni della semina 1943 – 1945, Comitato per la Resistenza nel Verbano, Comune di Verbania 1974, p. 140 (riedizioni: I giorni della semina, Vangelista, Milano 1979 e 1995, p. 155; Tararà, Verbania 2005, p. 159).
[13] I giorni della semina, Tararà, Verbania 2005, p. 99-100.
[14] Teresa Binda (1900 – 1944), madre vedova del giovane partigiano Gianni Saffaglio (1925 – 2017), salita in ValGrande per trovare il figlio fu bloccata in valle dall’inizio del rastrellamento e lo seguì nella ritirata della colonna Muneghina. Al rientro a Verbania, riconosciuta da un fascista prigioniero poi liberato durante il rastrellamento, fu arrestata nella sua casa di Suna e fucilata a Beura Cardezza assieme a otto partigiani il 27 giugno 1944. Insignita della Medaglia d’oro al Merito Civile il 14 febbraio 2008.
[15] I giorni della semina cit., p. 71.
[16] Ivi p. 93.
[17] Val Grande partigiana e dintorni. 4 storie di protagonisti. Maria Peron, Dionigi Superti, Alfonso Comazzi, Gianni Cella, Margaroli, Verbania 1980, p. 7.
[18] Ivi, p. 25-45.
[19] Ivi, p. 47-68.
[20] Resistenza Unita, n. 3, marzo 1988. Ripubblicato in Fuori legge ??? Dal diario partigiano alla ricerca storica, Tararà, Verbania 2012, p. 121-124.
[21] Val Grande partigiana ecc. cit. p. 69-107.
[22] Organizzazione Todt. Costituita dal Ministro tedesco degli Armamenti e della produzione bellica, Fritz Todt, divenne operativa in tutti i paesi europei occupati con mansioni di edilizia militare. Chi aderisce viene esentato dal servizio militare per cui vi affluiscono renitenti, disertori, anche ex partigiani ecc. che vivono così in una situazione dove l’ingaggio tedesco li sottrae legalmente da qualsiasi rappresaglia fascista. Vi aderiscono operai provenienti da tutte le regioni occupate dai tedeschi. Molti anche dal VCO. Complessivamente la Todt arriverà a contare 240.000 operai. In alcuni casi operai addetti a particolare mansioni, come Comazzi, furono costretti ad arruolarsi nella Wermacht.
[23] Val Grande partigiana ecc. cit. p. 105-119.
[24] Cfr. Mino Ramoni, Vincenzo Adreani. Primo sindaco di Verbania. Il sindaco della liberazione (1883-1948), VB/doc, Verbania 2009, p. 64-68 e Orazio Barbieri, I sopravvissuti, Feltrinelli, Milano 1972, p. 36-50 (riedito ed. Pentalinea, Prato, 1999, p. 42-60).
[25] Emilio Liguori, Quando la morte non ti vuole. (I casi di un giudice istruttore al tempo della grande tormenta), in Verbanus n. 2, 1980, Alberti libraio editore, p. 140-212. Poi riedito isolatamente: Alberti 1981.
[26] Ivi, p. 173. Corsivi miei.
[27] Anche sulla sua tomba, al Cimitero Maggiore di Milano (Campo di Gloria n. 64), sulla sua lapide (n. 443) il cognome è erroneamente indicato come Tomasetti.
[28] Su queste mitizzazioni e su come Chiovini abbia dato il contribuito fondamentale al recupero della memoria di questa donna straordinaria, cfr., su questo stesso blog, Cleonice. Il lungo cammino della memoria. Una bella lettura al femminile è quella di Maria Minola: Tomassetti Cleonice, l’alchimista.
[29] Classe IIIa B. Cleonice Tomassetti. Vita e morte, Tararà, Verbania 2010, p. 35.
[30] Ivi, p. 43-44.
[31] Ivi, p. 68.
[32] Cronache di terra lepontina. Malesco e Cossogno: una contesa di cinque secoli, Vangelista, Milano 1987 (riedizione Tararà, Verbania 2007).
[33] Ivi, p. 200.
[34] Ivi, p. 15.
[35] Ivi, p. 200.
[36] Ivi, L’idioma di una civiltà estinta, p. 93-102.
[37] Ivi, p. 25.
[38] Ivi, p. 36.
[39] Ivi, p. 38.
[40] Ivi, p. 39.
[41] Ivi, p. 104-105. L’analisi tecnica e terminologica della struttura delle baite e, in particolare, del tetto in pietra (piòd) che richiedeva competenze specifiche – quelle del teciàtt –sono descritte in modo particolareggiato nelle pagine successive.
[42] A piedi nudi. Una storia di Vallintrasca, Vangelista, Milano 1988 (riedizione: Tararà, Verbania 2004).
[43] Ivi, p. 119.
[44] Ivi, p. 12-13.
[45] Ivi, p 89.
[46] Ivi, p. 63.
[47] Ivi, p. 112.
[48] Ivi, p. 152-153.
[49] Ivi, p. 185-186.
[50] Ivi, p. 181.
[51] Le ceneri della fatica, Vangelista, Milano 1992, p. 7 (riedizione: Tararà, Verbania 2019).
[52] Ivi, p. 218.
[53] Gli archivi consultati (12) e le testimonianze raccolte (13) sono indicate all’inizio: cfr. Ivi, p. 6.
[54] Ivi, p. 16-17.
[55] Oggi per Vallintrasca si intende solo la valle del San Giovanni (Valle Intragna), mentre storicamente e nei testi di Chiovini viene compresa anche la valle del San Bernardino, il torrente che nasce a ponte Casletto dalla confluenza del Rio Grande e del Rio Pogallo. L’uso al plurale (le Vallintrasche) risolve il possibile equivoco.
[56] Ivi, p. 191.
[57] Ivi, p. 43.
[58] Ivi, p. 171.
[59] Ivi, p. 165-166.
[60] Ivi, p. 164-165.
[61] Ivi, p. 192-193.
[62] Ivi, p. 255-256.
[63] Ivi, p. 194.
[64] Ivi, p. 10.
[65] Cfr. Il diario partigiano di Nino Chiovini. Il diario è stato poi ripubblicato integralmente in Fuori legge ??? Dal diario partigiano alla ricerca storica, Tararà, Verbania 2012.
[66] Pubblicato postumo sulla rivista Verbanus n. 18, Verbania 1997, pp. 354-368 e riedito in: Istituto Cobianchi, Memoria di Trarego, Verbania 2003, pp. 154-164 (nuova ed. Tararà, Verbania 2007, pp. 160 – 169).
[67] Pubblicato da Tararà, Verbania 2014.
[68] Fuori Legge, ed. cit., p. 61.
[69] Ivi, p. 82-84.
[70] In Verbanus n. 18, Verbania 1997, pp. 366-368.
[71] Piccola storia partigiana della banda di Pian Cavallone, Tararà, Verbania 2014, p. 84-86.

Dall’8 marzo, viste le restrizioni di movimento man mano intensificatesi, giornalmente ho postato su facebook una o più foto tratte dall’archivio digitale dei miei viaggi degli ultimi anni. Un modo per riguardare e richiamare alla mente – e agli occhi – luoghi e artisti che avevo apprezzato o che mi avevano comunque colpito; nel contempo, ai tempi del #iorestoacasa, una modalità per tener aperti i contatti con i miei amici digitali. Frattali di bellezza e pertanto di speranza.
Di seguito la nona e decima settimana di fotografie con i testi (didascalie e talvolta qualcosa di più) e i link che le accompagnavano. Ho poi concluso con il 71mo giorno (17 maggio), antecedente alla riapertura e all’alleggerimento sostanziale delle misure di contenimento.
Visite virtuali al tempo del COVID-19 (mese 2 – giorno 26) #iorestoacasa
Jannis Kounellis (Pireo 1936 – Roma 2017), Senza titolo, 1991
Artista greco, naturalizzato italiano, è uno dei massimi esponenti in Italia della corrente dell’Arte povera, di un’arte povera non minimalista, si è detto. Ama infatti installazioni scenografiche di forte impatto. Questa opera apre la collezione permanente “L’irruzione del contemporaneo” al Mart di Rovereto dedicata ai linguaggi artistici che, a partire dagli anni ’50 del secolo scorso, hanno reinventato pittura e scultura “superando la spazio astratto della cornice e del piedistallo, sconfinando nello spazio della vita”.
“Io sono un pittore: sono un visionario, ma non dipingo.
Vorrei guadagnare la visione, cioè ciò che all’inizio era il quadro.
È la visione il mestiere del pittore”.
Visite virtuali al tempo del COVID-19 (mese 2 – giorno 27) #iorestoacasa
Mario Merz (Milano 1925 – Torino 2003): Chiaro Oscuro, 1983.
Altro artista approdato all’arte povera; dopo il periodo delle scritte luminose al neon che riproponevano gli slogan del 1968, le installazioni di igloo lo caratterizzano per tutto il periodo successivo. Con l’utilizzo dei materiali più diversi l’autore – come si afferma nella presentazione di una mostra dello scorso anno all’Hangar Pirelli Bicocca –“indaga e rappresenta i processi di trasformazione della natura e della vita umana: in particolare gli igloo, visivamente riconducibili alle primordiali abitazioni, diventano per l’artista l’archetipo dei luoghi abitati e del mondo e la metafora delle diverse relazioni tra interno ed esterno, tra spazio fisico e spazio concettuale, tra individualità e collettività. Queste opere sono caratterizzate da una struttura metallica rivestita da una grande varietà di materiali di uso comune, come argilla, vetro, pietre, juta e acciaio – spesso appoggiati o incastrati tra loro in modo instabile – e dall’uso di elementi e scritte al neon” (https://pirellihangarbicocca.org/mostra/mario-merz-igloos/#)
“Chiaro Oscuro” fa parte della permanente contemporanea al Mart di Rovereto. Questo il commento in loco: «Alla ricerca dei principi che regolano le energie della natura, a partire dal 1968 Mario Merz realizza gli igloo: strutture circolari che rimandano alle pratiche essenziali dell’umanità, come costruire una casa, pensare il cosmo o esplorare il mondo. In linea con la pratica di Merz, in “Chiaro Oscuro” l’artista compone l’installazione come un demiurgo che trasforma e mescola forme e materiali artificiali e naturali, pieni e vuoti, superfici chiare e oscure nel tentativo di connettere archetipi, esaltarli e attivarli».
Visite virtuali al tempo del COVID-19 (mese 2 – giorno 28) #unpocoesco
Armando Testa (Torino 1917-1992), Punt e Mes (variazioni 1960-62) e Sedie con matita (1972).
Oggi un autore che si colloca tra arte contemporanea e grafica, tra ironia dadaista e pubblicità. Visto che è lecito uscire un po’, possiamo brindare ma non sederci.
Al Mart nel 2017, in occasione del centenario della sua nascita, era allestita la temporanea “Tutti gli ‘ismi’ di Armando”. Di seguito l’introduzione:
«Scrivendo in merito al Futurismo e alla vita moderna, nel 1928 Fortunato Depero annotava: “L’arte dell’avvenire sarà potentemente PUBBUCITARIA. Tale profetica affermazione ha trovato riscontro nel corso del Novecento e del nuovo millennio in forme espressive che contaminano le discipline, superano lo specifico delle arti e prendono coscienza del ruolo della comunicazione e dell’attivo contributo dei media nel dare forma alla società e al proprio tempo.
In tale scenario il Mart coglie l’occasione del centenario della nascita per celebrare il genio di Armando Testa (1917-1992). Personaggio dall’inesauribile curiosità e inarrestabile fantasia, Testa ha saputo trasferire le sperimentazioni delle avanguardie artistiche nell’immaginario collettivo moderno. Come suggerisce il titolo della mostra, manifesti, caroselli, sculture e dipinti mettono in luce le connessioni con i principali “temi” del Novecento: il dinamismo del Futurismo, la composizione dell’Astrattismo, i paradossi visivi del Surrealismo o gli slittamenti semantici del Dadaismo. Le dichiarazioni dell’autore, estratte da interviste storiche dell’Archivio Rai, orientano un percorso che evidenzia gli omaggi a grandi maestri del XX secolo come Piet Mondrian, Pablo Picasso, John Cage e approfondisce alcuni temi affrontati da Armando Testa in una relazione talvolta fondata e, in altri casi, ironica e divertita rispetto ai motivi più profondi dell’arte contemporanea. Al centro del suo interesse vi è sempre l’idea del “moderno” come istanza che si impone nella necessità di corrispondere alla velocità e alle dinamiche del cambiamenti sociali dell’Italia del dopoguerra. Armando Testa è un protagonista fondamentale della nostra epoca esibendo la straordinaria capacità di determinare un immaginario popolare che investe la vita quotidiana, accompagna le Innovazioni del modi di produzione, crea nuovi miti attraverso l’elaborazione di aggiornate tecniche di comunicazione che, nella loro straordinaria sintesi, continuano a offrirsi all’analisi e al piacere di interminabili divagazioni per indagini semiotiche, riflessioni sociologiche e pratiche artistiche dell’attualità.»
Visite virtuali al tempo del COVID-19 (mese 2 – giorno 29) #unpocoesco
Fortunato Depero (Fondo 1892 – Rovereto 1960), Casa d’arte futurista Depero
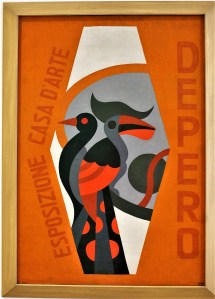 Se nel 1918 nascono in Italia un certo numero di Case d’arte futuriste a partire da quella di Prampolini a Roma, questa fondata l’anno dopo a Rovereto era, nella concezione dell’artista, un’officina di arti applicate (arazzi, marionette, grafica pubblicitaria …) ed è successivamente diventata un vero e proprio museo. Dal 1989 è incorporato nel Mart (Museo d’Arte Moderna e Contemporanea di Trento e Rovereto) e nel 2009 è stato restaurato e ristrutturato su progetto dell’architetto Renato Rizzi.
Se nel 1918 nascono in Italia un certo numero di Case d’arte futuriste a partire da quella di Prampolini a Roma, questa fondata l’anno dopo a Rovereto era, nella concezione dell’artista, un’officina di arti applicate (arazzi, marionette, grafica pubblicitaria …) ed è successivamente diventata un vero e proprio museo. Dal 1989 è incorporato nel Mart (Museo d’Arte Moderna e Contemporanea di Trento e Rovereto) e nel 2009 è stato restaurato e ristrutturato su progetto dell’architetto Renato Rizzi.
Questa l’autopresentazione sul sito:
 “Quando vivrò di quello che ho pensato ieri, comincerò ad avere paura di chi mi copia”. (F. Depero) «La Casa d’Arte Futurista Depero è l’unico museo fondato da un futurista – lo stesso Depero, nel 1957 – in base a un progetto dissacrante e profetico: innovazione, ironia, abbattimento di ogni gerarchia nelle arti. L’edificio si trovava nell’elegante centro storico della Rovereto medioevale. Depero, un vero pioniere del design contemporaneo, curò personalmente ogni dettaglio: i mosaici, i mobili, i pannelli dipinti. Morì nel 1960, poco dopo l’apertura. Il 17 gennaio 2009, in occasione del centenario del Futurismo, il Mart ha dato una seconda vita a Casa Depero. Un complesso restauro, firmato dall’architetto Renato Rizzi, ha recuperato le zone originali progettate dall’artista, completandole con due nuovi livelli ispirati direttamente al gusto di Fortunato Depero. Dentro si possono ammirare, esposti a rotazione, circa 3000 oggetti lasciati dall’artista alla città, fra dipinti, disegni, tarsie in panno, grafiche e giocattoli.
“Quando vivrò di quello che ho pensato ieri, comincerò ad avere paura di chi mi copia”. (F. Depero) «La Casa d’Arte Futurista Depero è l’unico museo fondato da un futurista – lo stesso Depero, nel 1957 – in base a un progetto dissacrante e profetico: innovazione, ironia, abbattimento di ogni gerarchia nelle arti. L’edificio si trovava nell’elegante centro storico della Rovereto medioevale. Depero, un vero pioniere del design contemporaneo, curò personalmente ogni dettaglio: i mosaici, i mobili, i pannelli dipinti. Morì nel 1960, poco dopo l’apertura. Il 17 gennaio 2009, in occasione del centenario del Futurismo, il Mart ha dato una seconda vita a Casa Depero. Un complesso restauro, firmato dall’architetto Renato Rizzi, ha recuperato le zone originali progettate dall’artista, completandole con due nuovi livelli ispirati direttamente al gusto di Fortunato Depero. Dentro si possono ammirare, esposti a rotazione, circa 3000 oggetti lasciati dall’artista alla città, fra dipinti, disegni, tarsie in panno, grafiche e giocattoli.
Casa Depero ospita anche un ricco programma espositivo, che reinterpreta in chiave contemporanea l’originaria vocazione di questo luogo al dialogo tra artisti e comunità locale.»
Visite virtuali al tempo del COVID-19 (mese 2 – giorno 30) #unpocoesco
Fortunato Depero (1892 –1960), Casa d’arte futurista Depero: Autoreclame e Pubblicità.
- Studi di insegne pubblicitarie, 1929http://www.mart.trento.it/casadepero
- Cartellone Balli Plastici, 1918
- Copertina di “”, 1930
4-5. Campari, 1926
 «L non è vana, inutile e esagerata espressione di megalomania, bensì indispensabile NECESSITÀ per far conoscere rapidamente al pubblico le proprie idee e creazioni».
«L non è vana, inutile e esagerata espressione di megalomania, bensì indispensabile NECESSITÀ per far conoscere rapidamente al pubblico le proprie idee e creazioni».
«L’arte dell’avvenire sarà potentemente pubblicitaria. Tale espressione apparentemente eretica, tale audace concezione e inoppugnabile constatazione l’ho avuta dai musei e dalle opere del passato. L’arte dei secoli passati è pregna di glorificazioni. Ovunque un’impronta guerresca e religiosa, ovunque una documentazione di fatti, di cerimonie e di personaggi esaltati nelle loro atmosfere vittoriose, nei loro simboli, nei gradi di comando e di splendore. Anche i loro prodotti eccelsi ed ambienti regali (architetture, regge, troni, drappi, alabarde, stemmi ed armi di ogni foggia) appaiono in simultanea glorificazione. Non c’è opera antica se non inghirlandata di trofei gloriosi pubblicitari, di arnesi di pace, di guerra e di vittoria; timbrati da sigle e da simboli originali di potenti casati, composti e stilizzati con una libertà autoincensatoria ultrareclamistica. […]
 L’arte della pubblicità è un’arte decisamente colorata, obbligata alla sintesi. Arte fascinatrice che arditamente si piazzò sui muri, sulle facciate dei palazzi, nelle vetrine, nei treni, sui pavimenti delle strade, dappertutto. Si tentò perfino di proiettarla sulle nubi. È insomma un’arte viva che penetra e si diffonde ovunque, moltiplicata all’infinito e che non rimane sepolta nei musei. Arte libera da ogni freno accademico.
L’arte della pubblicità è un’arte decisamente colorata, obbligata alla sintesi. Arte fascinatrice che arditamente si piazzò sui muri, sulle facciate dei palazzi, nelle vetrine, nei treni, sui pavimenti delle strade, dappertutto. Si tentò perfino di proiettarla sulle nubi. È insomma un’arte viva che penetra e si diffonde ovunque, moltiplicata all’infinito e che non rimane sepolta nei musei. Arte libera da ogni freno accademico.
Arte gioconda, spavalda, esilarante, ottimistica. Arte di difficile sintesi, dove l’artista è alle prese con la creazione ad ogni costo. Il cartello è l’immagine simbolica di un prodotto, è la geniale trovata plastica e pittorica necessaria per esaltarlo e interessarlo. Esaltando con ingegno i nostri prodotti, le nostre imprese, (cioè i fattori e l’essenza della nostra vita), non facciamo che dell’arte sinceramente moderna. L’arte pubblicitaria poi offre temi e campo di ispirazione inesplorati. Essa è fatalmente necessaria, attuale e rapidamente pagata. Sono persuaso che un solo industriale dà maggiore incremento all’arte nuova e alla sua evoluzione, più di cento critici o di cento collezionisti passatisti. […]
L’influenza dello stile d’avanguardia e futurista in tutte le applicazioni e creazioni pubblicitarie e decorative è evidente, lo stesso mi vedo frequentemente plagiato, con più o meno gusto, con più o meno intelligenza. Ciò mi fa naturalmente molto piacere e, benché mi sia dedicato all’arte pubblicitaria con limitato tempo, constato e non esito a dichiararlo, di avere fatto scuola; ma aggiungo che in questo campo inesauribile avrò ancora qualcosa da dire.»
(Dalla Rivista “Futurismo”, Roma, 1933)
Visite virtuali al tempo del COVID-19 (mese 3 – giorno 1) #unpocoesco
Fortunato Depero (1892 –1960), Marionette di legno e Balli Plastici (Casa d’arte futurista Depero)
Costruzione di donna, 1917
Marionette
Video “Pagliacci”: apertura e scena conclusiva.
Operai
«… Per ottenere un maggior senso geometrico e di libertà proporzionale nei costumi, nei personaggi e nei rapporti fra scena e figura, bisognerebbe dimenticare addirittura l’elemento uomo e sostituirlo con l’automa inventato; cioè con la nuova marionetta libera nelle proporzioni, di uno stile inventivo e fantasioso, atta ad offrire un godimento mimico paradossale e a sorpresa…». (F. Depero)
Il progetto dei “Balli Plastici” nasce nel 1917-18 con l’incontro di Depero con il poeta svizzero Gilbert Clavel e il loro soggiorno a Capri. Un “teatro magico” realizzato con marionette di legno dai movimenti meccanici e accompagnato da musiche d’avanguardia. La prima rappresentazione a Roma nel 1918 con undici repliche nel Teatro dei Piccoli fondato dal grande burattinaio Vittorio Podrecca.
Lo stile delle marionette realizzate in quegli anni continuerà a caratterizzare anche le opere successive di Depero: sculture, dipinti, “mosaici di stoffa” ecc.
Visite virtuali al tempo del COVID-19 (mese 3 – giorno 2) #unpocoesco
Fortunato Depero, Casa d’arte futurista Depero, 1957
Al piano terra su una parete tre grossi dipinti a olio di analoghe dimensioni (cm. 220 x 168,5 ciascuno) si presentano quasi come un grande murale che interseca modernità e tradizione nelle simbologie e nelle strutture architettoniche, miti antichi e miti contemporanei, in una grande visione dove l’antico diventa integralmente moderno.
Da sinistra: Generosità sconfinata – Pietre antiche e moderne – Vampa eroica
Visite virtuali al tempo del COVID-19 (mese 3 – giorno 3) #unpocoesco
Fortunato Depero (1892 –1960), Diabolicus (1924), autoritratto
Esposto nella Casa d’arte futurista, abbiamo un autoritratto che si distacca dalle autorappresentazioni tipiche di molti artisti. In questo autoritratto del 1924 (titolato “Diabolicus” nel 1932 dopo il ritorno dagli Stati Uniti) Depero si raffigura come un montanaro (con alle spalle le Dolomiti) e contemporaneamente come un viaggiatore ove le Dolomiti si trasformano in grattacieli. Sarà infatti nel 1928 che Depero si trasferisce a New York e che “diabolicamente” trasformerà le Dolomiti in grattacieli e se stesso, dal montanaro attaccato alle proprie radici e tradizioni, nel viaggiatore moderno volto alla scoperta del “nuovo mondo”, nel contempo messaggero oltreoceano dell’arte futurista.
Visite virtuali al tempo del COVID-19 (mese 3 – giorno 4) #unpocoesco
Rovereto.
1-2 . Palazzo Del Ben – Conti d’Arco (sec XV), Piazza Rosmini
- Palazzo Pretorio – Municipio (sec XV)
- Per le vie del centro
Chiudo questa (retro)visita virtuale a Rovereto con immagini di questa cittadina con cui noi del VCO e del Novarese, come abbiamo in parte già visto, abbiamo molti rapporti. Sul piano artistico con pittori presenti nelle collezioni del Mart (Tozzi, Casorati, Dudreville …) e perché qui sono nati due personaggi importanti per il nostro territorio. La figura di Antonio Rosmini e i Collegi rosminiani di Stresa e Domodossola sono ampiamenti noti. Meno noto è che Mario Flaim, comandante partigiano caduto sulla Marona e a cui è stata intitolata nell’ultimo periodo della Resistenza la Divisione che ha riunito tutte le formazioni del Verbano, sia anche lui originario della cittadina trentina.
Vale la pena, dopo il Mart e la Casa d’Arte Depero, percorrerne le vie, ammirare il Palazzo del Ben, oggi sede della Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto, nonché il Palazzo Pretorio, oggi sede municipale – entrambi risalenti al XV secolo – e, se si è autonomi nel trasporto, salire sul Colle di Miravalle dove è collocata la Campana dei Caduti (o della Pace), forgiata con il bronzo dei cannoni delle diverse nazioni in conflitto, che con i suoi cento rintocchi ogni sera al tramonto ricorda i caduti di tutte le guerre.
Visite virtuali al tempo del COVID-19 (mese 3 – giorno 5) #unpocoesco
Polimede di Argo, Kléobi e Bitone (585 a.C. circa). Museo Archeologico di Delfi.
Statue in marmo di grandi dimensioni (h. cm. 216) dello stile arcaico dei kouroi (ragazzi nudi astanti) di derivazione egizia. Furono scoperte nel 1893 e 1894 durante scavi organizzati da archeologi francesi.
I due gemelli, nella tradizione mitica, erano figli della sacerdotessa Cidippe del tempio di Hera. Secondo il racconto di Erodoto dovendo la loro madre recarsi a celebrare i riti della divinità olimpica, in assenza dei buoi, i due figli trascinarono il carro della sacerdotessa sino al tempio. La madre commossa per la loro dedizione chiese a Hera la ricompensa più grande che dei mortali potessero ricevere. La Dea li fece addormentare per sempre in un sonno piacevole, una sorta di morte inconsapevole e indolore.
Visite virtuali al tempo del COVID-19 (mese 3 – giorno 6) #unpocoesco
Sfinge dei Nassi (565 a.C. circa). Museo Archeologico di Delfi. 
Dono della popolazione di Nasso, la principale isola delle Cicladi, all’oracolo di Delfi. Statua di cm 222, scolpita nel marmo originario dell’isola, si ergeva a Delfi su di una colonna di 10 metri davanti al tempio di Apollo.
Tra le varie raffigurazioni della Sfinge questa, oltre il corpo di leone e il viso di donna – che qui ricorda quello tipico delle Korai greche – è nella versione alata, raffigurazione presente sia in Grecia che in tutto il medio oriente. Alla Sfinge si collega, come è noto, il mito di Edipo.
Visite virtuali al tempo del COVID-19 (mese 3 – giorno 7) #unpocoesco
Toro in oro e argento a sbalzo di dimensioni naturali, VI sec a.C. Delfi, Museo Archeologico.
Nel 1939, sotto la Via Sacra che conduce al tempio di Apollo, sede dell’Oracolo, è stato rinvenuto un deposito degli artistici oggetti preziosi che i “postulanti” recavano per poter accedere al responso del Dio.
Dal libro di Michael Scott, “Delfi. Il centro del mondo antico”, una efficace ricostruzione:
«(L’oracolo) non dice né occulta ma dà segni.» Eraclito
«Il giorno fissato era giunto. Dopo un viaggio su per i tortuosi sentieri montani che portavano al luogo santo nascosto nei recessi del massiccio del Parnaso, si erano riunite nel santuario di Apollo persone venute da vicino e da lontano, rappresentanti di città e di Stati, di dinastie e di regni fin dalla parte opposta del Mediterraneo. Allo spuntare dell’alba girò la voce che presto si sarebbe saputo se il dio Apollo avrebbe risposto alle loro domande. La luce del sole si rifletteva sulla facciata di marmo del tempio, la sacerdotessa dell’oracolo entrò nella parte più interna e gli interpellanti in folla cominciarono ad avanzare, in attesa del proprio turno per apprendere che cosa avessero in serbo per loro gli dei. Si riteneva che le divinità potessero tutto, controllassero tutto, sapessero tutto: le loro sentenze, più e più volte, si erano dimostrate definitive. Tra gli interpellanti c’era chi aveva atteso mesi, chi aveva percorso migliaia di chilometri. Adesso attendevano pazienti il proprio turno, ognuno presumibilmente pieno di apprensione per ciò che avrebbe ascoltato entrando nella casa del dio. Alcuni ne uscivano soddisfatti, altri delusi, i più pensierosi.
Al crepuscolo la sacerdotessa del dio si faceva muta. Le folle si disperdevano, dirette verso tutti gli angoli del mondo antico, portando con sé le parole profetiche dell’oracolo di Delfi.»
Visite virtuali al tempo del COVID-19 (mese 3 – giorno 8) #unpocoesco
Auriga, 475 a.C. circa. Museo Archeologico di Delfi. Statua in bronzo (cm. 180) e ornamenti argentei.
 La Statua originaria comprendeva anche la quadriga con i cavalli, di cui sono pervenuti solo alcuni frammenti.
La Statua originaria comprendeva anche la quadriga con i cavalli, di cui sono pervenuti solo alcuni frammenti.
È stata commissionata da Polizelo di Dinomene, tiranno siciliano di Gela, per celebrare la vittoria ai Giochi Pitici del 478 a.C. Delfi infatti non era famosa solo per il Tempio di Apollo e l’oracolo, ma ogni quattro anni vi si svolgevano, prima ancora di quelli olimpici, giochi panellenici (Pitici) che comprendevano non solo le competizioni sportive ma anche gare poetiche e musicali. Sovrastante al tempio di Apollo vi è infatti il teatro e, ancora più in alto, lo stadio per le competizioni sportive.
Visite virtuali al tempo del COVID-19 (mese 3 – giorno 9) #unpocoesco
Tesoro degli Ateniesi, Delfi (510 – 490 a.C. circa)
I templi del Tesoro o Donari custodivano le offerte preziose che le poleis greche donavano ad Apollo delfico. Secondo alcuni quello ateniese fu eretto per celebrare la vittoria della democrazia della polis attica nei confronti della tirannia, mentre secondo Pausania per celebrare la battaglia di Maratona (490 a.C.) contro i Persiani.
È un tipico tempio dorico “in antis” e il fregio con le metope che orna la parte superiore, rappresentava le imprese di Teseo, l’eroe mitico per eccellenza ateniese (di fronte), e quelle di Eracle, eroe tebano (di lato). Il tempio fu ricostruito tra il 1903 e il 1906 con un finanziamento del comune di Atene; le metope recuperate sono custodite nel Museo di Delfi.
Visite virtuali al tempo del COVID-19 (mese 3 – giorno 10) #passoechiudo
Delfi, Tempio di Apollo – Oracolo e Teatro
Con le foto dei due monumenti principali di Delfi, Tempio di Apollo con il sacello dell’Oracolo e il Teatro, chiudo dopo tre mesi e 10 giorni le mie visite virtuali quotidiane.
 Posto sul lato est del massiccio del Parnaso – monte brullo e per niente ‘paradisiaco’ come è invece rappresentato dalla tradizione poetica – il tempio di Apollo risale al V secolo a.C. e venne ricostruito dopo un incendio con il finanziamento della potente famiglia aristocratica ateniese degli Alcmeonidi. Nella cripta dove vi erano esalazioni considerate miracolose la Pizia dava voce al responso del Dio.
Posto sul lato est del massiccio del Parnaso – monte brullo e per niente ‘paradisiaco’ come è invece rappresentato dalla tradizione poetica – il tempio di Apollo risale al V secolo a.C. e venne ricostruito dopo un incendio con il finanziamento della potente famiglia aristocratica ateniese degli Alcmeonidi. Nella cripta dove vi erano esalazioni considerate miracolose la Pizia dava voce al responso del Dio.
Racconta Plutarco: «Non c’è niente di strano, dunque, se fra tante esalazioni che la terra fa scaturire, solo queste di Delfi riescano ad invasare le anime traendole alla visione del futuro. La tradizione conferma senz’altro il nostro discorso. Si racconta infatti che il potere di questo luogo si rivelò per la prima volta quando un pastore, capitato qui per caso, cominciò a proferire voci ispirate. Da principio i presenti dissero che era matto, ma poi, quando le predizioni di quell’uomo si realizzarono, restarono sbalorditi. A Delfi i più eruditi ricordano ancora il suo nome: Coreta.»
(Il tramonto degli oracoli, in Dialoghi Delfici, Piccola Biblioteca Adelphi, Milano, 1995, pp. 118-119)
Il teatro ove, oltre le frequenti rappresentazioni di commedie e tragedie, si svolgevano le gare di musica e poesia associate ai giochi pitici. La configurazione visibile oggi risale ad una ristrutturazione del IV secolo e al restauro del II sec a.C., in epoca romana. Poteva contenere 5.000 posti ed aveva un ingresso con un fregio rappresentante le dodici fatiche di Eracle.