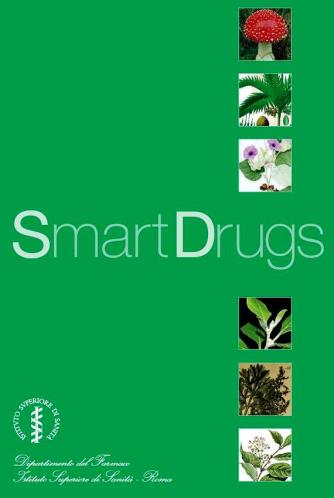La recensione che segue era stata postata su aNobii e nelle mie note su Facebook alla fine del dicembre 2009 dopo la pubblicazione di questo testo allora introvabile (Carlo Cattaneo, Interdizioni israelitiche, 1836) da parte di Caribou, un piccolo editore locale che poi purtroppo non ha avuto lunga vita (1).
Il testo era stato curato e introdotto dal compianto Paolo Guidera (2) che dell’editore era attivo collaboratore e testa pensante. L’abbiamo presentato alla Casa della Resistenza il 14 dicembre di quell’anno.
Il riferimento che facevo sei anni fa allo “scippo dei presunti federalisti” è ormai da archiviare; abbandonato l’indipendentismo padano e i richiami a qualche lettura indiretta di Cattaneo, originata dagli iniziali legami con Gianfranco Miglio, i leghisti attuali sotto la guida del loro nuovo capo hanno traslato il loro razzismo in un nazionalismo che ai richiami seppur indiretti a qualche libro privilegiano l’auspicio di ruspe e l’indossar magliette tamarre, mentre i loro capiscuola politici sono più dalle parti di Putin e Orbán ed i loro privilegiati compagni di strada i neofascisti di Casa Pound.
Per Carlo Cattaneo rimane l’oblio, a destra come a manca.
Interdizioni e Scippi
Una nuova edizione di un testo ormai introvabile, curata da Paolo Guidera con una precisa ricostruzione storica del contesto in cui il libro è stato scritto e chiari riferimenti alle relazioni culturali di Cattaneo: il maestro Romagnosi in particolare e, d’altro canto, la polemica, molto aspra, con Rosmini. Su quest’ultimo aspetto viene pubblicata una lettera aperta, a suo tempo censurata, in cui Cattaneo contrattacca molto aspramente le accuse ateismo, slealtà, plagio ecc. rivolte da Rosmini a Romagnosi. Il tema sottostante è quello dell’empirismo lockiano con la negazione delle idee innate e della sua compatibilità in un contesto culturale cristiano. Di fronte alla esaltazione acritica odierna sia di Rosmini che di Cattaneo, rivivere “in diretta” il confronto, fa emergere chiaramente la modernità del secondo (tanto esaltato a parole quanto ignorato nei fatti, come disse Bobbio) rispetto al primo.
Questa edizione riporta anche un articolo di Mazzini sullo stesso tema affrontato da Cattaneo: le leggi “di interdizione” agli ebrei, ossia divieti e limitazioni (possesso di terre ed edifici, di culto, di residenza, di matrimonio con cristiani ecc. ecc.). La differenza di metodo fra i due ne risulta del tutto evidente. Mazzini parte da principi universali etici e politici da cui ne deriva le obbligate conseguenze: “la nostra è un’epoca di emancipazione e di riabilitazione universale” e, se vogliamo che gli Israeliti diventino dei “buoni cittadini” il solo mezzo “è quello di farne dei fratelli con eguali diritti con tutti gli altri”.
Cattaneo, pur pervenendo a conclusioni simili, procede in modo diverso: l’avvio è dato da un caso specifico (l’acquisto da parte dei fratelli Wahl, cittadini francesi di origini ebraiche, di un terreno del Cantone svizzero di Basilea-Campagna dove la “possidenza” è interdetta agli israeliti ma anche dove un trattato Franco Svizzero equipara i cittadini francesi – e gli ebrei francesi sono, dopo la rivoluzione e le leggi napoleoniche, cittadini a tutti gli effetti – ai cittadini svizzeri e l’opposizione condotta verso questo atto di acquisto da parte del Consiglio Cantonale) e procede attraverso analisi storiche (origini e sviluppo delle interdizioni) giuridiche ed economiche. La conclusione è che le leggi di interdizione, costringendo gli ebrei alle sole attività commerciali e finanziarie, hanno storicamente prodotto effetti esattamente opposti a quelli che quelle leggi si proponevano; sono inoltre in contrasto con le leggi prevalenti del periodo e producono un danno sia privato che pubblico ai cittadini non ebrei. Infatti il divieto di acquisto da parte di ebrei produce anche una limitazione al diritto di vendita (e perciò di proprietà effettiva) dei proprietari di terreni; inoltre l’agricoltura del periodo (specie in Svizzera ma anche in Italia e altrove) per uscire dall’arretratezza ha bisogno dell’investimento di nuovi capitali, capitali che potrebbero facilmente affluire dai ceti mercantili ebraici se le interdizioni fossero abolite. Insomma in una società basata sui principi liberali della libera cittadinanza e del libero scambio la limitazione dei diritti di alcuni produce un danno e una limitazione di diritti a tutta la comunità.
Tutto questo produce conseguenze nefaste anche al livello più alto della vita collettiva, quello della qualità della convivenza all’interno di una comunità. Lascio la parola a Cattaneo:
“«Convivere non è meramente coesistere sullo stesso suolo. Gli schiavi della persona e della gleba propriamente non convivono cogli ingenui [i nativi, gli uomini liberi], ma servono ai medesimi. Il bue ed il cavallo non convivono con noi» [Gian Domenico Romagnosi]. La convivenza dunque differendo assai dalla mera coesistenza, consiste nel ricambio delle leali transazioni, degli officj civili e delle sociali carità.
Ora questi officj, queste carità si rendono maggiori a chi tiene una condotta più buona e cordiale e si mostra più capace di giovare altrui. L’aspettativa del ricambio spinge gli uomini a fare i primi passi. Epperò chi stringe i legami della convivenza, chi avvicina gli uomini agli uomini e ne avvalora la reciproca dipendenza, costringe l’individuo a condursi lodevolmente per provocare colle buone e generose azioni l’assistenza e la cordialità altrui. Allora il pensiero che un solo atto vituperevole può privarlo dell’assistenza sociale e dei vantaggi e dei piaceri che ne ridondano, gli diviene un saldissimo freno.
Perché questa perpetua responsabilità pesi su tutti gli uomini, è necessario che la convivenza sociale li congiunga tutti. Epperò quelle leggi che proscrivono un ceto qualunque, e lo escludono dalla sociale convivenza, lo sciolgono eziandio dalla necessità di rendersi utile e accetto agli altri ceti, e lo abbandonano alla spinta grossolana e immorale dell’egoismo. Se poi alle esclusioni si aggiungono distinzioni odiose e affliggenti, l’egoismo degenera in ostilità. Allora il ceto proscritto diviene un inimico accampato nel grembo della nazione, il quale nel secreto delle transazioni private rende a più doppj quel male che gli viene inflitto dalle publiche ordinanze.” (pp. 137-138)
Come ha sottolineato Franco Restaino “Cattaneo è senz’altro il più lucido e attento intellettuale del periodo postnapoleonico, e l’unico che, insieme a Leopardi, può essere letto con piena e immediata fruibilità dei suoi scritti caratterizzati da una chiarezza e da una accessibilità senza confronti.” [Storia della Filosofia, UTET. Torino 1999, vol. 4/1]
Oggi, con evidenza, Carlo Cattaneo scriverebbe delle “interdizioni islamiche” riferendosi ancora, come allora, sia alla Svizzera che all’Italia. E ribadirebbe che il modo migliore per alimentare ostilità e fondamentalismo di una minoranza è quello di negarle diritti e libertà di culto.
Che presunti federalisti, nel loro furore xenofobo e anti islamico, esaltino Cattaneo come loro padre teorico non desta meraviglia; non possiam pretendere che perdan tempo a leggere testi di 170 anni fa. Com’è noto preferiscon gazebo e ronde a librerie e biblioteche.
Che da parte della cultura laico democratica non vi sia una reazione verso questo “scippo” leghista del rigoroso intellettuale illuminista repubblicano Cattaneo, leader indiscusso delle giornate di Milano e deputato eletto nel primo parlamento italico (superando in due collegi lombardi su tre il moderato Cavour), ma mai insediatosi per non dover prestar giuramento alla “codina” monarchia sabauda, questo si!, che desta profonda preoccupazione.
Ci hanno scippato e stravolto parole come libertà, federalismo (che unisce e supera gli Stati e non li frammenta), popolo, comunità, ecc. ecc.; perlomeno non lasciamoci portar via le fonti su cui è possibile ri-alimentare il nostro pensiero.
———–
(1) Altre edizioni recenti del testo di Cattaneo sono reperibili presso gli editori Einaudi, Fazi, Le Monnier e Mondadori Oscar (all’interno di La Lombardia di Carlo Cattaneo).
(2) Paolo, collega di Filosofia al Liceo Cavalieri di Pallanza, rigorosamente laico nonché lettore e studioso dalle conoscenze vastissime, ci ha lasciato nel novembre 2013. Sul sito La natura delle cose vi è una pagina a lui dedicata dove sono linkabili alcuni dei suoi scritti.
Quanto segue è in gran parte in debito ad un confronto avvenuto nei mesi scorsi all’interno di Agenda 20 20 sul tema Cultura e territorio e su quello della nostra identità. Confronto che dovrebbe sfociare in un momento pubblico di studio e discussione con la presenza di esperienze e pratiche significative.
Una prima versione l’avevo fatta girare tra membri dell’associazione. La ripropongo qui in nuova versione.
Dentro un paradosso borgesiano
Da tempo mi riproponevo di scrivere qualcosa di organico sull’identità in relazione alla nostra appartenenza territoriale, ma più leggevo, rileggevo e riflettevo, più le idee mi si aggrovigliavano. Tra gli scritti che avevo sottomano c’era “Intervista sull’identità” di Zygmunt Bauman che avevo lasciato da parte per un pregiudizio negativo sull’autore: da un po’ di tempo mi pareva che la sua categoria di “liquidità” fosse diventato un mantra omniesplicativo e ripetitivo. Non è il caso di questo testo, ormai di dodici anni fa, che sin dalle prime pagine è pieno di spunti illuminanti.
A pagina 19 l’autore richiama uno dei racconti di Borges che fa parte dell’Aleph: La ricerca di Averroè dove si narra del filosofo arabo di Cordova, impegnato nella traduzione della Poetica di Aristotele, all’interno di una cultura – quella islamica – che non conosce il teatro.
Come ci spiega lo stesso Borges al termine del racconto:
“Nella storia che precede ho voluto narrare il processo di una sconfitta. Pensai, al principio, a quell’arcivescovo di Canterbury che si propose di dimostrare che c’è un Dio; poi agli alchimisti che cercarono la pietra filosofale; in seguito, alle vane trisezioni dell’angolo e quadrature del cerchio. Poi riflettei che è più poetico il caso di un uomo il quale si propone un fine che non è vietato agli altri, ma a lui soltanto. Ricordai Averroè, che chiuso nell’ambito dell’Islam non poté mai sapere il significato delle voci tragedia e commedia”.
Bauman lo cita in riferimento ad un censimento, avvenuto nella sua Polonia poco prima della seconda guerra mondiale, che si proponeva di registrare le appartenenze nazionali di tutti gli abitanti (oltre i polacchi, tedeschi, ebrei, ucraini, bielorussi …). Ebbene una quota consistente degli intervistati (circa un milione), nonostante le insistenze degli addetti, non erano in grado di rispondere se non “siamo di qui”, “questa è la nostra terra” e simili.
“Alla fine i responsabili del censimento dovettero arrendersi e aggiungere la voce “locali” alla lista ufficiale delle nazionalità …”
Scrivevo cinque anni fa in un articolo sul VCO come comunità:
“Il Vco è o può effettivamente diventare una comunità? È vissuto come tale dai propri abitanti? Le forze politiche e sociali hanno sinora lavorato in questa direzione? Pare evidente la risposta negativa.”
La risposta di oggi sarebbe ancor più negativa: se allora tra i motivi della difficoltà, oltre quelli socio economici, c’era quello della differenziazione politica fra i governi locali e fra questi e quello provinciale e regionale, oggi nonostante tutte le rappresentanze significative del territorio (sindaci, presidenza provincia, parlamentari regionali e nazionali) siano tutte dello stesso partito, la frammentazione e le dispute campanilistiche sono ancora più accentuate e – proprio perché non più mascherabili dalle differenze politiche – ancor più trasparenti.
In sostanza il VCO non è stato in grado di essere/diventare una Comunità.
Oggi ci interroghiamo sull’identità, ma è evidente che fra identità e comunità c’è un legame strettissimo. Perché mi è parso illuminante l’esempio del censimento polacco richiamato da Bauman?
Mi pare che la situazione nostra sia analoga e inversa a quella degli intervistati “locali” della Polonia pre-guerra per i quali l’appartenenza (e identità) locale, territoriale, era chiara, ma per nulla quella nazionale: per loro quella domanda non aveva senso.
Se chiediamo ad un napoletano, a un bergamasco o a un valdostano se si identifichino con quell’appellativo e nella cultura che quel nome rappresenta, nella maggior parte dei casi la risposta probabilmente sarebbe positiva. Ma come chiederlo ad un abitante del VCO?
Non c’è il nome (solo a provarci fa spavento: vcionese? Verbancusiossolano? …) e pertanto … non c’è, non è pensabile, “la cosa”.
All’opposto dei “locali” polacchi di Bauman: la nostra identità nazionale di Italiani non ci pone problemi, ma quella territoriale ci pare preclusa. A noi soltanto!
Inseriti a nostra insaputa in un paradosso borgesiano.
Anche l’intervista ai giovani del VCO realizzata nel 2012 nell’ambito di Paesaggio a colori, conferma questa assenza di identità territoriale. Alla domanda sulla “realtà geografico – culturale a cui si sente maggiormente di appartenere” (due risposte possibili) al primo posto viene il Comune di residenza (27,7%), al secondo l’Italia (21,4%), seguiti da Il mondo in generale (18%) e Il nord Italia (15,2%). Solo al quinto posto La provincia in cui vivo con un misero 8,9%.
Il VCO ha dimostrato – e dimostra tutt’ora – di non essere una comunità; cercarne l’identità sarebbe allora impresa vana.
Fine del problema?
All’opposto. Se la nostra identità territoriale non c’è, è certamente inutile “cercarla” … possiamo però (tentare di) costruirla. Non è un “dato”, è un “compito”.
Come dice Bauman a proposito della crisi delle identità nella società globalizzata:
“…la “identità” ci si rivela unicamente come qualcosa che va inventato piuttosto che scoperto; come il traguardo di uno sforzo, un “obiettivo”, qualcosa che è ancora necessario costruire da zero o selezionare fra offerte alternative, qualcosa per cui è necessario lottare e che va poi protetto attraverso altre lotte ancora … (p. 13)
L’identità può entrare nella Lebenswelt [nel concreto “mondo della vita”, nella quotidianità] solo come un compito ancora non realizzato, non compiuto, come un appello, come un dovere e un incitamento ad agire …(p. 19-20)”
Con un problema che rimane comunque aperto: qual è il nostro territorio di riferimento? Identità territoriale … di dove? L’attuale provincia non pare più consona e sue tre porzioni (Verbano, Cusio ed Ossola), con territori ancor più limitati, risulterebbero decisamente asfittiche. In sostanza la costruzione della nostra identità territoriale non è solo un compito “culturale”, necessità anche di una perimetrazione (o ri-perimetrazione) territoriale e di un “nome della cosa” riconosciuto (dall’interno) e riconoscibile (dall’esterno).
Da questo punto di vista la permanenza o meno dell’istituzione Provincia del VCO è ininfluente, e fors’anche ostativa.
Identità individuale e collettiva
L’etimo di “identità” (idem) permette una oscillazione di significati:
- da un lato “il medesimo, lo stesso” ad indicare la permanenza e l’eguaglianza di un ente con se stesso (e pertanto, in riferimento alle persone, “individualità”);
- dall’altro “identico a …” (e nel contempo, implicitamente, “diverso da …”) e pertanto “identità” come relazione di eguaglianza / similarità con altro / i.
L’identità, nella sua accezione socio-antropologica, non va così confusa con “individualità”, ossia con l’unicità dell’individuo, della singola persona, con la sua riconoscibilità ed identificazione (es. “Carta di identità”).
Non c’è cioè identità socio culturale antropologica se non nella relazione dell’individuo con la collettività di riferimento; questa si forma e consolida attraverso il riconoscersi ed identificarsi con il gruppo (familiare, sociale, locale, nazionale ecc.) di cui si condividono, assimilano ed imitano caratteristiche, comportamenti ed idealità. Identità individuale e identità collettiva si rimandano pertanto l’una con l’altra.
Il processo di formazione sociale dell’identità è stato modellizzato da Henri Tajfel con la sua Teoria dell’Identità Sociale (Social Identity Theory o, in forma breve, SIT) come un processo a tre fasi tendente a scindere nettamente il gruppo sociale di appartenenza (ingroup) dagli altri gruppi (outgroups):
- Categorizzazione: massimizzazione delle uguaglianze interne e delle differenze esterne;
- Identificazione: costruzione della propria identità come appartenenza al gruppo;
- Confronto sociale: valorizzazione del proprio gruppo e corrispettiva de-valorizzazione dei gruppi esterni.
Nello sviluppo del pensiero socio antropologico si è progressivamente passati da una concezione statica di identità, e analogamente di cultura, (una identità “culturale” è un sistema definibile e stabile, ben distinto da ogni altro), ad una concezione processuale dove le identità (individuali e collettive) sono sottoposte alle dinamiche relazionali e trasformative del complesso sociale (le identità si formano, consolidano, trasformano, escono di scena dando spazio/vita a nuove identità ). Per arrivare infine, con particolar riferimento all’attuale società globalizzata e complessa, a identità plurime che convivono e si intersecano sia a livello individuale che collettivo.
Ogni identità si forma e consolida attraverso un duplice processo di riconoscimento: interno e esterno, auto-riconoscimento ed etero-riconoscimento (come mi vedo, come “noi” ci vediamo e dall’altro lato come “gli altri” mi e ci vedono). Una identità solida / forte presenta elevata congruenza fra auto riconoscimento ed etero riconoscimento. Viceversa la dissonanza fra i due lati dello specchio è indice di una identità fragile o comunque ancora non pienamente formata.
Vi sono identità ascritte, attribuite ed identità assunte o tendenzialmente tali (desiderate).
Il riconoscimento (esterno) può inoltre venire dall’alto (verticale) o lateralmente, dai contesti limitrofi (orizzontale).
L’identità nazionale rappresenta l’esempio primo di identità ascritta e di riconoscimento verticale. Lo stato moderno ha sostituito il “cuius regio, eius religio” con il laico “cuius regio, eius natio”. Il criterio religioso di identità (ascritta) ha lasciato il passo a quello di nazionalità.
Con la globalizzazione e la progressiva perdita di forza degli Stati nazionali il ruolo delle identità locali, territoriali può sopperire alla più generale crisi di identità (le attuali identità incerte e fluttuanti). Identità locali, territoriali non certo come riscoperta (fittizia) di “radici” e originarie purezze destinate a sfociare in messe in scena folkloriche prive di spessore.
Identità territoriale (assunta) invece da concepire come un processo culturale di ricostruzione della propria storia (il territorio non come natura attribuita e determinante, ma come natura coltivata, antropizzata), delle proprie reti e relazioni, e come costruzione condivisa di un proprio possibile futuro.
Una identità in grado non solo di riconoscersi collettivamente ma anche di capace di garantirsi un etero-riconoscimento orizzontale in reti corte, medie e lunghe. Riconoscimento orizzontale che oggi passa anche (e sempre più) attraverso il digitale.
Se i mediatori, i segni distintivi dell’identità sociale originariamente passavano attraverso la corporeità (tatuaggi, ornamenti, vestiti, prossemica e gestualità), attraverso icone, simboli, linguaggio nonché attività lavorative ed artistiche, nella società mondializzata delle pluriappartenenze la narrazione assume un ruolo sempre più centrale nella costruzione e nel riconoscimento interno ed esterno delle identità.
L’identità come compito e come processo può così riflettersi nel percorso di una narrazione sempre ridefinibile ed incrementabile di nuovi capitoli.
Alla ricerca di un nuovo perimetro
Lasciando ad un successivo momento di approfondimento (possibilmente collettivo) l’individuazione di un progetto culturale in grado di ridefinire le linee di fondo – e una congruente narrazione – della nostra identità territoriale, c’è una domanda di fondo a cui non è possibile sottrarsi.
Qual è il nostro territorio? Qual è il perimetro in cui collocare la nostra identità?
Il VCO non è (stato) tale. Abbiamo sbagliato tutti a non capirlo. Una sommatoria non dà una unità. Non era “pensabile” e non è stato vissuto realmente come tale. Ripercorrerne le vicende non aiuta molto. A partire da un capoluogo (Verbania) che non è mai stato in grado di assumerne il ruolo e che probabilmente non ha mai voluto farsene realmente carico; con il paradosso invece di esser stato spesso accusato del contrario.
Rifluire ai singoli componenti (Il Cusio, il Verbano e l’Ossola) mi pare privo di prospettive.
Il tramonto delle province (Quando? Vero o sulla carta?) può aiutare ad uscire dall’impasse. Tenendo conto che nelle fasi di transizione vi può essere una discrepanza fra identità assunta (e vissuta) e identità istituzionale, nel medio periodo i due livelli non possono che allinearsi.
L’esempio prima ricordato della Polonia lo evidenzia in modo significativo. Se prima dell’ultima guerra la popolazione della Polonia era costituita da un 30% di non polacchi (oltre al 2,5% circa di “locali”), attualmente il 97,6% si definisce polacca. Vi sono certo stati gli eventi drammatici dell’ultima guerra, lo sterminio degli ebrei, le migrazioni ecc., ma vi è poi stata una serie significativa di eventi (da Solidarność al papa polacco) che hanno favorito (e narrato) un forte autoriconoscimento ed analogo etero riconoscimento di identità nazionale.
Quale, nel nostro piccolo, può essere il percorso istituzionale in grado di accompagnare la costruzione di una identità, locale ma non asfittica?
Penso all’Unione dei Comuni (che col tempo può anche portare alla fusione).
Ad esempio il patto sottoscritto di un Piano strategico della Città dei Laghi fra i Comuni di Baveno, Casale C.C., Gravellona Toce, Omegna e Verbania perché non pensarlo nella prospettiva di una Unione di Comuni? Se esiste una “conurbazione” in atto fra questi ed è giusto, come opportunamente si dibatte, che tale conurbazione non sia subita e tantomeno assecondata nei suoi aspetti di consumo e deterioramento del territorio, ma “governata”, forse, nel medio periodo, un piano strategico non è sufficiente. Certo andrebbe coinvolto qualche altro Comune: in primo luogo Mergozzo che della conurbazione in atto fa certo parte. Avremmo così una meglio definibile “Città dei 3 Laghi” che potrebbe costituire un orizzonte non solo istituzionale ma anche, in una prima fase, di identità territoriale.
Una Unione dei Comuni (dall’alto) da accompagnare (dal basso) con adeguati progetti culturali e da pensare come una fase intermedia, non in contrasto con altre parti del territorio circostante, ma appunto come tappa in cui altri Comuni (per esempio quelli Ossolani) procedano nella stessa direzione.
Perimetri transitori verso un perimetro più ampio (e direi più appetibile) che, alla lunga, potrebbe essere quello di tutti i territori che afferiscono (al di qua e al di là del confine) alle Alpi Lepontine.
Un sogno. Certo, finché solitario.
Ma i sogni collettivi non si chiamano più tali. Diventano aspirazioni, narrazioni e progetti e prima o poi realtà.
La butto lì, alla ricerca di possibili co-sognanti.
Testi consultati
Pollini, Appartenenza e identità. Analisi sociologica dei modelli di appartenenza sociale, Franco Angeli, Milano 1987.
- L. Borges, L’Aleph, Feltrinelli, Milano 2001
- Bauman, Intervista sull’identità, Laterza, Bari 2003.
- Salsa, Il tramonto delle identità tradizionali. Spaesamento e disagio esistenziale nelle Alpi, Priuli & Verlucca, Scarmagno [To], 2009.
Testi online:
Un paesaggio a colori: http://images.vb.camcom.it/f/Varie/55/5528_CCIAAVB_13122012.pdf
Report Agenda Cultura: https://agendaverbania2020.files.wordpress.com/2014/05/agenda-vb-2020-report-sport-e-turismo.pdf
Bellezza, paesaggio e sviluppo; problematiche e prospettive nel VCO di A. Biganzoli: http://pensieridizorro.blogspot.it/2015/03/civilta-rurale-montana.html
Identità personale e collettiva di L. Sciolla: http://www.treccani.it/enciclopedia/identita-personale-e-collettiva_%28Enciclopedia_delle_scienze_sociali%29/
Il carattere necessario e riduttivo delle identità. Un’intervista a Franco Crespi: http://www.fupress.net/index.php/smp/article/view/13585/12672
Cleavage e identità di C. Colloca: http://www.fupress.net/index.php/smp/article/view/8464
Che cosa è l’identità collettiva di L. M. Daher: http://www.fupress.net/index.php/smp/article/view/13580
Indovina Chi: identità contemporanee da ri-conoscere di G. Sarra: http://www.fupress.net/index.php/smp/article/view/13587
VCO: una comunità senza futuro? (1): https://www.facebook.com/notes/gianmaria-ottolini/vco-una-comunit%C3%A0-senza-futuro-1/279814194996
C’è un futuro per la comunità del VCO ? (2): https://www.facebook.com/notes/gianmaria-ottolini/c%C3%A8-un-futuro-per-la-comunit%C3%A0-del-vco-2/280180119996
Citazioni
“…Tönnies precisa infatti che il sentimento di appartenenza alla comunità territoriale non si costituisce meramente in relazione alla condivisione, da parte di un certo numero di individui, della medesima località di residenza o in relazione alla vicinanza di abitazione, ma anche in relazione alla cultura, ossia al complesso di valori e di simboli che sono in qualche modo legati alla terra, al suolo e al territorio. In questa prospettiva Tönnies sottolinea, ai fini del sentimento di appartenenza alla comunità territoriale, la funzione primaria della « terra coltivata» o, in altri termini, del paesaggio antropizzato e del territorio trasformati dal lavoro degli uomini di diverse generazioni. È infatti attraverso e mediante il lavoro umano che il suolo acquista una rilevanza e una signi[ìcanza simbolica per i medesimi individui che ad esso hanno contribuito o per quelli che riconoscono e prendono coscienza del lavoro di individui che li hanno preceduti. “
(Gabriele Pollini, Appartenenza e identità, Franco Angeli, Milano, 1987. pp. 204-205)
“Va tassativamente bandita qualsiasi rappresentazione romantica di una cultura/identità alpina con caratteristiche di originarietà, di autoctonìa o peggio di purezza, quasi si trattasse di un patrimonio consustanziale alla realtà indigena”
(Annibale Salsa, Il tramonto delle identità tradizionali, Priuli & Verlucca, Scarmagno [To], 2009, p. 26)
“Nella sua capacità riflessiva di elaborazione dell’esperienza e nella sua memoria, l’attore sociale costruisce la sua identità nel tempo come una continuità narrativa. … Proprio perché si tratta di una narrazione, l’identità è suscettibile di costanti variazioni e riformulazioni connesse ai mutamenti dell’esperienza e delle condizioni sociali.”
(Il carattere necessario e riduttivo delle identità. Un’intervista a Franco Crespi” in “Società Mutamento Politica” vol. IV, n. 8, 2013)
Ho già presentato in un precedente post il volume Il tunnel e il kayak (*), lavoro collettivo frutto della collaborazione fra l’associazione Contorno Viola, e il Cremit (Centro di Ricerca sull’Educazione ai Media all’Informazione e alla Tecnologia) dell’Università Cattolica coordinato dal prof. Pier Cesare Rivoltella.
Riporto di seguito due paragrafi incentrati sulla Peer & Media education e sulla sua genesi quale evoluzione della Peer education ai tempi di internet e della sua “alleanza” con la Media education. Paragrafi scritti materialmente dal sottoscritto, ma frutto di confronto ed elaborazione collettiva, in particolare il secondo.
( * Edizioni Franco Angeli, 2014.)
6.2 P&M: la genesi del concetto
La PE si è fondata proprio su di un rovesciamento del maternage adulto, in una cessione di responsabilità e in un conferimento di fiducia che ha investito i peer e la loro capacità di interagire con il gruppo dei pari, la loro naturale capacità comunicativa, il loro far leva su competenze e abilità personali, il loro far emergere una dimensione valoriale ed educativa caratterizzata da impegno prosociale.
Ed è in particolare su questi quattro assi (gruppo, comunicazione, competenze e valori) che la PE in questi ultimi due decenni, nel contatto diretto con il succedersi delle generazioni e dei cambiamenti che le nuove tecnologie digitali hanno di continuo introdotto, si è progressivamente trasformata mettendo in luce convergenze e punti di contatto con la parallela evoluzione della Media Education.
Il gruppo dei pari. La pratica della PE interseca la dimensione del gruppo a più livelli. Abbiamo innanzitutto il “gruppo progetto” dove la parità non necessariamente è d’età, ma di apporto di competenze fra operatori e giovani che danno vita a una progettazione partecipata[1]. Abbiamo poi il “gruppo dei peer” dove alla pari età si aggiungono la condivisione del ruolo e una esperienza comune; gruppo che sostiene l’agire dei singoli peer con un continuo scambio reciproco: riflessioni sull’azione comune, competenze e motivazioni in un processo a spirale di learning-by-doing. Abbiamo infine il “gruppo target” che, come più volte sottolineato, si è spesso identificato con una classe scolastica. Anche in questo caso abbiamo più livelli su cui l’intervento di PE deve saper interagire:
Il gruppo classe è vissuto come un luogo forte di coinvolgimento emotivo, sia in positivo (le amicizie, le fedeltà, le esperienze forti) che in negativo (rifiuto, sofferenza, solitudine). Inoltre fra il gruppo classe “formale” (l’elenco del registro) e quello informale (quello delle amicizie e degli affetti) può esserci una forte discrepanza; quest’ultimo può assumere il carattere del gruppo classe “segreto” che accetta e include ma, in alcuni casi, rifiuta e ostracizza (compagni di classe e talvolta insegnanti)… (Ottolini et al., 2007).
La centralità del gruppo dei pari come luogo di formazione e di costruzione dell’identità è stata non a caso fortemente sottolineata da Piero Amerio in apertura del primo Convegno nazionale sulla Peer Education[2] sia per l’aspetto orizzontale ed egualitario, sia – a differenza di quanto avviene nel più ampio contesto sociale – per la possibilità di un controllo diretto degli effetti delle proprie parole e delle proprie azioni: «Nel gruppo lo si sa, perché il gruppo è piccolo…: di ogni azione abbiamo subito il controllo del feedback, del ritorno indietro»[3].
Cosa cambia nel gruppo classe (o in un gruppo extrascolastico) con l’irrompere della dimensione digitale? La connessione permanente estende lo spazio sociale al di là della presenza: il gruppo classe “segreto” può inglobare amici digitali con cui si interagisce di continuo. Il feedback di cui parlava Amerio non è più ristretto al solo gruppo fisico e una conferma (o disconferma) digitale può pesare altrettanto, e spesso più, di quella in presenza, anche perché la “platea” si è di gran lunga allargata. Inoltre, se il sovrapporsi di identità plurime caratterizza in particolare le generazioni del nuovo millennio, il proliferare delle community online permette di dar spazio a nuove identità, anche di nicchia, che nell’ambito del gruppo in presenza o nel contesto sociale circostante, non potrebbero trovare espressione.
Sottolineano Gardner e Davis (2013) come:
… i giovani abbiano oggi maggiore libertà nell’adottare e ammirare modelli identitari che erano sconosciuti o disprezzati nei decenni precedenti. C’è una maggiore accettazione di coloro che sono in qualche modo diversi. … Le organizzazioni e i Club degli anni cinquanta-sessanta non sono semplicemente spariti: sono stati sostituiti da un numero molto più elevato di comunità online che rappresentano un’ampia gamma di interessi diversi. Per quanto il tuo interesse possa essere di nicchia, potrà trovare espressione e approvazione online, sia che questo avvenga sotto casa o in giro per il mondo. … Le nuove tecnologie della comunicazione possono offrire opportunità inedite per l’espressione di sé… (pp. 87-91).
Il gruppo in presenza va allora decodificato, non solo per far emergere il “gruppo nascosto” delle relazioni significative, ma anche per farlo interagire in modo esplicito con le sue connessioni con altri gruppi sia del territorio che digitali. Un peer&media educator è allora un peer che agisce con la consapevolezza che il gruppo su cui interviene, al di là della sua fisicità, costituisce un insieme di intersezioni con altri gruppi presenziali e digitali; e che possiede un bagaglio di base che gli permette di interagire a questi diversi livelli.
Capacità comunicativa. Il peer educator, in quanto “risorsa non professionale” faceva affidamento soprattutto sulla propria “naturale” capacità di interagire con i propri pari; la formazione era volta a rinforzare questa capacità in particolare sul versante della gestione dei gruppi attraverso le tecniche proprie della psicologia sociale (brain storming, role playing…). L’introduzione del video negli interventi ha già costituito un salto dalla “naturalità” a una comunicazione mediata dalla tecnologia. In più casi ai peer si è affiancato un tecnico (operatore e/o regista) per le riprese e soprattutto per la postproduzione. Bisogna però osservare come le tecnologie digitali siano sempre più a bassa soglia e produrre un video ben confezionato, anche nella fase più complessa del montaggio, diventi sempre più facile grazie alle risorse direttamente reperibili in rete. Tanto più per i giovani che generalmente hanno agile dimestichezza con le nuove tecnologie.
Lo stesso vale per tutte le forme di comunicazione e presenza online: il problema non consiste nella capacità di accesso, partecipazione e utilizzo che rapidamente avviene in modo spontaneo, ma nella consapevolezza delle diverse specificità dei molteplici strumenti (un social network generalista è cosa ben diversa da una community dedicata a una tematica/interesse specifico ad es. musicale, o da un servizio di messaggistica istantanea come WhatsApp). Il peer&media educator sarà allora un peer in grado di muoversi agilmente tra i diversi registri comunicativi e i diversi codici propri della multimedialità digitale.
Abilità e competenze. Abbiamo altrove sottolineato le contraddizioni[4] fra mondo scolastico – in particolare, si può aggiungere, se caratterizzato dal “codice della collezione”[5] – e mondo digitale e indicato, nella prospettiva di una Peer Education 2.0, l’esigenza di far proprie le caratteristiche comunicative dei new media non per contrapporle a quelle scolastiche ma per aiutare i giovani – ma anche gli adulti – a convivere e travalicare quelle contraddizioni con lo spirito del passatore che si trova altrettanto a suo agio al di qua e al di là del confine.
Si potrebbe obiettare come la scuola stia già andando in tale direzione e l’uso delle nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione (ICT) sia sempre più diffuso; come l’utilizzo delle LIM e dei tablet con la loro multimedialità e connettività stia soppiantando gesso e cancellino, dizionari e libri di testo; come in sostanza si stia superando l’atteggiamento di chiusura e prevalgano apertura ed entusiasmo. Dalla demonizzazione alla mitizzazione verrebbe da dire. Sulla base di una mole ormai consistente di ricerche a livello internazionale Calvani (2012) sottolinea come le nuove tecnologie man mano introdotte nella scuola non abbiano di per sé prodotto miglioramenti nell’apprendimento e come, dopo una fase di entusiastica promozione e accettazione, succeda una fase in cui emergono le criticità, le incompatibilità e le lamentele, ad esempio sull’assenza di tempo. L’innovazione tecnologica di per sé non produce un salto di qualità soprattutto se non si supera l’ambiguità fra il concepirla come mezzo (learning with technologies) o come oggetto dell’apprendimento (learning about technologies) e non si è consapevoli «che sono le metodologie (e gli insegnanti che le impiegano) a fare la differenza». Di per sé la tecnologia può anche avere effetti negativi quale, ad esempio, la perdita di competenze cognitive che vengono delegate allo strumento (estroflessione cognitiva)[6].
Le nuove tecnologie, in sostanza, abbisognano di innovazione didattica e metodologica: questo vale per la scuola come per l’educazione in genere. Non è pensabile una Peer&Media Education senza una profonda riflessione e adeguate sperimentazioni in questa direzione.
Facendo riferimento agli sviluppi della new media literacy Jenkins (2009) individua, nell’ambito delle competenze digitali, undici nuove abilità e per ciascuna di queste suggerisce attività e percorsi (in presenza e online) per svilupparle. Si può sottolineare come quattro di queste facciano già parte del patrimonio acquisito della Peer Education: Gioco, Simulazione, Performance (impersonare identità alternative), Intelligenza collettiva (confrontare opinioni e unire conoscenza); in questi casi si tratta di orientarle e sperimentarle anche in ambito digitale. Le restanti consistono nel campionare e miscelare contenuti mediali (Appropriazione), volgere l’attenzione contemporaneamente in più direzioni (Multitasking), interagire con gli strumenti espandendo le competenze cognitive (Conoscenza distribuita), valutare l’affidabilità delle diverse fonti (Giudizio), seguire e utilizzare una pluralità di piattaforme mediali (Navigazione transmedia), cercare, sintetizzare e immettere in rete informazione (Networking). Dell’ultima (Negoziazione) parleremo fra poco. Abilità e competenze di pertinenza in primo luogo della New Media Education e che la P&M potrà implementare e collaudare con attività e sperimentazioni, in ambito sia presenziale che, soprattutto, digitale, orientandole nell’orizzonte della prevenzione nella sua più ampia accezione.
Ultima osservazione, anzi interrogativo: facendo riferimento a Gardner (1983, 1993) e alla sua teoria sulla pluralità delle intelligenze, l’insieme di queste abilità digitali richiede la messa in campo di una pluralità di intelligenze o sono congruenti con una particolare forma di intelligenza? La seconda ipotesi è sostenuta da Battro e Denham (2007) i quali sostengono vi sia una specifica intelligenza digitale, da aggiungere alle nove indicate da Gardner[7], che essi chiamano appunto “intelligenza digitale” caratterizzata da specifici codici e icone e da una struttura di attività binaria: clic (porta aperta) / non clic (porta chiusa). Intelligenza che preesiste alle tecnologie digitali ma che trova in queste il suo ambiente, il suo contesto privilegiato. A significare come non basti esser “nativi” per esprimere talento digitale né utilizzare di continuo (smanettare) le nuove tecnologie per sviluppare questa intelligenza, ma sia necessaria una adeguata educazione; certo con l’eccezione (l’eccezionalità) dei talenti precoci che manifestano prestissimo una spiccata specifica intelligenza – per l’intelligenza musicale Gardner indica quale esempio Mozart – che nel campo digitale potrebbero identificarsi in qualche giovanissimo hacker[8].
Dimensione valoriale. La PE ha una dimensione valoriale insita nel suo stesso dna: la prevenzione quale azione nella comunità e per la comunità, la cooperazione all’interno del gruppo dei peer e a quello dei pari che comporta un proiettarsi verso una cittadinanza attiva e solidale.
Lo sviluppo digitale 2.0 orienta le attività online nella direzione di una cultura partecipativa (Jenkins, 2009) con possibilità “a bassa soglia” di esprimere attività informativa, artistica e civica in un ambiente «in cui la linea di demarcazione tra consumatori e produttori è sempre più sfocata» e dalla normatività “opaca” e comunque differenziata fra le diverse community. È il tema dell’autorialità e del suo esercizio consapevole.
Tra le competenze digitali Jenkins indica anche quella della Negoziazione definita come «l’abilità di viaggiare attraverso differenti comunità, riconoscendo e rispettando la molteplicità di prospettive e comprendendo e seguendo norme alternative»[9]. Si tratta di una competenza che ha di certo aspetti cognitivi (la capacità di passare attraverso codici e registri diversi, connessa alla abilità di navigazione transmedia; quella di esplicitare norme implicite ecc.) ma che ha soprattutto una valenza etica basata sul rispetto delle norme (della netiquette) e dei valori di riferimento delle diverse community a cui si partecipa.
Di fronte agli sviluppi della “civiltà tecnologica” e alla possibilità che produca ripercussioni drammatiche sull’ambiente e di riflesso sulle future generazioni, Hans Jonas (1979) ha ritenuto inadeguata l’etica tradizionale fondata sul rapporto con l’altro (il “prossimo”) e sulla reciprocità («il mio dovere è l’inverso del diritto altrui» e viceversa); il dovere assume una dimensione ecologica e si proietta nel futuro sulla base del “Principio responsabilità” che ci rende eticamente imputabili non solo delle nostre azioni ma anche delle loro conseguenze future. Possiamo, in modo traslato, applicare il Principio responsabilità anche alle tecnologie digitali: la nostra attività nel web può modificare l’ambiente digitale sia nella direzione della trasparenza, incremento delle conoscenze, solidarietà e civismo che in direzioni del tutto contrarie con ripercussioni che possono andare molto al di là di ogni possibile reciprocità; si può fare l’esempio di un video virale postato su YouTube.
Se la PE «è per sua stessa definizione ecologica… e rappresenta un buon esempio di ecologia sociale» (Croce et al., 2011, p.12) lavorando nella direzione di un riequilibrio fra gruppo dei pari e contesto sociale, una P&M matura avrà il compito di estendere questa dimensione ecologica all’ambiente digitale.
Abbiamo dunque visto, focalizzando questi quattro aspetti (gruppo, comunicazione, competenze, valori), come la PE, nel momento in cui si proietta nel digitale (PE 2.0), non possa far a meno di integrarsi con l’ambito teorico e metodologico della New Media Education e come una Peer Education 2.0 costituisca pertanto solo una tappa provvisoria verso il logico traguardo della Peer&Media Education.
6.3 Una definizione praticabile
La Peer&Media Education (P&M) – nell’accezione del Gruppo di Verbania e del CREMIT che ne hanno fissato idea e metodo – è un modello di prevenzione e intervento socio-educativo basato su una metodologia attiva che integra metodi e tecniche della Peer Education con gli approcci e gli strumenti della Media Education.
Questa integrazione si basa sull’obiettivo comune della Peer e della Media Education ovvero lo sviluppo di percorsi di riflessione e di prevenzione partecipata su tematiche di interesse condiviso che prevedano l’empowerment dei soggetti e dei gruppi coinvolti nei processi in funzione dello sviluppo di consapevolezza critica e responsabilità.
I protagonisti dell’intervento sono i peer, ovvero membri di pari status dei destinatari, che vengono formati sui temi della prevenzione dei comportamenti a rischio in presenza e nel web e sulle competenze:
- della gestione del gruppo presenziale e digitale;
- della comunicazione tra pari;
- dell’analisi dei media;
- della produzione mediale;
- delle metodologie di intervento e collaborazione online.
Gli obiettivi perseguiti sono:
- promuovere percorsi di prevenzione e promozione di comportamenti consapevoli, stimolando il protagonismo giovanile (e non solo) rispetto ai temi della promozione/prevenzione e della cittadinanza attiva;
- attivare percorsi nel contesto scolastico ed extrascolastico e nel web, sperimentando i nuovi linguaggi sia durante gli interventi in presenza sia nei social network e nelle community digitali;
- comprendere come le dinamiche educative nel presenziale e nel digitale possano integrarsi;
- fornire elementi di gestione del gruppo dei pari presenziale e digitale;
- fornire strumenti e tecniche di conduzione per intervenire sui pari, analizzando le differenze e le congruenze tra gruppo presenziale e digitale.
Il risultato è una forma innovativa di presenza educativa e di prevenzione che riconosce nei media, in particolare nei social network e nelle online community, una protesi identitaria fondamentale per il gruppo dei pari che trova altri spazi di espressione dove integrare e ridefinire i propri vissuti nell’ottica di una socialità espansa. In questo contesto i social network e le comunità online divengono uno spazio e uno strumento di intervento grazie all’attivazione di competenze sociali diffuse, nella prospettiva di un superamento della dicotomia tra presenziale e digitale.
Tale modello, nato e sviluppato soprattutto in ambito giovanile, si deve comunque ritenere trasversale rispetto a target diversi di età (età adulta, età anziana) e ai differenti ambiti della prevenzione (comportamenti sessuali a rischio, dipendenze, devianze) e dell’intervento educativo (cittadinanza digitale, identità di genere, sviluppo armonico della persona).
I percorsi di P&M prevedono l’interazione di risorse professionali e non che, grazie a corsi di formazione atti a sviluppare e valorizzare le doti naturali, le competenze e le risorse individuali e collettive del gruppo dei pari, mantengono le rispettive sfere di autonomia, sviluppando nuove forme di alleanza intergenerazionale.
La prospettiva. La P&M si caratterizza come una pratica educativa e sociale che incentiva la cooperazione e la partecipazione favorendo il progressivo sviluppo di capitale sociale (i peer delle successive generazioni) orientato alla cittadinanza attiva sia nelle comunità territoriali che nelle community (cittadinanza digitale).
Bibliografia citata
Battro, A.M. & Denham, P.J. (2007). Hacia una inteligencia digital. Buenos Aires: Academia Macional de Educación.. Trad. it. (2010). Verso un’intelligenza digitale. Milano: Ledizioni.
Calvani, A. (2012). Alla ricerca di una ragion d’essere per le ICT nella scuola. Psicologia dell’educazione, 6, 3, 293-300.
Croce, M., Lavanco, G. & Vassura, M. (Eds.). (2011). Prevenzione tra pari, Modelli, pratiche e processi di valutazione. Milano: FrancoAngeli.
Dalle Carbonare, E., Ghittoni, E. & Rosson, S. (Eds.). (2004). Peer educator. Istruzioni per l’uso. Milano: FrancoAngeli.
Gardner, H. (1983). Frames of mind: the theory of multiple intelligences. New York: Basik Books. Trad. it. (1987). Formae mentis. Saggio sulla pluralità dell’intelligenza. Milano: Feltrinelli.
Gardner, H. (1993). Multiple Intelligences: the Theory in Practice. New York: Basik Books. Trad. it. (1994). Intelligenze multiple. Milano: Anabasi.
Gardner, H. & Davis, K. (2013). Generazione App. La testa dei giovani e il nuovo mondo digitale. Trad. it. (2014). Milano: Feltrinelli.
Jenkins, H. (2009). Confronting the Challenge of Participatory Culture: Media Education for the 21st Century. Cambridge, Ma: MIT Press. Trad. it. (2010). Culture partecipative e competenze digitali. Milano: Guerini & Associati.
Jonas, H. (1979). Das Prinzip Verantwortung, Insel Verlag, Frankfurt am Main. Trad. it. (1990). Il principio responsabilità. Un’etica per la civiltà tecnologica. Torino: Einaudi.
Ottolini, G. (2011a). La strategia dell’ipotenusa. La prevenzione tra rete adulta e mondo giovanile. In G. Ottolini (Ed.), 43-54.
Ottolini, G., Beretta, M., Boschini, G. & Pesce, B. (2007). Pratiche di formazione e manutenzione del gruppo classe. In C. Pontecorvo & L. Marchetti (Eds.). Nuovi saperi per la scuola. Le scienze sociali trent’anni dopo. Venezia: Marsilio Editori, 157-175.
——————
Note
[1] Nell’esperienza verbanese tale fu ad esempio l’iniziale “Tavola rotonda” del 1996 che diede origine a tutta l’esperienza successiva (cfr. sopra cap. 1.1).
[2] Cfr. sopra cap. 1.2.2.
[3] P. Amerio, Gruppi, persone e istituzioni, 16.10.2003. Intervento al Convegno nazionale “Peer Education. Adolescenti protagonisti di quale prevenzione?” (Registrazione video). Cfr. anche, sempre di Amerio, la prefazione in Dalle Carbonare et al. (2004).
[4] In Ottolini, 2011a: p. 48-51; in sintesi queste le principali contraddizioni individuate: comunicazione verticale e orizzontale; monomedialità e multimedialità dei testi; monofunzionalità e isolamento delle diverse attività di contro a plurifunzionalità (attività multitasking); compiti risolutivi (a 1 soluzione) e compiti adattivi (a n soluzioni); lavoro individuale e lavoro cooperativo; concezione del sapere lineare e deduttiva di contro ad concezione organica e integrata; spiegazione come esplicitazione e dilatazione di tutti i passaggi logici e di tutte le connessioni di contro a spiegazione come agile ricapitolazione in grado di suggerire – più che esplicitare – passaggi e connessioni implicite e pertanto ritmo dilatato che richiede prolungata attenzione di contro a ritmo accelerato che richiede una concentrazione più intensa seppur di breve periodo.
[5] Cfr. sopra cap. 4, nota 6.
[6] Esempio tipico l’utilizzo della calcolatrice prima di aver acquisito le abilità di calcolo.
[7] Linguistica, Logico-matematica, Musicale, Spaziale, Corporeo-cinestetica, Intrapersonale, Interpersonale, Naturalistica, Esistenziale.
[8] Mi piace ricordare Aaron Swartz, programmatore già a 13 anni, precursore di Wikipedia, attivista dei diritti digitali, perseguitato come hacker per aver “praticato” il libero accesso su contenuti scientifici da database accademici protetti, morto suicida a 26 anni nel gennaio 2013.
[9] Jenkins, 2009, trad it. p. 166. Tra le attività online che l’autore suggerisce per sviluppare tale competenza, viene indicata la partecipazione ad una discussione connessa ad una voce di Wikipedia per rispettare al meglio le regole Wiki e, in particolare, quella (difficile) della neutralità.
Pubblicato il 4 luglio 2010 su Facebook e fatto circolare via mail, questo post divenne a suo modo virale con ripubblicazione su altre pagine facebook e su alcuni blog, in alcuni dei quali è ancora reperibile (*). Venne anche pubblicato (in versione cartacea) sulla rivista Animazione sociale.
Rileggendolo mi pare ancora attuale, al di là del sindaco leghista di turno salito agli effimeri onori della cronaca. Se ne trovano di simili ancor oggi: ad esempio quello di Mortara che se la prende con la squadra di calcio dei giovani rifugiati.
Al tempo dei muri di Orban e consoci questi episodi potrebbero sembrare piccola cosa, ma razzismo e intolleranza si costruiscono proprio a partire da piccoli episodi quotidiani ed è assolutamente sbagliato sottovalutarli.
Aeroporto di Amburgo, primo pomeriggio del 23 settembre 2000. Sono di fianco alla scala mobile che sale nell’area di imbarco mentre aspetto le quattro ragazze della mia scuola che ho accompagnato nella settimana precedente ad Emden per un workshop internazionale (Germania, Austria, Italia, Russia) sulla figura dell’educatore svoltosi presso il locale l’Istituto professionale (Berufsbildende Schulen I).
Le ragazze sono in giro per l’aeroporto a far fuori gli ultimi marchi prima di imbarcarsi. Sfoglio un giornale mentre curo tre carrelli con i nostri bagagli. La coda dell’occhio mi fa percepire uno strano movimento nell’area alle mie spalle. Alzo lo sguardo e osservo uno strano turista – tra i 60 e i 65 anni – che, proprio di fronte a me e alla scala mobile, va a ad appoggiarsi alla balaustra delle scale che scendono al piano inferiore.
Ha l’aria tranquilla di chi sa che deve aspettare e passa il tempo ad osservare il via vai. Mi colpisce il suo abbigliamento che era certo quello del turista (forse un inglese, penso) ma con qualche incongruenza. Un po’ trasandato ma a suo modo di un’eleganza vecchia maniera. Pantaloni di velluto, scarpe larghe e scamosciate, un soprabito un po’ fuori stagione visto che quel fine settembre era ancora abbastanza caldo e un cappello di feltro grezzo, mi pare di ricordare verde. Al suo fianco, appoggiata, una borsa di plastica larga ed alta che sembra contenere uno o due pacchi.
Ad un certo punto, ero ritornato al mio giornale, lo intravedo muoversi celermente ma senza scomporsi nel correre. All’inizio non capisco, la borsa era rimasta al suo posto e vedo il nostro “turista” prendere un carrello abbandonato a fianco della scala mobile e sistemarlo nelle guide dell’apposito deposito. Naturalmente recuperando la moneta di due marchi.
Allora capisco. Il nostro è una sorta di “barbone snob”. Quello è il lavoro che si è inventato: recuperare i carrelli abbandonati e riportarli a loro posto con un guadagno netto di due marchi a carrello; e magari il recupero di qualche oggetto, rivista od altro dimenticati. Nella mezzora che segue sono altri quattro o cinque i carrelli abbandonati da viaggiatori frettolosi di imbarcarsi. Faccio mentalmente un rapido calcolo e penso che se la media è quella, il nostro può guadagnarsi almeno dai 10 ai 20 marchi all’ora.
Quando tornano le quattro ragazze, senza dare a vedere, spiego loro l’attività del nostro dirimpettaio. Decidiamo di abbandonare a nostra volta i tre carrelli, tanto le monete in banca non le cambiano e tra poco più di un anno si sarebbe passati all’euro.
Mentre stiamo salendo sulla scala mobile mi volto ed incrocio lo sguardo del nostro; ha un mezzo sorriso d’intesa. Ci siamo capiti.
29 giugno 2010. La giunta leghista di Montecchio Maggiore (comune già famoso per il caso della mensa che aveva tenuto a pane e acqua i bambini non in regola con la retta) approva il regolamento di polizia urbana che all’art. 34, intitolato « Divieto dell’esercizio del mestiere girovago del cosiddetto “accompagnatore di carrelli della spesa” »– così recita: “È vietato su tutto il territorio comunale l’esercizio del mestiere girovago di “accompagnatore di carrelli della spesa”.
Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria, da euro 25,00 ad euro 500,00.”
Leggendo questa notizia segnalatami da Facebook la prima cosa che ho pensato è che alla definizione di Carlo M. Cipolla secondo cui gli stupidi sono coloro che riescono a recar danno contemporaneamente a se stessi e agli altri si potrebbe anche aggiungere: coloro che non si rendono conto del ridicolo del loro agire.
Mi è poi visivamente tornato alla mente l’Accompagnatore di carrelli di Amburgo. Nella scala di Cipolla è certamente un rappresentante dell’intelligenza umana: capace di perseguire allo stesso tempo il vantaggio proprio e quello altrui. Mettere al loro posto carrelli che sarebbero di intralcio ai viaggiatori traendone un non insignificante guadagno.
Chissà se è ancora al suo posto? Mi piace pensare che la sua scelta dell’aeroporto non fosse casuale o solo frutto dell’ingegno, ma una sorta di preparazione al suo grande viaggio. Me lo immagino in qualche paese esotico a godersi, con meritato riposo, i marchi (e poi gli euro) accumulati carrello dopo carrello. Alla faccia degli stupidi intolleranti che non sanno apprezzare varietà e diversità dell’essere e dell’agire umano.
————-
* Ad es. i blog di Marco Rossi Doria, Verbania Settanta di Claudio Zanotti e Una Verbania possibile.
Pubblicato in due successive note sulla mia pagina di Facebook il 13 e il 21 giugno 2010, fatto circolare anche tramite mail e ripreso su altri profili facebook e su un notiziario locale online.
Al di là del titolo (la seconda “puntata” era titolata più ottimisticamente C’è un futuro per la comunità del VCO?) il contenuto era abbastanza fiducioso nel futuro della nostra provincia.
Oggi (settembre 2015) tale fiducia mi pare mal riposta e, come scrivo in un altro recente post, frutto di un equivoco.
Non cambierei comunque (o aggiungerei molto) a quanto allora scrissi su Comunità e Politica di comunità.
Le brevi proposte finali hanno dato vita alla Video inchiesta Giovani e lavoro di cui ho reso conto nel relativo post.
Vi sarà ancora una provincia del VCO?
Nelle scorse settimane si è assistito, sull’onda della politica dei sacrifici “lacrime e sangue” alla pantomima sul futuro delle province. Dove tutti in linea di principio sono per abolire e/o tagliare, purché non a casa propria.
C’era chi sosteneva che tutte le province debbon esser abolite, ma senza chiarire quali le future articolazioni territoriali tra i Comuni e le Regioni. Subito insorge Bossi : “Guerra civile se toccano Bergamo!”
Arriva poi la proposta di abolire solo quelle inferiori a 220 mila abitanti. Atri insorgono ed allora la “furbata” di escludere regioni autonome e province di confine. Furbata “nordista” perché non si capisce qual differenza c’è fra una provincia che “confina” con le montagne ed una che “confina” col mare. Storicamente è sempre stato più difficile varcare i monti che il mare e le città marinare sono da sempre intersezione fra culture.
Scorporato all’ultimo momento dalla manovra anticrisi, il taglio delle province si ripropone poi per tutte quelle sotto i 200 mila abitanti con un apposito disegno di legge. Ma subito arrivano emendamenti ed emendamenti di emendamenti: prima (8 giugno) si salvano quelle a territorio prevalentemente montano per le quali il limite scende a 150 mila abitanti; ed infine, del gran taglio rimanendo solo quattro province (Vercelli, Fermo, Isernia e Vibo), si decide (10 giugno) che non se ne fa più nulla.
Non voglio qui entrare nel merito province Si/No (ed eventualmente quali) né limitarmi a deprecare il meschino spettacolo dei politici che invocano i tagli solo per gli altri, esaltando ognuno la irriducibile specificità del proprio territorio provinciale.
Il quesito principale non mi sembra: VCO provincia Si o No e, se No, con chi aggregarsi (Novara per tradizione, Vercelli per maggiore affinità, oppure provincia quadrante – VB, VC, BI, NO – per dar forte contrappeso al Torino-centrismo?).
Il quesito politico principale mi pare sia un altro: il Vco è o può effettivamente diventare una comunità? È vissuto come tale dai propri abitanti? Le forze politiche e sociali hanno sinora lavorato in questa direzione? Pare evidente la risposta negativa.
Le comunità non sono semplici ripartizioni amministrative, non si proclamano per decreto, ma nemmeno sono entità eterne ed immutabili. Le comunità cambiano e, se vi è una volontà collettiva, si costruiscono nel corso del tempo.
Il destino del VCO mi pare essenzialmente legato (permanga provincia o meno) proprio a questo: riuscire a diventare (ed agire come) una effettiva comunità. Quel che sinora non è stato.
Il VCO o è / diventa una comunità o è senza futuro
È abbastanza evidente come i partiti della nostra provincia abbiano sinora giocato a quella che può esser definita quale “politica dei campanili contrapposti”. Le principali scelte (e spesso “non scelte”) si sono appunto basate su preclusioni, campanilismi, alleanze trasversali “contro” (sanità, economia, politica del territorio, designazione dei candidati ecc. ecc.) attraverso veti e fragili equilibri che poco avevano a spartire con l’interesse dell’intera comunità provinciale. Naturalmente questo non riguarda solo i partiti ma l’intero tessuto sociale ed associativo (i sindacati ad es.), culturale ed informativo (ad es. gli organi di stampa locali che, a parte quello vescovile, non sono provinciali ma dividono/accorpano le aree di riferimento secondo altri criteri), ecc. ecc.
Emblematico che il capoluogo sulla carta (Verbania) non si sia mai sentito tale (e tanto meno come tale accettato) e che il nuovo sindaco invece di pensare a Verbania come capoluogo (ruolo non necessariamente centralistico) del VCO, si inventi una fantomatica “Capitale dei Laghi Europei”: tra la fuga di responsabilità da un lato e lo spot turistico vuoto di effettivi contenuti dall’altro. O che il (l’ex) sindaco di Domodossola, probabilmente per mettere in secondo piano le difficoltà di successione, rinfocoli oggi la polemica sulla scelta del capoluogo.
In effetti non ci vuole molto a sottolineare le diversità fra i tre territori che compongono la nostra provincia sia per il per paesaggio (montagne ossolane, Lago Maggiore, Lago d’Orta), che per le attività produttive e lavorative e, non ultima, per la diversità degli insediamenti e dei flussi migratori sia nei tempi che per provenienza.
Sostenere che il VCO non è una comunità, ma come dice il nome stesso, la somma di (almeno) tre comunità ben diverse è assai facile. Ancor più facile agire di conseguenza.
Ma forse qualcosa sta cambiando e, soprattutto, qualcosa deve cambiare. La crisi occupazionale ha messo in evidenza la fragilità strutturale del nostro territorio e non è un caso che i lavoratori abbian messo alla testa dei loro cortei prima del nome delle fabbriche in crisi o delle loro città, la parola d’ordine “vertenza VCO”. La singola fabbrica, il singolo comune, la singola zona cusiana/ossolana/verbanese non ce la può fare da sola. Il conflitto principale non è più operai/padrone, non è più interno alla comunità, ma tra la comunità stessa e processi decisionali esterni (delocalizzazione, finanziarizzazione, globalizzazione). O fronteggiamo tutti insieme la crisi e siamo in grado di pensare ad un diverso futuro unendo forze e risorse o il declino di tutto il VCO sarà inarrestabile. Permanga o meno la Provincia.
Il fatto stesso che Provincia e tre “capoluoghi” siano oggi amministrati con lo stesso segno politico di centrodestra può favorire il superamento degli antichi vizi di campanile spingendo le amministrazioni ad un progetto e un’azione unitaria. Così come le forse politiche di opposizione possono lavorare su di un progetto comune di alternativa, innestando una dialettica generale fra progetti per l’intero territorio e non più fra esigenze (o, peggio, ripicche) localistiche.
Ma la strada da fare è tanta mentre i tempi stringono.
Pensare ad una politica per il VCO non significa principalmente, a mio parere, trovare fondi, finanziamenti, sgravi fiscali, leggi autonomistiche ecc. (in sostanza aiuti/privilegi provenienti dall’esterno) ma “contare sulle proprie forze”, progettare il proprio futuro sulla base delle proprie risorse umane, professionali e culturali, delle ricchezze territoriali, ambientali ed artistiche che possano prospettare un futuro diverso il più possibile autonomo e non dipendente da processi economici sovrastanti.
Cos’è una comunità?
Scrivevo non tanto tempo fa1 che
“il tema della comunità costituisce una sorta di ‘buco nero’ nell’orizzonte tematico delle cultura politica italiana (della sinistra in particolare). La prevalenza di culture universalistiche (cattolicesimo, liberalismo, socialismo) ha messo ai margini le riflessioni e le esperienze sviluppatesi in questo ambito (il Movimento di Comunità nel Canavese, l’omonima casa editrice, Danilo Dolci, la scuola di Psicologia di Comunità di Amerio ecc.). Con il risultato che ci si è trovati del tutto impreparati – lasciando lo spazio al comunitarismo rozzo e premoderno della lega – quando, di fronte agli attuali processi di mondializzazione economica e culturale, il bisogno di comunità emerge con prepotenza.”
Certo il termine “comunità”, e soprattutto il suo uso, non è esente da ambiguità, ma sono sempre più convinto che è questo oggi un terreno (una dimensione) fondamentale della politica. Ossia che oltre al confronto fra destra e sinistra (il tema dell’eguaglianza fra le persone e fra i ceti sociali), fra autorità e libertà (di pensiero, di scelta e di azione individuale e collettiva), fra centro e periferia (stato e autonomie locali), fra economia ed ambiente, sia sempre più centrale il tema della comunità e del suo rapporto con gli individui, il territorio, l’ambiente, le reti interne ed esterne che le permettono, attraverso la partecipazione di perseguire il “bene comune”2.
Certo, vi è un comunitarismo rozzo ed identitario che concepisce la “comunità” come un aggregato di “identici” che affonda le sue “radici” nel territorio (sangue e suolo), che pensa di rafforzarsi chiudendosi rispetto all’esterno, che esalta in modo ideologico l’essere identici e a tal fine inventa miti e simboli identitari (magari mescolando simbologie celtiche, neopagane e cristiane). Un comunitarismo conservatore che può anche avvicinarsi a qualcosa di simile al nazismo (i miti celtici/ariani della razza). Comunitarismo che va affrontato in primo luogo smascherandone il suo carattere ideologico che nasconde la realtà effettiva (nessuna comunità è comunità di identici) sia la sua fragilità teorica: la teoria dei sistemi per prima cosa ci insegna che un sistema chiuso è un sistema fragile, non in grado di rinnovarsi e riadattarsi ai mutamenti, al contrario dei sistemi aperti; la psicologia sociale sottolinea la “forza dei legami deboli” ovvero la capacità di apertura ed innovazione di cui possono esser portatori quei collegamenti (ponti) anche episodici che un individuo, una rete sociale, una comunità hanno con individui, reti e comunità esterne; la storia ci mostra come le grandi civiltà (da quella greca a quella nord americana) siano nate da un “crogiolo” (melting pot), da una fusione creativa di culture, lingue, tradizioni diverse; e si potrebbe continuare.
Comunitarismo che va però soprattutto affrontato con la capacità di concepire (e costituire) una diversa idea di comunità: articolata al suo interno, aperta, dinamica, in grado di individuare e perseguire il “bene comune” attraverso il confronto e la partecipazione democratica. Mi sembra questo oggi il principale terreno di confronto fra forze politiche e soggetti sociali e culturali del VCO: interrogare noi stessi per immaginare, progettare, costruire un possibile futuro della nostra comunità provinciale.
___________ . ___________
C’è un futuro per la comunità del VCO?
Appunti per una politica di comunità
Gli elementi di fondo per una politica di comunità mi sembrano essenzialmente quattro:
- Valorizzazione del capitale umano e sociale
Il benessere di una comunità è in stretto rapporto con il proprio capitale umano (le conoscenze, le competenze e le esperienze degli individui) e soprattutto con il capitale sociale (l’insieme di relazioni di fiducia e sostegno che permettono alle persone singole e ai soggetti collettivi – quali una associazione o una istituzione – di sostenersi attraverso relazioni extraeconomiche di aiuto). Se il capitale umano è un patrimonio che “risiede nelle persone”, il capitale sociale è un patrimonio collettivo che “risiede tra le persone”3. Le implicazioni sono a tutto campo e tutti gli studi hanno sottolineato come il capitale umano costituisca il patrimonio primario a disposizione di una collettività e come un elevato capitale sociale favorisca identità collettiva ed integrazione da un lato e maggior capacità di un territorio a fronteggiare cambiamenti quali quelli prodotti dalla globalizzazione.
Cosa può significare allora valorizzare il capitale umano e sociale? In sintesi significa porre al centro il tema dell’istruzione e della ricerca da un lato e dell’associazionismo e del volontariato dall’altro. Temi spesso lasciati in secondo piano dalla politica tradizionale. Eppure la nostra provincia è particolarmente ricca sia di scuole e istituti di ricerca di qualità che di una realtà associativa particolarmente estesa.
Non basta “difendere” le nostre scuole e le strutture di ricerca e/o mettersele all’occhiello: occorre individuare in questo settore il terreno prioritario di investimento reperendo risorse sia umane che economiche, valorizzarne le iniziative, sostenere e favorire il raccordo reciproco e con l’insieme delle istituzioni culturali. Pensare in sostanza all’insieme del “settore della conoscenza” come all’ambito primario di investimento per lo sviluppo futuro.
Per quel che riguarda l’ambito del volontariato e dell’associazionismo in tutti i suoi settori (da quello sportivo a quelli di aiuto alle persone, di soccorso, di prevenzione e tutela del territorio, a quello culturale ecc.) la prima osservazione è che questo ambito è stato perlopiù considerato (dalla sinistra in particolare) come un “fratello minore” rispetto alla politica, costituito da persone che si occupano di aspetti secondari e non come ricchezza primaria della comunità, come il terreno appunto dove il perseguimento del “bene comune” avviene in modo spontaneo e solidale. La conseguenza è che è stato spesso ignorato ed abbandonato a se stesso, poco sostenuto e soprattutto poco valorizzato dalle istituzioni lasciandolo in questo modo talvolta scivolare verso gestioni personalistiche e/o privatistiche.
- Sviluppo delle reti sociali
Non solo valorizzare il capitale umano e sociale, ma soprattutto favorire il confronto e l’aggregazione, la messa in rete sia attraverso nuove connessioni e raccordi tra soggetti e gruppi che attraverso l’estensione della rete “on line”, non solo quale finestra sull’esistente, ma come grande opportunità di estensione di relazioni. Ad esempio uno o più portali internet, servizi collettivi di messaggistica ecc. ecc. Avendo come cura e preoccupazione di pensare sempre all’intero VCO come orizzonte di partenza e di guardare fuori, di stabilire legami con realtà significative ed innovative anche al di là della provincia, della regione e della nazione. Ponendosi talvolta finalità ed obiettivi espliciti, ma essendo consapevoli che le nuove proposte e i nuovi progetti spesso sorgono proprio dalla “semplice” messa in relazione di realtà diverse. Pensare ad esempio agli eventi promossi dalle associazioni non solo come occasioni di svago e di una pur significativa “messa in mostra” delle proprie attività e realizzazioni, ma soprattutto come grosse occasioni di relazione ed arricchimento fra realtà ed esperienze diverse.
- Tutela, gestione e valorizzazione dei “beni comuni”
È probabilmente questo l’ambito di maggior novità che obbliga a riparametrare molte delle categorie politiche (in particolare di economia politica) sin qui utilizzate. Comunità e “bene comune” sono strettamente connessi: la etimologia di “communitas” deriva infatti da “commune” vocabolo neutro latino che indica appunto il possesso o bene comune. Ma se sulla “comunità” una adeguata riflessione sociologica si ha già a partire dall’Ottocento (es. Comunità e società di Ferdinand Tönnies del 1887), una adeguata riflessione sui “beni comuni” è del tutto odierna: è di meno di un anno fa l’assegnazione del premio Nobel per l’economia ad Elinor Ostrom4, l’eterodossa economista che si batte per la difesa dei beni comuni sia naturali che culturali e virtuali affermandone con forza sia l’esistenza che la efficacia economica della loro gestione. In molti casi, laddove i beni comuni sono comunitariamente presenti e riconosciuti, la loro gestione collettiva è più efficace ed economica sia di quella pubblica (statale) che di quella privata. In sostanza non bisogna più ragionare in termini di economia privata e pubblica, ma di economia privata, pubblica e comunitaria. Quest’ultima da valorizzare e tutelare difendendola dalle privatizzazioni (dalle nuove “recinzioni”). Né bisogna pensare ai “beni comuni” come residuo arcaico, premoderno, presente solo in società scarsamente “sviluppate”. Se un certo tipo di beni comuni legati al territorio e alle sue risorse (le acque, i pascoli, i boschi, ecc.) sono certo più presenti in società a minore industrializzazione, c’è tutta una vasta gamma di beni comuni del tutto moderni ed in estensione. Pensiamo all’insieme del settore della conoscenza nonché ad internet ed in particolare a quanto oggi si sta aprendo tramite web 2.0 ed i nuovi media; ed anche qui, non a caso, si affacciano i sostenitori di nuovi vincoli e nuove recinzioni.
Ma cos’è un bene comune?
“Un bene comune (commons) vale a dire una risorsa condivisa da un gruppo di persone e soggetta a dilemmi (ossia interrogativi, controversie, dubbi, dispute ecc.) sociali. “5
“La grande virtù dei beni comuni come scuola di pensiero è la loro capacità di far riferimento all’organizzazione sociale della vita, la cui creatività è in larga misura autonoma dal mercato e dallo Stato. I beni comuni rivendicano la sovranità di questa attività culturale, la considerano un’economia separata che lavora in tandem con il mercato, svolgendo il proprio ruolo significativo (e spesso più importante). I beni comuni non sono un manifesto, un’ideologia, uno slogan: sono un modello flessibile per parlare della ricca produttività delle comunità sociali, e delle recinzioni del mercato che la minacciano.
L’ampiezza dell’interesse nei confronti dei beni comuni sta raggiungendo nuovi livelli, il che suggerisce che essi rispondano in modi culturalmente attraenti ad alcune esigenze molto concrete. I beni comuni permettono di articolare nelle discussioni di politica pubblica un nuovo sistema di valori; offrono strumenti utili e un vocabolario che aiuta la collettività a riaffermare il controllo sulle proprie risorse comunitarie; contribuiscono a dare un nome al fenomeno di “recinzione” da parte del mercato e a identificare meccanismi legali e istituzionali per proteggere le risorse condivise.”6
È sufficiente aprire un banchetto contro la privatizzazione dell’acqua, vedere l’interesse che immediatamente suscita per capire come questa tematica dei beni comuni costituisca un nervo scoperto della nostra società.
Quali i beni comuni della nostra comunità del VCO?
Indico alcuni dei principali con la consapevolezza che il confronto su questo ambito è ancora tutto da iniziare e che per ognuno di questi beni comuni andrebbe sviluppata una apposita strategia politica di riconoscimento, libero accesso, valorizzazione e sviluppo.
- Risorse idriche, energetiche, forestali ecc. del nostro territorio.
- L’ambiente quale bellezza naturale da tutelare/usufruire/valorizzare (dalle montagne ai laghi)
- Il patrimonio artistico, architettonico, insediativo (la bellezza prodotta dall’uomo)
- I beni culturali quali musei, biblioteche, enti di ricerca ecc.
- La conoscenza e i prodotti scientifici ed artistici, quali beni comuni di libero accesso (sia materialmente che on-line)
Può sembrare un discorso molto teorico, ma si potrebbero fare molti esempi. Uno per tutti. Un bene artistico di pregio quale Villa Poss7 a lungo abbandonato al declino e che vede oggi l’avanzare di una devastante speculazione edilizia8, riconoscerlo come patrimonio collettivo assumendo come prospettiva l’ormai decennale progetto del Museo del Paesaggio (un centro di studi, anche a livello universitario, e di ricerche sul paesaggio, sui giardini, sulla botanica e sull’orticultura) e/o pensarlo come futura sede dell’Università del VCO che è attualmente in crisi e che va ripensata e ristrutturata. Il tutto con un ruolo attivo nella progettazione e nella gestione delle associazioni culturali e di tutela ambientale e di enti di ricerca sia locali che nazionali.
- Progettare il futuro
Mi pare questo il punto maggiormente dolente/carente di tutta la politica della nostra provincia. Premesso che progettare il futuro significa parlare delle (e con le) nuove generazioni, quello che sconcerta è la totale assenza di una politica giovanile che non sia solo ancorata all’oggi e ad elementi tutto sommato marginali (es. il tempo libero ecc.). Ma su temi quali il lavoro, l’occupazione, le nuove attività lavorative, la valorizzazione e l’estensione del capitale sociale e delle reti, i giovani non sembrano presi in considerazione. I punti indicati in precedenza, così come tutto il dibattito su lavoro e occupazione nella nostra provincia9, se non vengono riferiti in modo prioritario alle politiche giovanili, rischiano di essere asfittici, senza apertura e senza prospettiva.
Le conoscenze sulla condizione e le aspettative dei giovani del VCO sono assi ridotte e quelle significative effettuate prive di effettiva ricaduta10. Le reti di capitale sociale ormai consolidate (es. quella della peer education) prese in considerazione in modo tutto sommato marginale.
Di seguito alcune indicazioni e proposte molto provvisorie:
- Pensare alle politiche giovanili come politiche non solo settoriali (es. il disagio, il tempo libero, l’associazionismo, la scuola ecc.), ma quali “politiche a tutto campo” rivolte al complessivo futuro produttivo, lavorativo, culturale e sociale della nostra provincia;
- Pensare alle politiche giovanili sempre (almeno) a livello di intero VCO: una provincia che può diventare, esser proposta ed esser vissuta come un’unica città policentrica ed ecocompatibile;
- Un’unica città che abbia un trasporto pubblico efficiente e diffuso a tutta la Provincia, a partire da quello che è attualmente l’asse di trasporto più “intasato” di Verbania-Omegna. Il “vecchio” progetto di una metropolitana leggera Verbania Intra, Stazione Fondotoce, Omegna era davvero così futuribile?
- Sviluppare “luoghi” ed occasioni che diano ai giovani (e alle associazioni prevalentemente giovanili) possibilità di incontro e di aggregazione non solo per il tempo libero ma come possibilità di scambio di conoscenze ed esperienze: il giovane isolato è quello che più difficilmente “trova” (o “si inventa”) un lavoro.
- Individuare nuovi settori di sviluppo dell’occupazione giovanile (energie rinnovabili, turismo ambientale e culturale, turismo scolastico, sviluppo di servizi per attività sportive legate all’ambiente, creatività artistica, nuove tecnologie e nuovi media, ecc.).
- La messa in opera di strumenti di conoscenza della effettiva condizione e delle aspirazioni dei giovani nelle più diverse situazioni: dalla precarietà ai nuovi lavori, da chi rimane nel VCO a chi è emigrato altrove.
Una piccola proposta a breve termine:
- Nascita di un organismo (una “officina del futuro”) che aggreghi giovani di tutta la provincia e provenienti da diverse esperienze;
- Organizzazione (progettazione e ricerca finanziamenti) di una video inchiesta sociale, condotta e gestita da giovani, sulla condizione giovanile ed occupazionale nel VCO incentrata su:
- Disoccupazione e precarietà lavorativa giovanile
- “Fuga” dei giovani dal VCO
- Nuovi lavori e nuove occupazioni
___ . __________ . ___ . ___ . __________ . ___
Postscriptum
Rileggendo l’insieme di questi miei due interventi sul possibile futuro del VCO mi rendo conto della grossa discrepanza fra il quadro delle riflessioni e le proposte accennate. Lo scopo era però quello di avviare un dibattito.
Proposte e progetti possono delinearsi e trovare gambe per camminare solo attraverso il confronto fra i diversi soggetti: soggetti individuali e collettivi; soggetti sociali, culturali, economici e politici.
È una scommessa. Ce la possiamo fare.
————————————————————————-
- Nuove dimensioni per la politica?: https://www.facebook.com/notes/gianmaria-ottolini/nuove-dimensioni-per-la-politica-noterelle-parte-2/68759889996
- Il bisogno di comunità : https://www.facebook.com/notes/gianmaria-ottolini/il-bisogno-di-comunit%C3%A0/68745054996 oppure L’orizzonte della comunità e la strategia del capitale sociale (con Mauro Croce) http://www.lasocietainclasse.it/oldpassaggi/sites/default/files/peereducation.pdf
- OCDE [OCSE] (2001), Du bien-être des nations. Le rôle du capital humain et social. Enseignement et compétences, Paris
- Elinor Ostrom ha vinto il premio Nobel per l’economia: https://www.facebook.com/notes/gianmaria-ottolini/elinor-ostrom-ha-vinto-il-premio-nobel-per-leconomia/85727849996 e Contro le enclosures digitali per una nuova utopia : https://www.facebook.com/note.php?note_id=34695264996
- HESS – E. OSTROM (a cura), La conoscenza come bene comune. Dalla teoria alla pratica, ed. italiana a c. P. Ferri, Bruno Mondadori, Milano 2009 , p. 3
- ivi, 43
- le schede del Museo del Paesaggio: http://www.museodelpaesaggio.it/it-it/home/paesaggio/schede/villa_poss_1
- Verbania News: http://www.verbanianews.it/joomla/fatti/politica/1170-poss (link non più attivo)
- il doc. La crisi del lavoro nel Verbano Cusio Ossola (di Carlo Alberganti per SEL) http://www.facebook.com/home.php?#!/note.php?note_id=421107732291 (link non più attivo)
- Es. la bella ricerca “Essere giovani nel Verbano Cusio Ossola” di Carlo Genova e Valentina Volonté (coop.
Comunicato
La Direzione generale della Politica Regionale e Urbana della Commissione Europea ha comunicato in questi giorni alla partnership territoriale che il progetto Interreg “UP2Peer” è stato selezionato come esempio della politica di coesione dell’Unione Europea e pertanto sarà inserito nel database comunitario che riunisce esempi di buone pratiche a livello europeo.
Il progetto Interreg “UP2Peer”, avviato nel territorio del VCO e del Canton Ticino nel mese di marzo del 2013 e attualmente in fase di conclusione, è stato promosso da una partnership composta da Provincia del VCO, associazione RADIX di Lugano, ASL VCO, Consorzio dei Servizi Sociali del Verbano, associazione Contorno Viola, cooperativa ICS e CREMIT dell’Università Cattolica del Sacro Cuore.
Il progetto si avvale del supporto tecnico di LBA Consulting, Daily ed Eclectica e si propone di contrastare, con strumenti innovativi, modalità dannose di consumo di bevande alcoliche tra i giovani mettendo in campo azioni orientate alla prevenzione degli incidenti stradali da guida in stato di ebbrezza alcolica grazie anche alle nuove tecnologie.
In questa prospettiva sono stati realizzati: interventi di prevenzione nell’ambito scolastico che hanno coinvolto oltre 1.200 studenti e una ventina di uscite nel territorio con una postazione mobile dedicata che hanno coinvolto circa 1.500 soggetti.
In particolare nel corso del progetto è stata sviluppata l’applicazione cALCOLapp, messa a punto grazie ad un evento residenziale con la partecipazione di peer educator italiani e svizzeri.
L’applicazione, disponibile su Play e Apple Store, prevede quattro sezioni: Alcol Test, che permette di ottenere una misurazione approssimativa dell’alcolemia; Test Driver che consente, attraverso due giochi, di valutare i propri riflessi e tempi di reazione; Quiz per determinare la conoscenza sul tema alcol e guida con domande a risposta multipla; Help, che in caso di emergenza consente di attivare rapidamente i soccorsi o valutare le soluzioni alternative per il ritorno a casa se non si è in condizione di guidare.
Ad oggi i download dell’applicazione sono oltre 4.000 a fronte dei 200 previsti dal progetto.
È in distribuzione in questi giorni il primo numero di “Nuova Resistenza Unita” del 2015.
Copertina ed editoriali sono dedicati ai fatti di Parigi.
Segnalo in particolare le “Spigolature” di Paolo Bologna che ci sono giunte pochi giorni prima che ci lasciasse.
Indice
p. 1 >> Editoriale: di Giuliana Sgrena
Editoriale grafico: di Ruggero Zearo
p. 2 >> Il male può essere banale? Attualità di Hannah Arendt: a cura di Gianmaria Ottolini
p. 7 >> A Caporetto, quasi un secolo dopo l’ultima battaglia sull’Isonzo: di Marco Travaglini
p. 10 >>Novecentodonne: di Luisa Steiner
p. 11 >> Che l’8 marzo torni ad essere … : di Elisabetta Colusso
p. 12 >> Riconoscimenti e ringraziamenti
p. 13 >> Notizie dal mondo delle biblioteche. Convegno delle Stelline 2015: di Chiara Uberti
>> 10 febbraio, Giorno del ricordo. Diario dall’Istria: di Giorgio Danini
p. 14 >> Spigolature: di Paolo Bologna
>> Giornata della Memoria 2015: di Monica Abbiati e Silvia Marchionini
p. 15 >> Carlo Grossini: di Bruno Pozzato
>> Recensione: Note a margine di Marco Travaglini
p. 16 >> Offerte/ ricordi/ notizie
>> Ricordo del partigiano Renzo Rizzi: di Massimo Zoppi
>> Notizie: “Note di musica. Concorso musicale”
Il 25 febbraio ricorre il 70° anniversario dell’eccidio di Trarego.
Nell’ambito della Convenzione fra Comune di Trarego Viggiona, Istituto Cobianchi e Casa della Resistenza che riconosce e tutela l’area monumentale di Promè quale luogo di memoria, la classe 5° Linguistico del Cobianchi ha preparato una lettura corale di documenti e testimonianze che saranno presentate mercoledì 25 febbraio agli studenti della scuola e sabato 28 presso la sala multiuso (località S. Mauro di Trarego Viggiona) in occasione del rinnovo e ampliamento della Convenzione.
Di seguito il testo predisposto.
Ma se l’uomo nato da mia madre avessi abbandonato, salma insepolta,
allora sì, mi sarei disperata: del resto non mi dispero.
Sofocle, Antigone
Presentazione
Buongiorno a tutti
Siamo la 5ALL del liceo linguistico dell’Istituto Cobianchi; oggi siamo qui con voi, a distanza di 70 anni dagli avvenimenti, per tenere vivo il ricordo delle vittime dell’eccidio di Trarego avvenuto il 25 febbraio 1945.
Poiché siamo una classe interamente femminile, ci è sembrato fin dall’inizio importante sottolineare il ruolo delle donne sia nella Resistenza in generale, sia in relazione alla trasmissione della memoria dell’eccidio. Le donne, infatti, ebbero diversi compiti tutti importantissimi e non sempre giustamente riconosciuti: alcune si preoccupavano di portare i viveri ai partigiani nascosti tra le montagne, di avvertirli dell’arrivo dei fascisti o di fare da staffetta, altre di curare i feriti e di ricomporre i morti, altre ancora imbracciarono direttamente le armi.
Per quanto riguarda l’eccidio di Trarego ci ha colpito il fatto che le vittime sono tutti uomini (partigiani e civili), ma la memoria, quella che è arrivata a noi attraverso le testimonianze, è quasi essenzialmente femminile. Sono le madri, le sorelle, le figlie e persino le suore dell’asilo, che ci hanno lasciato le parole più intense, le testimonianze più toccanti di quanto accaduto ai loro cari e a loro stesse dopo la strage. A loro è toccato il compito di riconoscere, ricomporre i corpi straziati e di celebrare i funerali, sfidando il divieto emanato dai fascisti.
Come Antigone nel mito greco, a loro è toccato il compito di elaborare il lutto negli anni successivi, lasciate spesso sole da istituzioni assenti e di tramandare in ogni occasione, vincendo il dolore e la pena, il ricordo di quanto accaduto. Siccome la maggior parte di queste donne straordinarie non sono più con noi, abbiamo voluto prendere le loro parole e farle nostre. Ci siamo basate principalmente sulle testimonianze contenute nel libro Memoria di Trarego e nel film-documentario “Trarego memoria ritrovata” del regista Lorenzo Camocardi, frutto del lavoro di ricerca di altre classi del Cobianchi, testimonianze che sono state trascritte, nelle parti che ci hanno più colpito, e riportate in prima persona. L’idea finale è stata quella di aggiungere queste voci, come in una specie di coro, al toccante resoconto dell’eccidio steso da Nino Chiovini, un anno dopo gli eventi, “Volante Cucciolo a Trarego” e pubblicato sul giornale “Monte Marona“.
Alle loro voci è dedicato il nostro lavoro.
25 febbraio 1945: Volante Cucciolo a Trarego
la Volante, a Trarego, è caduta senza retorica.
I Caduti di Trarego e tutti i nostri Caduti ci hanno insegnato.
La loro morte ci ha insegnato la vita e la via
di Nino Chiovini in “Monte Marona“, febbraio 1946
La Volante è tornata da un appostamento. È a Premeno. A Premeno arriva un biglietto di Arca. Un biglietto, un ordine di dieci parole: “La Volante deve raggiungere Scareno nel più breve tempo possibile“.
La Volante parte da Premeno. Parte di malavoglia: è appena tornata da un “giro” e vorrebbe stare un po’ a Premeno. Invece deve andare a Scareno. E Scareno non le è simpatico; ma parte, la Volante. E quasi, non canta. Si porta con sé un paio di bottiglie di cognac e qualche vasetto di marmellata, arrivato giusto allora. La Volante beve gli ultimi bicchieri al “Riposo”, poi saluta “mamma Luisina”. Esio, Aurano poi Scareno. E su, al Comando.
Arca è contento di rivedere la Volante. È sempre contento quando la ritrova. La saluta tutta e tende la mano a tutta.
Coro: E tutta la Volante lo saluta; ed è contenta di salutarlo.
Parla, Arca. Dice che in Cannobina la squadra di Dieci è stata attaccata. Ci sono dei morti: uno, forse, ė Dario. Dario era buono e anche un uomo. Un uomo di diciotto anni: un bambino a vederlo, un uomo a conoscerlo.
Arca dice che bisogna far qualcosa contro quelli che hanno accoppato Dario e il resto: contro la “Confinaria”.
Prima di partire, la Volante ha già vuotato una bottiglia di cognac ed ha superato la malinconia di Scareno.
Gigetto e Jubal si tirano le loro barbe: barbe di quattro peli biondi e castani, barbe forzate.
…
LUCIA ZUCCHINETTI: testimonianza su LUIGI VELATI (Gigetto)
Sono Lucia Zucchinetti, figlia della cugina di Luigi Velati: non ho mai conosciuto questo cugino di mia mamma perché è morto troppo giovane; ma lei me ne ha parlato spesso, mostrandomi le foto: bel tipo, atletico, sorridente mentre posa per il fotografo durante una gita in montagna. Perito chimico al Cobianchi, decise di unirsi alla Resistenza partigiana senza tentennamenti, forte e determinato come lo si può essere a vent’anni, consapevole di rischiare la vita da quel momento in poi, ogni giorno e ogni notte, dolce ma irremovibile davanti all’incredulità dei genitori e dei parenti.
Ricordo molto bene i genitori di Gigi, la zia Gina e Domenico Velati: la zia Gina non l’ho mai udita recriminare con il buon Dio per averle strappato quell’unico figlio in modo così crudele; penso volesse farsi carico della dignità e del coraggio da lui dimostrati, accettandone di conseguenza, senza lacrime anche la morte.
Un lampo d’orgoglio negli occhi quando qualcuno la salutava, mentre al cimitero di Pallanza, lucidava con amore il monumento funebre di Gigi o sistemava le ciotole dei fiori. Solo dopo la morte della zia Gina, abbiamo ritrovato nascoste in una scatola le reliquie più amare di quei giorni di lutto: il velo nero che ricoprì il bel volto del giovane su cui si infierì con crudeltà anche dopo la morte, le foto di un cadavere composto pietosamente dopo sevizie e brutalità. Nei nostri tempi, ancora segnati da guerre e dittature, possa il ricordo di Gigi e della sua morte, regalarci un nuovo desiderio di vera pace e libertà.
…
Poi, parte la Volante. Sugli scalini intona la sua canzone.
…squadra dell’allegria;
tra noi partigian non c’è malinconia.
Volante “Cucciolo” contenta e malinconica.
Coro: Nove uomini contenti e malinconici.
È contento Vola di essere accanto a Gino, Cesco accanto a Carluccio, Ermanno accanto a Gigetto, uno accanto all’altro. E la Volante fa i primi passi cantando, e uno allacciato all’altro.
E beve, beve anche l’altra bottiglia di cognac.
Gigetto dice che è ora di andare a dormire. Forse è meglio fermarsi alle prossime baite.
Tutti faticano e camminano nel buio senza luna: contenti e malinconici. Malinconici perché devono andare in Cannobina. Andare in Cannobina significa andare fra gente che non tutta ci vuol bene, gente che non tutta sta zitta; significa mangiar poco e soprattutto significa lasciare la zona bella, la zona che vede Intra, Pallanza e tutti i paesi che piacciono alla Volante.
Alle prime baite la Volante si ferma, entra in una e mette le armi al riparo del fieno. Poi dorme, malinconica e contenta. Nella Volante tutti si vogliono bene.
Coro: Bene sul serio. E dormono uno accanto all’altro, abbracciati. Così, dormono. Perché si vogliono bene.
…
GIULIANA LUBATTI
Sono Giuliana, sorella di Cesco, Gastone Lubatti
Mio fratello aveva undici mesi meno di me. Siamo cresciuti come gemelli, eravamo quasi coetanei.
Aveva il pallino per l’aviazione, e divenne volontario. E rimase lì fino all’otto settembre, quando è stato riportato a casa dai ferrovieri.
Per un po’ rimase a casa con noi, quando si ammalò di pleurite.
Poi arrivò la cartolina, ma lui con i “Mai morti” non ci voleva andare. Lui voleva andare in montagna. Voleva andare a combattere con i partigiani.
Così mio padre lo accompagnò sopra Omegna. Poi si spostò a Premeno, nella Cesare Battisti.
Erano tutti amici, lo andavo a trovare e facevano anche delle feste.
Mi ricordo una volta, una domenica sera, mi ha chiesto di fermarmi lì con loro. Abbiamo fatto una festa e lui disse a tutti: “Non toccate mia sorella, ha un fidanzato!”. Quella sera mi divertii molto, giocammo, ballammo, ridemmo.
È stata l’ultima volta che l’ho visto vivo.
La settimana dopo era già morto.
Lo rividi poi al cimitero. Nonostante fossero stati puliti e tamponati dalle suore erano irriconoscibili. Sdraiati su delle scale, il viso di mio fratello non era più il suo. Lo riconobbi dalla mano.
Mi ricordo solo quello, la sua mano. Non so cosa succede in quei momenti, ma mi sono scordata tutto; mi sono scordata anche di come sono tornata a casa.
Mia madre rimase a letto per giorni, non parlava, non mangiava, non piangeva. Io e mio padre avevamo paura di perdere anche lei. Poi un giorno finalmente pianse, mio padre mi abbracciò e mi disse: “È salva”.
Nino Chiovini, il comandante Peppo, ha lasciato nei suoi scritti memoria di Gastone, che mi piace ricordare: di lui dice che era l’ultimo arrivato nella Volante. Sebbene fossero stati stati compagni di scuola e di squadra di pallacanestro, si erano persi di vista. Nino, ricordando che Gastone aveva scelto la via della lotta di Liberazione nel dicembre ’43, racconta che si era distinto per il suo coraggio in varie azioni, come quella di Ompio, dove aveva imparato a serrare i denti per non crepare. Chiovini racconta come lo ritrovò nella formazione della Volante a Pian Cavallo. Aveva ancora il suo viso infantile, le efelidi sulle guance e più fitte vicino al naso, ancora la peluria chiara sotto le basette, come l’ultima volta che l’aveva visto; solo gli occhi grigio-azzurri erano quelli di un uomo. Di lui Nino ricordava anche la scanzonata scompostezza e la voce lenta e strascicata, sempre pacata, anche quando si arrabbiava.
…
La Volante oggi ha camminato, si è fermata, ha mandato una corvèe a Trarego per prendere viveri. Qualcuno ha fatto il bagno, qualcuno ha dormito, qualcuno ha preparato da mangiare. La corvèe è tornata con pane, carne, vino e una notizia: una pattuglia di fascisti sale tutte le sere a Trarego. Cinque/dieci fascisti, ora di arrivo, abitudini, itinerario e ora di partenza. C’è tutto. La Volante mangia, parte col buio, giunge a Trarego, lo lascia sopra di sé e si apposta sulla strada. Passa il tempo e i fascisti non passano. La squadra di Dieci resta com’è: con i suoi morti. I fascisti restano come sono: senza morti freschi. La Volante torna, cerca una baita col fieno, per dormire. Perché sono le due di notte. Al mattino, esce dalla baita la Volante. Si scrolla di dosso le briciole di fieno e sale su per il prato giallo sciatto di gelo vecchio: per cuocere la carne, sale.
A metà pendio vede uomini, uomini armati, cappello alpino. Un colpo di binocolo: “Confinaria”. A 150 metri. Tutti i sentieri sono pieni di “Confinaria”. Fascisti per tutta la montagna. E la Volante è nove uomini. La Volante tiene consiglio: tra le baite 200 metri dai fascisti. Poi ha deciso.
Coro: Deciso che cosa?
Sa che è in trappola e vuole uscire. Non si scalda e non perde tempo. Non smania e scherza ancora, ma pensa. Che cosa pensa? Ha deciso di non farsi pescare. Cerca un angolo morto per passare le ore che mancano al buio. Scende sparsa, sperando di essere defilata. Forse è defilata: se nessuno la vede. Come si fa ad essere defilati quando non c’è che prato quasi uguale chiazzato di neve e fascisti dappertutto?
Coro: Fascisti sopra su ogni sentiero, fascisti ai lati, fascisti sotto, a Trarego, a Oggiogno.
Ha trovato un angolo morto, la Volante: un catino, un imbuto di terreno, una conchetta, qualcosa per non lasciarsi vedere da tutte le posizioni. Nel catino la Volante parla. Parla, racconta e ride. Cesco racconta e gli altri ridono, Jubal racconta e gli altri ridono, Gigetto racconta e gli altri non ridono: perché parla di Fondotoce. Poi parla Ermanno, poi di nuovo Cesco, poi qualcuno ancora e gli altri ridono, meno quello di guardia che non sente. La Volante ride e non si dà pensiero. Vede i fascisti e non si scalda. Vede le baite bruciare e allora si arrabbia: si chiede perché i fascisti incendiano le baite.
Coro: Che colpa hanno le baite?
Poi, torna contenta di nuovo.
Coro: Contenta di essere tutta assieme, uno accanto all’altro.
Poi, verso sera c’è Vola di guardia e Vola dice che un reparto di 43 uomini scende verso il catino.
La Volante tiene consiglio e decide. Scendere in valle, e con la notte risalire l’altro versante, passando tra i loro presidi.
Brutto è decidere, poi si scherza ancora. Fuori dal catino, la Volante imbocca il sentiero appena segnato, scende verso la valle passando sotto il roccione.
Una raffica scuote il silenzio dei sassi che rotolano pianamente: e la Volante si ferma. Guarda e vede una fila di uomini in cima al roccione: sente altre raffiche e si butta lungo il pendio pelato.
Le raffiche infittiscono, passano accanto alla Volante, fischiano tra la Volante. E la Volante passa accanto alle raffiche, passa nelle raffiche e si muove tra le raffiche.
Coro: Poi, la Volante si muove nel suo destino.
Il destino di Ermanno che, sotto il roccione, spara finché avrà colpi. Il destino dei vivi che il caso lascia vivi. Il destino degli altri che si fermano al muretto. Un muretto a secco, dove comincia il prato. Dietro il muretto, uno accanto all’altro. E i corpi, uno accanto all’altro. E arrivano uno accanto all’altro. E colpiscono quelli della Volante:
Coro: uno accanto all’altro.
…
BRUNA GIARDINI
Sono Bruna Giardini la sorella di Ermanno. Il giorno dell’eccidio sono tornata da scuola e mia mamma mi ha detto: Devi andare su a Trarego perché è venuta la signora Tranquillini ad avvisare che ci sono dei partigiani morti. Mio papà e mio zio erano già avanti. Con la bicicletta sono andata fino a Cannero e poi ho preso tutte le scorciatoie a piedi. Quando sono arrivata mi hanno fatto vedere i morti. Li ho visti proprio tutti! Ero quasi convinta che mio fratello non ci fosse, l’ultimo invece era lui ed era il più conciato di tutti: gli han portato via mezza faccia, era tutto tamponato. Avevo quattordici anni…Mia mamma, una volta finita la guerra, non ha retto al dispiacere di vedere i partigiani che scendevano dalle montagne e suo figlio non c’era perché era già due mesi che era morto. La gente, alla fine della guerra, ha dimenticato tutto. Noi siamo stati sempre persone tranquille e non abbiamo cercato vendetta. Ho testimoniato a tutti e due i processi anche perché sono stata la prima a vedere i morti:il tribunale voleva sapere cosa realmente avevo visto. Purtroppo mi aspettavo che fosse fatta giustizia e invece…
…
Poi, Cesco dice che sono tutti morti e feriti e che la piantino di sparare. Lo dice ad un ufficiale: “Disgraziato, piantala di sparare: son tutti morti e feriti.” Ed è ferito anche lui. E dice proprio “disgraziato”.
La “Confinaria” smette di sparare di lontano. Si avvicina e spara da vicino. Da due metri, spara. Sui morti e sui feriti. Raffiche lunghe, senza senso, per diritto, per traverso. Calci di mitra che spaccano le ossa già rotte dalle raffiche.
Sette morti. E la Volante eran nove. Due borghesi, e fanno nove. Perché due borghesi? Nove morti.
Nove morti e 348 ferite. Nove morti massacrati.
Coro: La Volante morta: uno accanto all’altro, come la Volante viva.
IVO BORELLA (Villa)
Classe 1919
Villa faceva il contadino, prima. In montagna era venuto, ma nessuno ricorda che lui abbia spiegato a qualcuno il perché. Forse non lo avrebbe saputo neanche spiegare, perché non era uno che sapesse spiegarmi tanto bene. Di sicuro glielo diceva il cuore, di starci, perché con quel rospo d’asma che gli gonfiava il petto ad ogni rampa, poteva starsene anche a casa. Invece ci stava di cuore con noi. Non era il solo ad essere così. Con noi c’erano molti giovani a cui solo il cuore aveva fatto indovinare la via. Uno era Villa. Con le parole non sarebbe mai riuscito a indicarci la via.
Adesso la sua vita, da quando lo abbiamo conosciuto a quando è morto, è una via.
CORRADO FERRARI (Jubal)
Classe 1920
Perché un uomo, assordato dai colpi, con i muscoli rotti dai colpi, si alza e sceglie per le sue ultime parole: “Viva il comunismo?” Jubal ha fatto questo. Jubal lo sa. Jubal stava per morire e ha voluto lasciare agli altri queste parole. Gli uomini che muoiono con più calma lasciano un testamento spirituale. Jubal aveva fretta e ha lasciato solo un grido.
LUIGI VELATI (Gigetto)
Classe 1923
Nel giugno ’44 Gigetto era a casa, a Pallanza. Vide sfilare i 43 uomini verso Fondotoce. E li vide morire. Poi, arrivò da noi. “Per quelli di Fondotoce”, disse.
Venne in montagna per i morti, soffrì per i morti, sparò per i morti. E imparò dai morti. Infine morì lui, a Trarego.
E noi abbiamo imparato da lui e ancora impariamo da Gigetto e da tutti i nostri morti: più che dai libri più belli. I morti sono libri che non si scordano e che fanno imparare molto.
E Gigetto è un bel libro.
ERMANNO GIARDINI (Ermanno)
Classe 1924
Forse Ermanno è morto soddisfatto: tutti i colpi fuori dalla canna prima di morire.
Lo cedettero il Capo.
E il suo viso era macinato dalle schegge di una bomba a mano e dai colpi di calcio di un fucile manovrato per la canna. Di chi era la mano che teneva la canna del fucile?
Perché Ermanno quando costui cominciò l’opera, era già morto.
GASTONE LUBATTI (Cesco)
Classe 1925
Cesco aveva diciannove anni. Diciannove anni e il viso da bambino quieto. Si preoccupava più dei compagni che di sé. Poi voleva essere lasciato in pace. Poteva starsene a casa, ma diceva che i fascisti gli toglievano la pace e che avevano torto e, allora, per tornare tranquillo, salì in montagna a sparare: nel dicembre del 1943.
A Trarego, quando si accorse che lui era il ferito più leggero, gridò ai fascisti di piantarla di sparare. I fascisti si fecero sotto e macinarono colpi sui compagni, poi gli chiesero se voleva arruolarsi con loro. Rispose solo che gli facessero fare la fine dei compagni.
E questa non è retorica dell’eroismo.
LUIGI LESCHIERA (Gino)
Classe 1922
Gino era l’uomo Gino. Anzi è l’uomo Gino. Ė perché l’uomo sapeva sempre quel che voleva. Sapeva perché è diventato partigiano. Sapeva perché sparava. E lo diceva agli altri, a quelli che ancora non sapevano. Quasi non lo diceva a parole. Adesso non lo dice a parole. L’hanno imparato gli altri per quello che non faceva e per quello che non diceva.
A Trarego è morto senza parole. Gino non è di quelli che si sentono morire. Se ne è andato senza rumore.
PIERINO AGRATI (Vola)
Classe 1919
Vola era cugino di Gino. Abitavano dalle stesse parti, erano cresciuti quasi assieme, la pensavano allo stesso modo. Solo, Gino agiva più col cuore; Vola più con la testa. Vola cercava sempre quello che era giusto e ci ragionava sopra alle cose. Poi, Vola era buono. Buono e tranquillo. Lui non fumava e teneva il tabacco per noi, quando non ne avevamo. Quando sparava, sapeva sempre quanti colpi erano usciti. E sempre allegro, allegra a gli altri
Quando l’hanno ferito ha voluto ragionarci sopra e disse: ” O’ catà la mea”. Poi è morto.
Vola è di quelli che lasciano il vuoto grande quando muoiono.
ALDO BRUSA-PRIMO CARMINE
I due borghesi non c’entravano. Non erano armati, non avevano sparato, non avevano parteggiato per nessuno. Forse il cuore aveva parteggiato per i nostri. Ma non c’entravano: solo il caso li aveva portati su quella data superficie di terreno entro la quale chi non era in divisa fascista è morto. Anche loro avevano i buchi sporchi di stoffa bruciata, la carne spappolata. Il perché, chiaro, particolare, per loro non c’è. C’è quello generale, sovrano indifferente: la guerra non spigola, miete.
Ma anche loro sono una via.
…
GISELDA CARMINE
Sono Giselda, la sorella di Primo Carmine, uno dei civili uccisi a Promè: Primo era in Francia e lavorava a Montecarlo; quando è scoppiata la guerra è ritornato in Italia perché i francesi erano nostri nemici, e non gli permettevano di lavorare lì. È stato di stanza a Valona e poi in Grecia dove fu fatto prigioniero.
Dopo 5 o 6 mesi venne liberato dai tedeschi e, una volta tornato in Italia, per evitare di dover tornare a combattere si fece levare tutti i denti, in modo da non superare la visita medica per l’arruolamento e avere il congedo illimitato. Nonostante questo nel ’43 venne richiamato a combattere, ma si nascose in paese per poi fuggire su per i monti.
La domenica del 25 febbraio ’45 uno squadrone della Confinaria di Cannobio arrivò a Trarego. Mio fratello appena sentì la notizia dell’arrivo della Confinaria e della Brigata nera, avrebbe voluto tornare a casa, ma incitato da un amico, Aldo Brusa, che poi venne ucciso insieme a lui, decise di recarsi a casa di quest’ultimo a Promè, dove mangiarono insieme e poi si nascosero in una grotta. Qualcuno fece la spia e verso mezzogiorno i partigiani vennero inseguiti: sette caddero vicino a una stalla e due riuscirono a scappare. I soldati passarono anche davanti alla grotta e, non avendo accolto la loro supplica di lasciarli andare perché senza alcun arma, li uccisero con trentadue colpi di mitra ciascuno. Vennero poi scoperti i sette corpi e più in basso trovarono anche quello di mio fratello e del suo amico.
Dopo la strage per alcuni anni non riuscii più a ripercorrere la strada che porta a Promè, perché avevo troppa paura. Sulla pietra del sentiero c’erano ancora le macchie di sangue e ovunque io mi voltassi continuavo a vedere i volti dei partigiani e di mio fratello. Mia mamma ci andava perché c’era il mangime per gli animali, ma piangeva sempre quando tornava.
La guerra ci aveva portato via tutto, è stata la fine di tutto e da una cosa così non ci si può più riprendere.
Suor ALESSANDRINA DUSE
Testimonianza di suor ALESSANDRINA, dell’asilo di Trarego:
Dopo il mostruoso eccidio, i sette copri straziati dai colpi della mitraglia, coperti di sangue e di terra, rimasero lì, soli tra le foglie secche, ancora per due giorni e due notti. Quando finalmente i loro assassini si allontanarono, mi avvicinai a quel luogo di tragedia, muovendomi tra le ombre della notte ormai vicina. Tremava il mio cuore a causa di tutti questi colpi e urla, avevo paura di scoprire la tragedia. Arrivai sul posto di fronte ai corpi massacrati di quei ragazzi, il mio cuore si sentì straziato e non riuscivo a trattenere le lacrime. Poi come avrebbero fatto tutte le mamme, spose e sorelle, cominciai a tamponarli e pulirli in modo da nascondere le ferite più gravi. Composi quei poveri corpi e pregai per le loro anime maledicendo gli assassini. Dopo due giorni permisero la sepoltura e furono portati in cimitero da alcuni paesani. Lavai con misericordia i corpi dei Martiri e mi sostituì alle madri, alle spose e alle sorelle di questi giovani in questa dolorosa circostanza, sfidando i sospetti e le ire fasciste. Vorrei essere ricordata solo per il mio gesto come patriota.
ANNA BEDONE
Sono Anna Bedone Ferrari, maestra della scuola elementare di Trarego negli anni della guerra e aiuto segretario comunale. Negli anni successivi al ’43 mi trovai ad aiutare alcune famiglie ebree, falsificandone i documenti o, come nel caso della famiglia Coen Torre, trovando loro una casa a Trarego.
Il 25 febbraio, il giorno della strage, era un giorno come tanti: ero al lavoro, quando sentii degli spari, a quel punto mi recai a casa della famiglia Torre per riprendere mia figlia che, dopo la scuola, come ogni giorno, veniva ospitata da loro. Nel momento in cui arrivammo a casa, finalmente pensai: “Tra le case di Cheglio mi sento più tranquilla “.
Il giorno dopo arrivò l’ordine di andare a recuperare i cadaveri dei partigiani caduti per seppellirli in una fossa comune nel cimitero di Trarego. Allora il segretario comunale Ciccardini di Oggebbio disse che si potevano fare delle fotografie per il riconoscimento dei corpi da parte dei parenti. Siccome io ero una delle poche ad avere la macchina fotografica, mi chiese nell’ora di pranzo se ero disponibile a scattare delle foto. Io accettai ma, tornata a casa, trovai mio marito contrario poiché aveva paura e pensava che ci bruciassero la casa. Questo suo timore non cambiò la mia scelta.
I corpi erano stati posti su delle scale a pioli per poter essere fotografati, dopo essere stati ricomposti dalle suore che li avevano lavati.
Mentre scattavo le foto il messo comunale faceva da guardia fuori dal cimitero. Di lì, quel giorno, passò una persona, che sospetto sia stata l’informatrice dei fascisti.
Il giorno dopo, infatti, ricevetti una telefonata dal comando che mi intimò di consegnare il rullino, minacciandomi, in caso contrario, di venirmi a prendere. Contattai subito il segretario comunale che si occupò di riconsegnare il rullino.
La notizia della morte dei nostri partigiani si diffuse rapidamente e arrivarono qui amici e parenti a portarli via.
Il rullino venne ritrovato nella tasca del comandante Nisi, il 25 aprile, quando i fascisti scapparono, finita la guerra. Grazie al parroco del paese il rullino tornò nelle mie mani e decisi di farle sviluppare a Intra dal fotografo Moscardelli, il quale al momento del ritiro delle foto mi chiese di lasciargli i negativi che sarebbero stati utili per eventuali celebrazioni.
…
La vicenda di Giuseppe Clair Gagliani
Il giorno in cui avevo scattato le foto il signor Gagliani era presente ed ebbe parole di solidarietà nei confronti dei partigiani uccisi; sembra che abbia esclamato: “Vi vendicheremo!”. Purtroppo qualcuno riferì ai militari fascisti di Cannero la sua frase e così il giorno dopo essi sequestrarono sua figlia sedicenne e telefonarono in municipio con l’ordine di avvisare Gagliani di presentarsi, altrimenti non avrebbero rilasciato sua figlia Maria. Io quel giorno speravo proprio di non incontrarlo, ma, invece, quando sono arrivata alla stazione di Cheglio l’ho incrociato e ho dovuto riferirgli tutto. Fu arrestato e, mentre lo portavano al comando di Cannobio, gli spararono nella schiena. Poi liberarono la figlia.
MARIA GAGLIANI
Sono Maria, figlia di Giuseppe Clair Gagliani. Avevo sedici anni, nel marzo del 1945. Mio padre partecipava alla lotta di liberazione e non si trattenne davanti allo scempio dei partigiani uccisi a Promè. Una spia denunciò ai fascisti il nome di mio padre e così il 1 marzo vennero a casa nostra a cercarlo e, non trovandolo, mi presero come ostaggio. Venni portata a Cannero al comando fascista, dove restai fino all’indomani; ricordo che fui liberata dopo una raffica di colpi di mitraglia. Chiesi subito di mio padre, ma mi dissero che era fuggito. Così chiesi alla gente se sapeva qualcosa, ma dissero che era scappato anche se sapevano già la verità. Io non contenta continuai a chiedere a tutti fino a quando qualcuno mi disse di andare a Cannero perché lì c’era mio padre… Morto. Io pensavo fosse in strada ma non lo vedevo da nessuna parte poi però mi dissero che ero sul gradino dove c’era il suo sangue.
Mia sorella allora era piccola e per non farla assistere alla scena le vennero date 5 lire per andare a comprare le caramelle.
Mia mamma non volle i soldi dal soldato che aveva ucciso mio padre e, quando partecipò al processo, che si tenne a Novara, gettò in faccia all’assassino quelle monete che le erano state date il giorno della sua cattura.
…
Il giorno della liberazione ero su per i monti e sentii le campane suonare, così tornai a casa e vidi mia mamma che piangeva.
Dall’Antigone di Sofocle
Antigone: ” [..] ma se prima del tempo io morirò, questo io lo considero un guadagno: per chi vive, com’io vivo, fra tante pene, un guadagno non sarà la morte?
Per me dunque, affrontar tale destino, è un dolore da nulla. Ma se l’uomo nato da mia madre avessi abbandonato, salma insepolta, allora sì, mi sarei disperata: del resto non mi dispero.
Tu dirai che da folle io mi comporto;
Ma forse di follia m’accusa un folle [..] “