Accademia delle Arti di Berlino, Adolf Hitler, antisemitismo, arte, assurdo, Auschwitz, Bandi Citrom, Berlino, Boris Pahor, Buchenwald, Budapest, Casa Museo Kertész Imre, Chiarezza, destino, diari, Diario della galera, dio, ebreo, Ennio Morricone, Essere senza destino, Europa, Ferenc Szálasi, Fiasco, Fidesz, figlio, Friedrich Nietzsche, Germania, Giuseppe Tornatore, governo magiaro, Gyurka, Hannah Arendt, Il secolo infelice, Il vessillo britannico, Imre Kertész, Intelletuale ad Auschwitz, Io un altro, István Szabó, Jean Améry, Kaddish per il bambino non nato, L'ultimo rifugio, La banalità del male, La nascita della tragedia, La tigre sotto la pelle, Lajos Koltai, letteratura, libertà, Liquidazione, Lo spettatore, matrimonio, Mein Kampf, Metamorfosi, moglie, nazismo, nazismo ungherese, Necropoli, olocausto, Premio Nobel, Primo Levi, Se questo è un uomo, Senza destino, sguardo infantile, shoah, spirito dionisiaco, stalinismo, Storia poliziesca, tempo, totalitarismo, Trattato di Trianon, Trilogia, Ungheria, Unione Sovietica, Verbale di polizia, Viktor Orbán, Zeitz
Dall’Ungheria nazista all’Universo concentrazionario

“Essere senza destino” del Premio Nobel Imre Kertész
“Forse per la sua stessa enormità, la Shoah non ha prodotto molti libri indispensabili. Libri di cui non si possa proprio fare a meno, per verbalizzare l’indicibile, per concettualizzare l’impensabile, per tramandare l’imperdonabile. I titoli di questi libri d’eccezione, credevamo di conoscerli già tutti. Se questo è un uomo di Primo Levi, La banalità del male di Hannah Arendt, Essere senza destino di Imre Kertész, Intellettuale a Auschwitz di Jean Améry. Ma adesso, alla lista delle letture indispensabili va aggiunto il titolo di un volume stampato per la prima volta in inglese, nella New York del 1947 (l’anno stesso della prima edizione di Se questo è un uomo), e da allora mai più pubblicato in alcuna lingua. La tigre sotto la pelle, di Zvi Kolitz, è un libro assolutamente straordinario.”
La lettura di questo passo di Sergio Luzzatto[1] mi ha subito posto tre ovvi quesiti: chi è Imre Kertész (di cui non avevo mai sentito parlare né letto il libro citato), perché non viene citato Necropoli di Boris Pahor che ritengo assolutamente da collocare fra gli indispensabili sulla Shoah e. infine, chi è l’autore del citato La tigre sotto la pelle. Al terzo rimando a quando avrò recuperato e letto il libro di Zvi Kolitz. Al secondo penso di aver risposto in un mio precedente articolo su questo blog (Shoah, percorsi di lettura asimmetrici) in cui oltre a Levi ed Améry mi soffermo su Necropoli di Pahor. E veniamo all’autore del primo quesito.
Imre Kertész: una vita e il suo assurdo
Imre nasce a Budapest il 9 novembre 1929 da Aranka Jakab e László Kertész, coppia di ebrei ungheresi di classe media non praticanti. Nato nell’anno della grande crisi in cui molti preferiscono invece togliersi la vita.
“Quando sono venuto al mondo il Sole era nel segno della più grande crisi economica fino ad allora mai conosciuta, la gente si buttava di sotto dall’Empire State Building, dal turul (l’aquila immaginaria della tradizione ungherese) in cima al ponte Francesco Giuseppe, e da tutti i punti situati in alto dell’intero globo; si gettava nell’acqua, nei precipizi, sul lastricato, a seconda delle possibilità”[2].
Ebreo ungherese di Budapest; quando Imre nasce la popolazione ebraica dell’Ungheria si era quasi dimezzata dopo il Trattato di Trianon per lo scorporo di territori rurali con presenza significativa di comunità ebraiche, concentrandosi prevalentemente nella capitale ove costituisce circa un quarto degli abitanti della città, ma già dal 1920 era stato dato avvio a norme antiebraiche con la legge del numerus clausus che limitava l’accesso alle Università e alle professioni. Il successivo progressivo avvicinarsi alla Germania con norme sempre più restrittive sfocerà nel 1944 con il governo del capo dei nazionalsocialisti ungheresi Ferenc Szálasi.
“Un capo partito di nome Adolf Hitler mi guardava torvo dalle pagine del suo Mein Kampf, la prima legge antisemita ungherese chiamata numerus clausus si trovava sullo zenit della mia costellazione prima che il suo posto fosse preso dalle leggi successive. Tutti i segnali terrestri (non so nulla di quelli celestiali) testimoniavano l’inutilità, o meglio l’irragionevolezza, della mia nascita.”
Per non parlare della situazione famigliare in disfacimento e di una “buona educazione” che lo disciplinava alla obbedienza e alla remissività.
“Ero un inconveniente anche per i miei genitori che stavano divorziando. Sono la manifestazione materiale di qualche incontro amoroso di due persone che non si amavano […]. Figlioletto di mio padre e di mia madre che non avevano più nulla in comune, alunno di un istituto privato dove mi avevano internato mentre loro sbrigavano le pratiche del divorzio; scolaro e piccolo cittadino dello Stato. […] Ero circondato, sovrintendevano alla mia mente: mi educavano. Mi allevavano per eliminarmi, a volte con parole affettuose, altre con rimproveri severi. Non protestavo mai, mi impegnavo a fare il mio meglio: mi lasciavo andare alla nevrosi della buona educazione con languida buona volontà. Ero un membro umilmente impegnato, seppure non sempre perfettamente allineato, della tacita congiura che attentava alla mia vita”.
Remissività introiettata che porterà, lui ragazzino, a subire le progressive discriminazioni, prima con l’inserimento in corsi per soli ebrei, la stella gialla sui vestiti fin quando, scortato dalle forze di polizia ungheresi, viene portato con migliaia di concittadini alla stazione di Budapest, destinazione Auschwitz, senza tentare in alcun modo la fuga, anche se le occasioni non erano mancate. Tra i quattordici e quindici anni attraversa così l’esperienza concentrazionaria (Auschwitz e Buchenwald) che segnerà tutta la sua vita e i suoi scritti.
Dopo la liberazione del Campo di Buchenwald da parte dell’esercito statunitense (11 aprile 1945), rientrato a Budapest non ancora sedicenne riprende gli studi, si diploma al liceo nel 1948 e intraprende l’attività di giornalista e di traduttore dal tedesco all’ungherese. Nel 1951 perde il lavoro di giornalista presso il periodico “Chiarezza” in quanto la rivista si era allineata alle posizioni staliniste del partito, da cui Imre era decisamente lontano. Tra le traduzioni su cui si era cimentato vi era La nascita della Tragedia di Friedrich Nietzsche; contrariamente a molte letture e alla stessa posizione del filosofo tedesco, Imre non vede nello spirito dionisiaco la riscoperta di una naturalità originaria ma la nullificazione della individualità che nell’età moderna si esprime come spirito gregario tipico dei partiti-regime come quelli nazista e comunista-stalinista. La via di uscita può essere solo la scelta di vivere in posizione marginale non rinunciando alla propria razionalità.
Dopo un periodo di lavoro operaio e il servizio militare riprende l’attività di giornalista indipendente e di traduttore iniziando anche l’attività di scrittore grazie ad un amico musicista che gli aveva proposto di comporre libretti per operette musicali. All’inizio degli anni ’60 inizia a lavorare sulla sua opera più nota (Essere senza destino / Sorstalanság) che avrà un parto lunghissimo – circa tredici anni – sia per l’insoddisfazione dei primi risultati che per periodi ricorrenti di depressione e del fantasma del suicidio che, afferma più volte Kertész, accompagna costantemente i sopravvissuti, in particolare gli scrittori, costretti a rivivere il loro passato, ricordando Jean Améry che elaborava le sue opere con al fianco dei fogli una pistola.
Completato nel 1973 ma inizialmente rifiutato dagli editori ungheresi, Essere senza destino uscirà due anni dopo (1975) senza però riscuotere particolare interesse.
Dopo il crollo del muro si trasferisce a Berlino e, con la pubblicazione in tedesco della sua opera a cui si sono aggiunti gli altri due testi della cosiddetta trilogia dell’Olocausto (Fiasco del 1988 e Kaddish per il bambino non nato del 1990) inizia la sua notorietà che lo porterà a riconoscimenti internazionali come il Premio Herder nel 2000 e il Premio Nobel per la Letteratura nel 2002 con la motivazione “per una scrittura che sostiene l’esperienza fragile dell’individuo contro l’arbitrarietà barbarica della storia”.
In Ungheria, visto che tra l’altro Kertész è stato il primo premio Nobel per la Letteratura ungherese (e ancor oggi l’unico) è nata qualche polemica perché Imre viveva e lavorava in Germania e in una intervista a Die Welt del 2009 si è definito “berlinese”. La sua posizione nei confronti della nazione natale è sempre stata ambivalente. Da un lato molto critica, anche per il periodo postcomunista come esplicita in uno scritto del 1997 in cui sottolinea non solo la permanenza dell’antisemitismo ma una sorta di suo “bisogno” per poter scaricare le proprie colpe nazionali.
“Se davvero [le autorità ungheresi] non vogliono vedere le vite distrutte di tante persone, una Storia completamente erronea per una serie di guasti dei quali sono colpevoli, dei momenti storici avviati alla rovina per le loro colpe, e si ostinano a considerare quegli eventi come disgrazie causate da malvagie forze straniere, oppure da una sorta di maledizione nazionale, dal destino, anzi dal fato… se è davvero così, allora si può affermare che hanno bisogno dell’antisemitismo.
L’anima di una piccola nazione dell’Europa centro-orientale, gravata dal complesso del padre e scivolata in una perversione sadomasochistica, sembra non poter vivere senza il grande oppressore, sul quale scaricare la propria disgrazia storica, e senza il capro espiatorio delle minoranze, su cui sfogare il sovrappiù di odio e di risentimento accumulato durante la sequela dei fallimenti quotidiani. Senza antisemitismo, quale identità potrebbe avere chi è ininterrottamente occupato con la propria specifica identità magiara? Ma che cos’è mai la specificità magiara? Affrontando la questione in modo diretto, si può affermare che quella specificità si rintraccia principalmente nelle affermazioni negative, tra le quali quella più semplice – quando non menano il can per l’aia – recita: “Ungherese è ciò che non è ebreo.” Eh già, ma che cos’è ebreo? Ebbene, è evidente: quello che non è magiaro. L’ebreo è colui del quale si può parlare al plurale perché è identico a tutti gli altri ebrei, le cui caratteristiche si possono riunire in tabelle, proprio come accade per una razza animale non troppo complicata (naturalmente sto pensando a bestie nocive, il cui pelo setoso è un puro inganno ecc.), e siccome la parola “ebreo” in ungherese è diventata un’espressione spregiativa, il tribuno politico magiaro dell’ultima ora, incanutito nell’onesta prassi di collaboratore, per evitare ogni complicazione dirà “straniero”, ma tutti sapranno a chi si riferisce e, all’occasione, sarà privato dei diritti, bollato, derubato e picchiato a morte. E io… Io che cosa posso fare qui?”[3]
Dall’altro lato ha sempre continuato a considerarsi ungherese, prima ancora che ebreo, a difendere anche con una polemica virulenta, i diritti culturali e linguistici della consistente minoranza magiara in Romania. Negli ultimi anni tornerà a vivere a Budapest e il suo lascito sarà diviso fra l’Accademia delle Arti di Berlino e la Casa Museo Kertész Imre di Budapest.
Un’eredità contesa a partire dal premio Nobel del 2002: l’anno successivo il governo magiaro gli assegnò la Gran Croce dell’Ordine al Merito della Repubblica ungherese e quello federale tedesco nel 2004 lo omaggiò con analoga onorificenza germanica. E attualmente il governo di Viktor Orbán, nella volontà di riscrivere la storia del proprio paese, tenta di accreditarlo nella sua visione nazionalistica
“nel tentativo di trasformarlo in un eroe nazionale in chiave anticomunista. Finiscono in soffitta, o meglio sotto il tappeto, i feroci attacchi di cui lo scrittore ebreo fu vittima da parte dei partiti di destra, compreso il Fidesz di Orbán, al momento della vittoria del Nobel nel 2002, soprattutto per le parole sull’Olocausto, gli orrori del nazismo e le complicità ungheresi.”[4]
Essere senza destino
“Oggi non sono andato a scuola. O meglio, ci sono andato, ma solo per farmi esonerare dal nostro professore. Gli ho portato la lettera di mio padre, in cui richiede il mio esonero per “motivi familiari”. Il professore ha chiesto quali fossero questi motivi familiari. Io gli ho risposto che mio padre è stato chiamato al periodo di lavoro obbligatorio; a quel punto lui non ha più fatto obiezioni.”
Inizia così il racconto del quattordicenne Gyurka (Köves György); siamo a Budapest nella primavera del 1944 e con la stella gialla che porta come tutti i familiari raggiunge il padre che, destinato non si sa dove né per quanto, viene sommerso da una mesta cerimonia di saluto dalla famiglia allargata. Non molto dopo anche il giovane è assegnato al lavoro come “apprendista manovale” in una raffineria petrolifera alla periferia della città. Un giorno mentre si reca al lavoro, il pullman viene fermato da un poliziotto e tutti gli ebrei, giovani e meno giovani, costretti a scendere. Concentrati in un capannone dove Gyurka si riunisce con i suoi coetanei di lavoro coatto, verranno poi scortati dalla polizia ungherese fino alla stazione. Un treno blindato lo porterà ad Auschwitz dove, grazie al suggerimento di alcuni deportati di dichiarare di avere sedici anni, riuscirà a superare la selezione iniziale (ma non tutti i suoi compagni). Verrà poi trasferito a Buchenwald e di lì al campo di lavoro di Zeitz (a sud di Lipsia). Un suo concittadino “veterano” del campo, Bandi Citrom, gli fa spontaneamente da tutore e lo istruisce alla dura arte della sopravvivenza: lavarsi, tenere sempre una scorta della razione di cibo, “non lasciarsi mai andare” mantenendo la propria dignità ed anche il proprio orgoglio magiaro affrontando con decisione la fatica del lavoro. Gyurka per un po’ riuscirà a seguire i dettami del più anziano concittadino, ma coll’aumentare della fatica, della spossatezza fisica e per una infezione al ginocchio incomincerà a lasciarsi andare sin quasi arrivare al punto di non ritorno. Operato in qualche modo passa in più reparti di infermeria tra freddo cimici e pidocchi, sarà riportato Buchenwald sino a che si ritrova in un reparto di infermeria tenuto da vecchi deportati col triangolo rosso che lo curano, lo nutrono e lo riportano in guarigione. Siamo ormai nell’aprile del 1945, il campo viene liberato dagli alleati. A piedi e con mezzi di fortuna si unisce ad un gruppo di giovani ungheresi per ritornare a casa. A Budapest non ha voglia di seguire la trafila burocratica dei soccorsi e decide di riprendere in mano il proprio destino. Per prima cosa cerca la casa di Bandi Citrom ma trova la giovane moglie oramai rassegnata al non ritorno del marito. A casa sua scopre che l’appartamento è occupato da una famiglia ungherese che gli chiude la porta in faccia. I vecchi vicini ebrei gli comunicano di aver ricevuto la notizia della morte di suo padre a Mauthausen. Trova assurdo che gli chiedano di “dimenticare gli orrori” consapevole che la “reminiscenza” di quei giorni e di quelle persone (Bandi Citrom, gli infermieri, e tutti gli altri) non lo lasceranno più.
“… non esiste assurdità che non possa esser vissuta con naturalezza e sul mio cammino, lo so fin d’ora, la felicità mi aspetta come una trappola inevitabile.”
Le giravolte del destino
Imre dichiarerà più volte che questo è un romanzo e non è autobiografico. È però evidente che la sua esperienza concentrazionaria ne è la fonte principale.
Il racconto scorre in modo lineare ed è di facile lettura … ma è decisamente spiazzante, non facile da inquadrare e si può capire perché non fosse ben accolto dall’Ungheria comunista del dopoguerra, trovando notorietà solo dopo il successo in Germania e il Premio Nobel.
Innanzitutto non è un libro di denuncia né delle atrocità naziste né del collaborazionismo magiaro; certo ci sono entrambe (per verti versi più il secondo che le prime) ma descritte (spesso solo accennate) in modo asettico, come qualcosa di ovvio e “naturale”.
La narrazione in prima persona del giovane Gyurka ne ricostruisce lo sguardo infantile, non seleziona e non dà priorità a questo o quel dettaglio od evento, di fronte ad accadimenti inattesi emerge lo stupore del ragazzino e nello stesso tempo una sorta di realismo fatalistico: se avviene così è perché così deve essere. A partire dal contrassegno giallo che naturalmente porta come tutti i suoi parenti e i conoscenti ebrei. Mentre la sorella maggiore della sua amica Annamaria, con cui aveva rubato qualche fuggevole bacio, mal sopportava la stella gialla per gli sguardi di odio che intercetta nella gente e si interroga su che cosa significhi essere ebrea, Gyurka commenta “a me sembra che il suo modo di vedere sia un po’ esagerato”.
La guardia magiara di confine che avvisa gli ebrei del treno blindato che sono giunti alla frontiera, li interpella dal finestrino “con buone intenzioni” chiedendo di lasciare in mani ungheresi denaro e oggetti preziosi, piuttosto di farseli poi requisire dai tedeschi. («In fin dei conti anche voi, a ben vedere, siete ungheresi!»). In cambio avrebbe dato loro dell’acqua anche se “violava le disposizioni”. Siccome chi trattava chiedeva di ricevere prima l’acqua il gendarme
“… alla fine era piuttosto arrabbiato: «Porci ebrei, sapreste fare affari anche con le cose più sacre». Era così che la vedeva lui. E con voce soffocata dall’indignazione e dall’astio ci espresse l’augurio: «Allora crepate di sete!». Cosa che poi accadde davvero, almeno così si diceva nel nostro vagone.“
E alcuni interrogativi che il giovane si pone giunto in un posto sconosciuto dal nome di Auschwitz-Birkenau ci sconcertano. Come mai ci sono dei detenuti con le divise a righe, certo ebrei visto la stella gialla, in quel posto ove era venuto per lavorare, “provando interesse nei loro confronti e mi sarebbe piaciuto conoscere i loro reati”. Diversamente dagli altri testi “indispensabili” sulla Shoah citati all’inizio, qui vi è un rovesciamento di prospettiva fra lettore che apprende e narratore che sa e “verbalizza l’orrore dell’indicibile”. Gyurka non sa, non capisce dove si trova, acquisterà consapevolezza lentamente, passo a passo; noi lettori invece sappiamo e ci stupiamo del suo stupore.
Solo alla fine, ritornato a Budapest, cercando di spiegare ad altri che non capiscono (un giornalista, i vecchi vicini di casa), ripercorrendo la sua esperienza ne trova in qualche modo il senso: il tempo, l’essere ebreo, il destino.
Il tempo, il suo succedersi a tappe ci permette di sopravvivere, persino talvolta di annoiarci, “…in generale … io non mi sono accorto degli orrori”.
“Sì, e come te lo spieghi?”. E allora, dopo averci riflettuto, ho detto: “Con il tempo”. “Cosa significa, con il tempo?” “Significa che il tempo aiuta.” “Aiuta…? In cosa?” “In tutto,” e ho cercato di spiegargli come è, arrivare in una stazione non proprio lussuosa ma nel complesso accettabile, pulita e graziosa, dove solo lentamente, col succedersi del tempo, tappa dopo tappa ti si chiarisce tutto quanto. Quando hai superato la prima tappa, quando sai di averla passata, già ti si presenta la prossima. Quando poi sei arrivato a conoscere tutto, allora hai anche compreso tutto. E mentre comprendi tutto, non rimani certo inattivo: già sistemi le cose nuove, vivi, agisci, ti muovi, adempì le continue richieste di ogni tappa successiva. Se però non ci fosse questa successione nel tempo e tutte queste conoscenze si riversassero su di noi in una volta sola, forse la nostra testa non riuscirebbe a sopportarle e nemmeno il nostro cuore – così cercavo di spiegargli. […] D’altra parte, ho proseguito, c’era il difetto, si potrebbe dire lo svantaggio, che il tempo, in qualche modo, bisognava trascorrerlo. Per esempio avevo visto dei prigionieri – gli ho detto – che erano nel campo di concentramento già da quattro, sei o dodici anni, anzi, più esattamente: c’erano ancora. Ora, queste persone, per quattro, sei o dodici anni, ovvero in quest’ultimo caso dodici per trecentosessantacinque giorni, ovvero dodici per trecentosessantacinque per ventiquattro ore, e ancora avanti, dodici per trecentosessantacinque per ventiquattro per… e all’indietro, in secondi, minuti, ore, giorni: ebbene, avevano dovuto in qualche modo superare questo dalla A alla Z. D’altra parte ancora, ho aggiunto, proprio questo poteva essere stato d’aiuto, perché se tutto questo tempo, dodici per trecentosessantacinque per ventiquattro per sessanta per sessanta, si fosse improvvisamente riversato su di loro in un colpo solo, non avrebbero resistito – al modo come invece hanno resistito – non lo avrebbero retto né fisicamente né psichicamente.”
Essere ebreo per un ragazzo di famiglia non osservante, laica che senso ha? Drasticamente, dice Gyurka, In sé niente, sono le circostanze che ti fan diventare tale.
“Ciascuno ha fatto i suoi passi finché ha potuto: anch’io, e questo non solo marciando in colonna a Birkenau, bensì già prima, qui a casa. Li ho fatti con mio padre, con mia madre, con Annamaria e anche – forse quelli più difficili – con la sorella maggiore. Adesso glielo saprei spiegare cosa significa essere “ebreo”: niente, niente per me e niente in sé, in origine, e questo finché non si innescano quei passi. Niente di tutto quello è vero, non esiste del sangue diverso, non esiste niente, ma solo… e qui mi sono bloccato, ma all’improvviso mi è venuta in mente la frase del giornalista: esistono solo date circostanze e all’interno di esse nuovi dati di fatto.”
Il destino forse non esiste, scopre alla fine Gyurka, discutendo animatamente con i vecchi vicini che lo avevano invitato a dimenticare; siamo liberi – e responsabili – di ogni passo che facciamo.
“Anch’io ho vissuto un destino dato. Non era il mio destino, eppure l’ho vissuto – e non capivo come potessero non concepire che io, adesso, volevo farne qualcosa di questo destino, che dovevo ancorarlo, agganciarlo a qualcosa, che non potevano dirmi semplicemente che era stato un errore, un incidente, una specie di sbandata o magari che non era affatto accaduto. Mi rendevo già conto, e anche chiaramente, che non riuscivano a capirmi, che le mie parole a loro non andavano a genio, anzi, che c’era qualcosa che urtava loro persino i nervi. Mi accorgevo che di tanto in tanto il signor Steiner voleva interrompermi, voleva quasi balzare su, vedevo che l’altro vecchio lo tratteneva e ho sentito che gli ha detto: “Lo lasci stare, non vede che vuole semplicemente parlare? Lo lasci parlare”, e infatti io ho parlato, probabilmente a vuoto e forse anche in modo un po’ sconnesso. Comunque anche così ho spiegato loro che non si può cominciare una vita nuova ma soltanto proseguire quella vecchia. Io e nessun altro ho fatto i miei passi e, aggiungo, con rettitudine. […] Volevano forse che tutta la mia rettitudine e tutti i miei passi pregressi perdessero il loro significato? Perché questo repentino cambiamento dell’animo, perché questa riluttanza, questo rifiuto di voler comprendere: se esiste un destino, allora la libertà non è possibile; se però – ho continuato, sempre più sorpreso di me stesso, sempre più eccitato – la libertà esiste, allora non esiste un destino, il che significa – mi sono fermato ma solo per prendere fiato – il che significa che noi stessi siamo il destino – questo ho improvvisamente capito, e l’ho capito in quel preciso istante con una pregnanza fino a quel momento sconosciuta.”
Il Film
Nel 2005, con la regia di Lajos Koltai, esce Senza destino. Fateless che, a prima vista, ripercorre fedelmente le vicende del testo originario. È lo stesso Imre Kertész a curarne la sceneggiatura e che però afferma:
“La sceneggiatura è come un assegno in bianco di cui il registra fa quello che vuole … Dopo il film si differenzia in modo incredibile dal testo in quanto è un altro genere. L’eroe di “senza destino” è obbligato a rivivere quel periodo, un periodo terribile, secondo per secondo. Minuto per minuto, ora per ora, giorno per giorno, mese per mese. Quel tempo è l’orrore, questo è uno degli aspetti determinanti e fondamentali che Lajos ha subito afferrato e capito.”[5]
Koltai non è propriamente un registra ma ha acquisito notorietà quale direttore della fotografia con registi quali l’ungherese István Szabó e l’italiano Giuseppe Tornatore e la sua scelta è innanzitutto visiva, virata verso un marrone atta a rappresentare una cupezza che richiama
“… un certo mondo visivo, paragonabile solo alla pittura e agli esempi che mi piacciono di quel genere. Quindi è tutto totalmente medievale; sembra quasi un dipinto medievale.“
La musica che accompagna immagini e vicenda del giovane deportato sono di Ennio Morricone che sceglie di assecondare il film senza alcuna forzatura né insistenza:
“Una dignità il film l’aveva già. La sua musica ha la dignità che ha il film … L’etica conta sempre. Penso sempre all’etica musicale, ovvero alla fattura della scrittura di una partitura. Lì dentro ci deve essere già la dignità del compositore. Qualche volta la partitura oltrepassa la misura: evitare questo è la mia preoccupazione.”
Un film strettamente aderente al testo e alla sceneggiatura che ne deriva, eppure necessariamente “radicalmente diverso” nel messaggio e nella finalità. Non c’è più il rovesciamento spiazzante fra lettore (spettatore) che sa e protagonista che non sa. Non vi è più un narratore interno che ci immerge nel racconto e negli stessi pensieri del protagonista, il nostro sguardo è invece necessariamente esterno, quello della cinepresa che accompagna il bambino deportato ma non si identifica col suo sguardo interiore. Diversamente dal romanzo questo è invece esplicitamente un film di denuncia di un passato perlopiù ignorato in Ungheria, differentemente da quanto avviene in Germania dove l’Olocausto è insegnato nelle scuole, voluto da uno scrittore-sceneggiatore che ha scelto un regista ungherese per destinarlo ai connazionali magiari. Dice il regista:
“… facciamo un film sull’Olocausto perché non è stato trattato a sufficienza. È il passato ma ancora oggi persino il mio vicino pensa non sia accaduto ma una sorta di storia della Disney. Incredibile! E parlo di persone che hanno studiato. Bisogna dare visioni; un film parla un linguaggio visivo e questo è il vero linguaggio per parlare alla gente.”
Le altre due opere della TRILOGIA
Fiasco (1988)[6]
Il fallimento del titolo è quello di “un vecchio” che davanti a un secretaire pensa e ricorda, e che forse non è tanto vecchio d’età e capiamo dal nome (Köves) trattarsi del protagonista di Essere senza destino. Ora è uno scrittore nella Germania comunista al cui conformismo asfissiante non riesce ad adattarsi. E i suoi manoscritti gli vengono più volte rispediti dagli editori con giudizi poco lusinghieri. Se l’opera precedente era narrativamente lineare, questa presenta una struttura complessa, una “opera aperta” con tanto di romanzo nel romanzo e continui riferimenti all’opera precedente.
“I lettori della nostra casa editrice hanno letto il Suo manoscritto, e in base al loro parere concorde, non approviamo la pubblicazione del Suo romanzo.
«Riteniamo che la composizione artistica della materia derivante dalla Sua esperienza non sia riuscita, nonostante il tema sia terribile e impressionante. Che il romanzo non diventi, per il lettore, un’esperienza impressionante, è dovuto in primo luogo alle reazioni del protagonista che sono a dir poco strane. Riteniamo comunque comprensibile che il protagonista, adolescente, non riesca a comprendere subito cosa stia succedendo intorno a lui (le chiamate all’Arbeitsdienst, l’obbligo di portare la stella gialla, età), ma non riusciamo a spiegarci perché, arrivando al campo di concentramento, ritenga “sospetta” la rasatura a zero dei prigionieri. Le frasi di cattivo gusto continuano: “neanche i loro volti sembravano ispirare fiducia: orecchie a sventola, nasi sporgenti, occhi incavati, dalle luci minuscole e furbesche. Da ogni punto di vista sembravano comunque degli ebrei”.
«Poco credibile anche che la visione dei forni crematori susciti in lui “la sensazione di una sorta di scherzo goliardico”, “di certe beffe”, poiché sa di essere in un campo di sterminio, e che il suo essere ebreo è sufficiente perché lo uccidano. Il suo comportamento, le sue annotazioni assurde, disgustano e offendono il lettore, che con rabbia legge anche la fine del romanzo, visto che il comportamento fino ad allora tenuto dal protagonista non offre appiglio a un giudizio morale, l’individuazione delle responsabilità (per esempio, i rimproveri fatti alla famiglia ebraica che abita nella loro casa). E dobbiamo accennare anche allo stile. Le Sue frasi sono espresse per lo più maldestramente, con grande fatica, e purtroppo sono frequenti le espressioni del tipo “.. .per lo più insomma davvero…”; “molto naturalmente, e un attimino oltre a ciò…”.
«Per questo Le restituiamo il manoscritto.
«Distinti saluti.
«…Questa lettera mi regalò, per lo meno, un mattino ricco di sentimenti: ancora oggi sento una certa nostalgia, a riandarci con il pensiero.
Ma nonostante tutto vi è una sorta di “lieto fine”, l’esser stato fedele a se stesso alla fin fine ha pagato e il destino che si è scelto lo condurrà sino alla fine. Con la nostalgia della “fase eroica”, della lotta solitaria per imporsi. E così il “vecchio” ci lascia.
“La sua avventura unica, la sua epoca eroica, ora e per sempre sono giunte alla fine. Ha trasformato in un oggetto la propria persona il suo testardo segreto l’ha diluito facendolo divenire una generalità, la sua realtà indicibile l’ha fatta evaporare in gesti. L’unico romanzo possibile per lui sarà un libro tra i libri, che condividerà la stessa sorte degli altri libri, aspettando che su di esso cada lo sguardo del raro acquirente. La sua vita diventerà quella di uno scrittore, che scrive, scrive i suoi libri, fino a che non deruba completamente se stesso e non si purifica diventando un nudo scheletro, liberandosi dai fronzoli superflui: dalla vita. Sisifo – dice il racconto — dobbiamo immaginarcelo felice. Certo. Ma anche lui è minacciato dalla misericordia. Sisifo – e l’Arbeitsdienst [Lavoro coatto] – sono eterni, è vero; ma la roccia non è immortale. Attraverso un cammino aspro, in tanti ruzzolamenti, prima o poi si consuma, e Sisifo un bel giorno si scopre a fischiettare distratto e a scalciare davanti a sé, nella polvere, niente più che una pietruzza grigia.
E cosa ne può fare? Chiaramente si piega, se la mette in tasca, se la porta a casa – dato che è sua. Nelle sue ore vuote – e adesso lo aspettano soltanto ore vuote – la tira fuori ogni tanto.
Mettersi a far finta di farla ruzzolare su, verso l’alto delle vette, sarebbe ridicolo: ma con i suoi occhi vecchi velati dalla cataratta, può osservarla, come se anche adesso ne considerasse il peso, e la presa. Ci avviluppa sopra le dita tremanti e insensibili, e sicuramente la impugna ancora nel momento dell’ultimo, estremo slancio – quando senza vita cade dalla sedia posta di fronte al secrétaire.”
Kaddish per il bambino non nato (1999)[7]
Se Essere senza destino era strutturato come un racconto lineare, con un unico narratore interno e una unitarietà temporale (un anno) che si apre e chiude a Budapest – la complessità e lo spiazzamento nasceva semmai dal confronto/conflitto con il lettore – e con Fiasco Kertész approda, secondo la felice concettualizzazione di Umberto Eco, ad una Opera aperta, con questo testo che chiude la “trilogia” abbiamo una “orazione”. Testo da leggere possibilmente ad alta voce con rimandi e ricorrenze in un flusso ininterrotto dove il prima e il dopo si intersecano di continuo. Testo non a caso idoneo ad una sua recitazione teatrale[8]. Nel primo testo avevamo il bambino narrante, nel secondo lo scrittore, qui il sopravvissuto con una ormai quasi completa sovrapposizione fra narratore ed autore. Sopravvissuto che non riesce, anzi non vuole liberarsi dal proprio passato. Da Auschwitz non si guarisce!
“No!” – dissi subito e immediatamente …
Questo l’incipit mentre due anziani passeggiano in un faggeto vicino alla loro casa di cura. La “domanda innocente” che ha scatenato e scombussolato l’io narrante era semplicemente “se avessi un figlio”. Ma quel “No!” che viene ribadito è soprattutto il No! che fece a sua moglie (ora ex). Per cui l’oratoria funebre è nel contempo per il figlio non nato e per un matrimonio che si è dimostrato impossibile fra un sopravvissuto e una giovane e bella ebrea (e medico) che aveva voglia di vivere e desiderio di guarire il suo amato.
Scrittore e traduttore “la penna è la mia zappa”,
“… scrivo perché devo scrivere, e se scriviamo, dialoghiamo, l’ho letto da qualche parte, fin quando esisteva un dio, probabilmente dialogavamo con Dio, ora che non c’è più, uno presumibilmente dialoga solo con gli altri o, nella migliore delle ipotesi, con se stesso, vale a dire che parla da solo o borbotta, come dir si voglia …”
E, rivolto al figlio non nato (e non voluto)
“… la mia vita considerata come possibilità della tua esistenza alla luce della serie di riconoscimenti e all’ombra del tempo che scade si modificò così una volta per tutte: la tua non esistenza considerata come liquidazione necessaria e radicale della mia esistenza … Perché solo così ha un senso tutto quello che è successo, che ho fatto e che mi hanno fatto …”
E ritorna più volte al suo incontro con la giovane e bella ebrea
“… visto che voleva parlarmi perché aveva saputo chi ero: B. scrittore e traduttore di cui aveva letto uno “scritto”, del quale doveva assolutamente parlare con me, disse, e abbiamo anche parlato, fino a quando non siamo finiti a letto – Dio mio! – e abbiamo parlato anche dopo, anche durante, ininterrottamente …”
“Poi venne fuori il titolo di un libro allora di moda, una frase del libro di moda allora, anzi ancora oggi, anzi di sicuro per sempre, che l’autore pronuncia dopo essersi schiarito la voce in maniera dovuta ma ovviamente rivelatasi poi inutile, con la voce rotta dall’emozione: “Per Auschwitz non c’è spiegazione” […], come se questa proposizione enunciativa, che reprime allo stato embrionale tutte le enunciazioni, enunciasse qualcosa, laddove non bisogna essere Wittgenstein per accorgersi che, già solo prendendo in considerazione la logica linguistica, è sbagliata, vale a dire che vi si riflettono al massimo i desideri, l’infantile moralità menzognera o sincera e vari complessi soffocati: a parte questo non ha alcun valore enunciativo. Credo, l’ho anche detto, poi ho solo parlato, parlato in maniera inarrestabile, ormai logorroica, a tratti soffermandomi su uno sguardo femminile puntato su di me, che pareva volesse far scaturire in me una sorgente, mi venne in mente, nel bel mezzo della mia coazione a parlare, di sfuggita e probabilmente in maniera erronea, riflettendo al massimo desideri e vari complessi soffocati, dico, mi venne in mente che era lei, la mia futura moglie, ma prima la mia amante, che conobbi solo dopo tale conversazione, quando, stanco, turbato e dimentico di tutto e pronto ad andarmene (“all’inglese”, come si suol dire), ella attraversò un tappeto verde-blu, come se camminasse sul mare.”
…
… in una di queste notti incandescenti al buio, mia moglie disse che potevamo rispondere a tutte queste domande e risposte, a tutte queste domande e risposte che riguardano le nostre vite, solo con la nostra vita, più precisamente con la vita intera, perché tutte le domande poste e tutte le risposte fornite da ora in poi sarebbero state domande insufficienti e risposte insufficienti, e lei poteva immaginare la completezza nello stesso modo, perché, perlomeno per quanto la riguardava, nessun’altra completezza poteva sostituire la completezza unica, integrale, reale, quindi voleva un figlio da me, mi disse. Sì, e
“No!” – dissi subito e immediatamente, senza esitazione e, per così dire, istintivamente, perché ormai è del tutto naturale che i nostri istinti agiscano contro i nostri istinti, che, per così dire, i nostri controistinti agiscano al posto, anzi a mo’ dei nostri istinti; e come se questo
“No! ” non fosse stato un “No! ” abbastanza secco – o poiché forte della mia incongruenza – mia moglie si mise a ridere. Lei comprendeva, mi disse più tardi, da quale profondità fosse sgorgato quel mio
“No!”, e cosa dovessi vincere dentro di me perché divenisse un sì. Io le risposi che credevo anch’io di aver compreso quello che pensava, ma il
“No!”
era “No!”, […]
le dissi, tanto basti immaginare una conversazione disperata e infame, le dissi, immaginiamo, le dissi, il bambino, il nostro bambino, le tue grida, diciamo, le dissi, il bambino ha sentito qualcosa e strilla, diciamo, “Non voglio essere ebreo! “, visto che è fin troppo immaginabile e motivato che il bambino non voglia essere ebreo, e che la risposta metterebbe a disagio me, diciamo, sì, perché come si può costringere una creatura a essere ebrea, a questo riguardo, le dissi, camminerei sempre a testa bassa davanti a lei – a te – perché non potrei darle – darti – niente, né una spiegazione né una fede né un’arma da fuoco, …
…
“No! ” – non potrei mai essere padre, destino e dio di un altro uomo,
“No! ” – non potrà mai accadere a un altro bambino quello che è accaduto a me nell’infanzia,
“No! ” – urlò, ululò dentro di me qualcosa, è impossibile che questo, l’infanzia, accada a lui – a te – e a me.
E allora nella coppia qualcosa si rompe in modo irrimediabile
E anche ora, disse mia moglie, anche ora dentro di lei tutto diceva che voleva vivere. Le dispiaceva per me, ma le dispiaceva soprattutto perché era così impotente; ma aveva fatto tutto quello che poteva per salvarmi (e io tacqui, sebbene mi avesse sconcertato il modo in cui parlava). Già solo per gratitudine, continuò mia moglie, ero stato io a mostrarle quella strada che proprio io non riuscivo a percorrere con lei, perché le ferite che mi portavo dentro erano più tenaci del mio giudizio, forse avrei potuto anche scacciarle, sembrava, ma almeno a lei pareva, disse mia moglie, che non avessi voluto e non volessi scacciarle, e questo ci era costato il nostro amore, il nostro matrimonio. Disse di nuovo che le dispiaceva che mi avessero rovinato, disse, e che mi fossi rovinato, cosa che all’inizio non aveva visto, anzi, disse mia moglie, all’inizio si era meravigliata del fatto che, malgrado mi avessero rovinato, è vero, io non mi fossi rovinato, all’epoca mi vedeva così, ma si sbagliava, disse mia moglie, non sarebbe stato un problema, e non avrebbe generato in lei un sentimento di delusione, sebbene fosse fuor di dubbio che ne aveva sofferto, disse mia moglie. Ripeté che voleva salvarmi, ma che la sterilità, una qualche forma di sterilità di intenti, di affetto e di amore aveva pian piano estinto l’affetto e l’amore verso di me, lasciando dentro di lei solo un senso di sterilità e di inutilità e di infelicità.
…
“Poi ci separammo. E se, malgrado tutto, non ricordi gli anni successivi a quello come anni di totale arsura desertica è soltanto dovuto al fatto che, anche in questi anni, come del resto sempre da allora, prima e naturalmente anche durante il periodo del matrimonio, lavoravo, sì, mi ha salvato il lavoro, anche se in realtà mi ha salvato solo per conto della distruzione. In questi anni non solo sono giunto ad alcuni riconoscimenti decisivi, ma in questi anni ho riconosciuto che i miei riconoscimenti si intrecciano uno dopo l’altro, nodo a nodo con la mia sorte. In questi anni ho riconosciuto anche la vera natura del mio lavoro che, tutto sommato, non è altro che scavo, lo scavo ulteriore, definitivo, di quella fossa che altri hanno cominciato a scavare per me nelle nuvole, nei venti, nel nulla.”
…
“In questi anni ho iniziato a scrivere fogliettini sul mio matrimonio. In questi anni si è fatta viva di nuovo mia moglie. Una volta, sperando in nuove ricette[9], l’aspettavo nel solito caffè, lei teneva per mano due bambini. Una fanciulla dagli occhi scuri con i pallidi puntini delle lentiggini sparse intorno al nasino e un ragazzo caparbio, dagli occhi allegri e duri come sassi grigio-azzurri. Salutate il signore, disse loro. Una volta per tutte mi ha fatto tornare completamente in me. Ogni tanto, come un furetto malconcio, superstite della grande disinfestazione, guizzo furtivamente per la città. Di tanto in tanto drizzo le orecchie a un suono, a un’immagine, come se il fiuto intermittente dei ricordi assediasse dall’aldilà i miei sentimenti incalliti e infingardi. In prossimità di qualche casa, all’angolo di qualche strada, mi fermo spaurito, con le narici dilatate, scruto tutt’intorno con lo sguardo allarmato, voglio fuggire, ma qualcosa mi tiene prigioniero. Sotto i piedi il canale ribolle, come se la piena inquinata dei miei ricordi volesse emergere dal suo letto nascosto per trascinarmi via. Così sia; mi ci sono preparato. Durante il mio ultimo, grande raccoglimento, ho presentato la mia vita ancora fragile, caparbia, l’ho presentata per partire con il fardello di questa vita nelle mani levate in alto, per immergermi nelle acque impetuose, nere, di un fiume oscuro, Dio mio!
lasciami immergere
per l’eternità,
Amen”
Bibliografia ragionata delle altre opere di Kertész disponibili in traduzione italiana
I Diari
1992 Diario dalla galera (1961-1991). Ed. it. Bompiani, Milano 2009
A partire dal 1961 per tutto il periodo del governo comunista ungherese. I temi sono quelli dell’arte e del come rappresentare Auschwitz, i temi della libertà e del conformismo sotto una nuova forma di totalitarismo.
“1* maggio 1965. Essere senza destino – come titolo possibile, ma senz’altro come sottotitolo. Cosa intendo per destino? In ogni caso la possibilità della tragedia. La determinazione esterna, le stigmate costringono la nostra vita in una situazione condizionata dal totalitarismo, in un’assurdità, fa fallire questa possibilità: se quindi noi viviamo come realtà la determinatezza che ci viene imposta, invece che la necessità derivante dalla nostra libertà relativa, questo io lo chiamo assenza di destino. […]
1966 Non gli ebrei, bensì l’uomo, che occasionalmente è ebreo: “l’ebreo” come situazione nel totalitarismo […]
Settembre 1982. È un paradosso che, nonostante tutto, l’uomo ricerchi la felicità: in questo si cela la sua infelicità. Questo è l’errore, giacché solo nella sofferenza c’è qualcosa di simile alla vita. E – anche se in un primo momento sembra una contraddizione – soltanto nella sofferenza vi è consolazione. […]
Febbraio 1990. Gli uomini vivono la liberazione dalla tirannia come un crollo. Cosa succederebbe se li gettassero nella libertà!”
2003 Lo spettatore. Annotazioni 1991 – 2001. Ed it. Bompiani, Milano 2018
Dopo il crollo del muro le delusioni per un paese, l’Ungheria, che non sa far buon uso della libertà ma si rifugia nel nazionalismo.
“Sono un europeo che custodisce l’unica forma di esistenza universale, l’unica coscienza universale, che vive l’unica forma di vita senza patria – e fuori di patria –, ovvero sono ebreo, eclettico, esistenzialista, credente irreligioso, errabondo esiliato.”
«…adesso ho almeno una prova del fatto che il contenuto più importante della mia vita è stato, in fondo, la libertà, che gli atti più importanti – le mie opere – sono stati atti di libertà.»
«È arrivato il rapporto del cosiddetto ufficio storico – tre mesi fa sono andato a chiedere, nell’ufficio che gestisce e archivia queste denunce, che mi consegnassero i documenti a me intestati, tutto quello che potrebbe essere stato scritto su di me tra il 1950 e il 1989. Ed ecco la risposta: “Lei non figura nei documenti d’archivio attualmente a nostra disposizione.” Dunque non hanno aperto alcun fascicolo su di me, nessuno mi ha denunciato. Ho preso un abbaglio! Ho vissuto la mia vita così, totalmente ignorato.»
…Il nazionalismo non è però che la forma effimera dell’odio e della distruzione universali. In verità si dovrebbero svelare i motivi profondi dell’odio e della distruzione universali, si dovrebbe indagare perché il mondo si odii così tanto, e per quale motivo si diriga con tanta foga verso la distruzione. In relazione alle culture sinora esistite possiamo notare due svolte: l’uomo ha perduto la fede, non solo nella vita ultraterrena, ma anche in quella terrena; la sua vita non ha un fine morale individuale (amore e redenzione) né ha più un orizzonte comunitario, creativo (forme di esistenza più alte, eccelse, più spirituali e creatrici) al quale desideri tendere. La seconda svolta – che del resto discende dalla prima – è che il modo di rapportarsi dell’uomo verso l’altro uomo è diventato un rapporto ostile, quello dell’omicida nei confronti della vittima, dell’omicida nei confronti dell’omicida, della vittima nei confronti dell’omicida.»
2010 L’ultimo rifugio. Romanzo di un diario (2001 – 2009), ed. it. Bompiani, Milano 2019
Il periodo della vita in Germania, in “esilio volontario” da una Ungheria con cui fatica a riconoscersi; in questi anni l’arrivo dei riconoscimenti per la sua opera sino al Premio Nobel per la letteratura. Già precedentemente aveva scritto: «Propriamente non ho ricevuto in nessun luogo tanto affetto, quanto me ne ha dato quella Germania, dove vollero uccidermi.» Ma il nostro passato ci accompagna e oramai la vecchiaia avanza con tutti i suoi segni del declino. Aperti comunque all’inaspettato.
“Ci portiamo la nostra vita ovunque. Governare la barca verso la fine. Misurare l’importanza di ogni cosa rispetto alla morte.”
«Ogni relazione umana è un’illusione. La famiglia: questioni di eredità, patrimonio. L’amicizia: parole calde, impotenza, inerzia. Talvolta una gioia per la disgrazia altrui. L’amore: vola via senza lasciare tracce da un momento all’altro. E qualcosa comunque esiste, nonostante tutto talvolta fiorisce un’azione. Ma sempre in modo inatteso e, nella maggior parte dei casi, non là dove la si aspetta, non da parte di colui nel quale abbiamo riposto tutta la nostra fiducia».
Altre opere
1993 Verbale di polizia. Ed. it. Casagrande, Bellinzona CH 2007
Scritto a quattro mani con lo scrittore (e matematico) ungherese Péter Esterházy. Un semplice controllo sul treno fra Budapest e Vienna quando oramai la cortina di ferro si è dissolta fa capire all’autore (e personaggio) che il passato fa enorme fatica a passare.
1997 Storia poliziesca. Ed. it. Feltrinelli, Milano 2007
«Alla fine decisi che non avrei omesso le azioni “rivoltanti”, avrei, invece, spostato l’ambientazione in un immaginario paese sud-americano. Questo lavoro rappresentò per me una sfida insolita […] non avevo mai scritto un romanzo che non fosse nato da una diretta e incalzante necessità esistenziale».
Il Protagonista/narratore è agente dei servizi segreti, condannato a morte per i suoi trascorsi di torturatore sotto la dittatura che lascia un memoriale sui suoi trascorsi e sul percorso di iniziazione sotto la guida dei suoi superiori. L’orrore ha una sua logica e non è prerogativa solo di Auschwitz.
1997 Io, un altro. Cronaca di una metamorfosi. Ed. it. Bompiani, Milano 2012
Il mondo cambia (dopo la fine dell’Unione Sovietica) e questo, volente o nolente, fa cambiare l’autore che su questo suo cambiamento racconta e riflette. Mal digerisce il riemergere del nazionalismo e non accetta di esser strumentalizzato e ridotto quale testimonial dell’orrore dell’antisemitismo. Esce sempre più spesso dal proprio paese e la sua identità da un lato si arricchisce e all’altro sembra divenire meno comprensibile.
“Un giorno, capiremo quello che stiamo pensando?” (Jung).
Un giorno capirò la mia vita? Riuscirò a capirla? Tutto indica il contrario: l’io estraneo radicato in me, il moralista che approva se stesso, il menzognero inventore di favole. Hannah Arendt afferma che ogni scritto origina da un solo impulso: comprendere qualche cosa. Ma lascia che la nebulosità offuschi la parola “comprendere”. […]
Forse noi realizziamo uno scopo e, anche se nel pieno delle nostre attività quotidiane, non teniamo in grande considerazione questa impresa; senza neppure accorgercene portiamo a compimento il fine della nostra vita – di quella vita che noi invece reputiamo senza scopo,”
1998 Il vessillo britannico (tre racconti). Ed. it. Bompiani, Milano 2004
Il primo racconto del 1991 che dà il titolo al volume, ripercorre gli anni del dopoguerra, il suo poco tollerato lavoro di giornalista, la convivenza con la futura moglie “conosciuta quando era appena uscita da un campo di lavoro dove l’avevano trattenuta per un anno dove l’avevano trattenuta con la solita motivazione: vale a dire senza alcuna motivazione”, la ricerca di un alloggio sino agli eventi della rivoluzione ungherese del 1956. Durante quegli assembramenti di popolo nelle strade della capitale, l’episodio che Imre ricorda ai suoi più giovani amici:
“In modo inaspettato, una macchina tipo jeep fece la sua comparsa; aveva il cofano completamente coperto dai colori inglesi – azzurro, bianco, rosso -, insomma… da un grande vessillo britannico. Sgusciava a velocità folle tra le nereggianti ali della moltitudine raccolta sui due marciapiedi quando, prima sporadico, poi sempre più fitto, risuonò l’applauso della gente – un segno di aperta simpatia. Ormai soltanto da dietro vidi la macchina che era sfrecciata sotto il mio naso: ed ecco che, nell’istante in cui l’applauso parve consolidarsi, diventare quasi voluminoso, dal finestrino di sinistra si sporse titubante – all’inizio quasi riluttante – una mano. […] Era un cenno forse d’amicizia, forse di saluto, forse un piccolo gesto di compassione: in ogni caso, conteneva una decisa approvazione,”
Il secondo racconto, “Il cercatore di tracce” è una sorta di giallo in parte onirico in parte metafisico dove il protagonista “l’ospite” ovvero “l’inviato” che alla fine sappiamo esser “straniero” è indagatore e forse indagato. Cerca una fabbrica (quella del lager di Zeit?) e incrocia delle donne misteriose, la moglie, una velata di nero che lo perseguita e una che appare in mezzo alla folla.
“Era bella, sì, eppure c’era qualcosa di lacerato in quella donna. Nel suo splendore compariva qualche segno di disperazione per lo sforzo sostenuto; nella sua sicurezza di sé, qualcosa della sonnambula; nella sua bellezza, qualcosa di trasandato, qualche tratto che era sul punto di diventare repellente, che minacciava in ogni istante di scatenarsi e di impadronirsi di quel volto con improvvise contrazioni.
Chi era dunque quella donna? Una strega? Uno spirito distruttore? Dove aveva già visto quel volto?”
Il terzo racconto, “Verbale” del 1991 anticipa il racconto “Verbale di polizia” del 1993. È in realtà un “contro-verbale” in cui Kertész ricostruisce la vicenda del suo fermo alla frontiera quando stava per recarsi a Vienna. Una situazione che gli richiama Kafka: “La condanna non viene tutta insieme, il processo stesso diventa pian piano la condanna.”
2003 Liquidazione. Ed. it. Feltrinelli, Milano 2005
Storia del suicidio di uno scrittore, indicato semplicemente da una B puntata, nato in campo di concentramento, e della indagine di Keserü, suo amico ed editore che vuole capire i motivi del suicidio e reperire l’ultimo romanzo a cui B. stava lavorando.
“Prima di lasciare l’appartamento lessi ancora una volta il messaggio di addio di B.: «SCUSATEMI! BUONA NOTTE!». Era il messaggio di addio più breve della letteratura universale e – pensai – nel suo genere era un capolavoro.”
B. aveva lasciato anche una lettera alla (ex) moglie e la richiesta di bruciare tutto: la lettera e l’ultimo manoscritto.
È finito il nostro mondo, il nostro – ora lo vedo chiaramente – servile mondo-prigione, che abbiamo tanto odiato. Eppure è stato quest’odio a mantenerci in vita, adesso lo so. Il dispetto, l’ostinazione che ci fa sopravvivere. – E l’amore? – potresti chiedermi. Mi sembra di sentire la tua voce. – L’amore non conta?
Non lo so, Sara. Tu ci hai provato in ogni modo. Mi dispiace. Devo sparire, andare via per sempre di qui, insieme con tutto quello che – come posso dire? – porto dentro di me, come la peste. Porto dentro di me delle forze capaci di un’incredibile distruzione, con il mio ressentiment si potrebbe distruggere il mondo intero, e ne parlo in maniera elegante, per non dire cose da far vomitare.
2003 Il secolo infelice (raccolta di saggi). Ed. it. Bompiani, Milano 2012
Raccolta di scritti a carattere saggistico realizzati fra il 1990 e il 2002 sui temi ricorrenti nelle sue opere letterarie: l’Olocausto, la Libertà, il totalitarismo, il ruolo dell’arte, l’Europa, l’essere ebreo e l’antisemitismo …
“Non considero “saggi” nel senso tradizionale del termine gli scritti che seguono; parlerei piuttosto di “approssimazioni”, anche se naturalmente questo genere letterario non esiste. Da una parte vorrei sottolineare il fatto che nessuno di questi lavori esaurisce il proprio soggetto, ma riesce al massimo ad approssimarsi a esso; dall’altra vorrei evidenziare che essi affrontano, sebbene da un altro punto di vista, lo stesso argomento delle mie opere narrative: l’inavvicinabile.”
Chiude il volume “Eureka!”, il discorso pronunciato in occasione del conferimento del Premio Nobel 2002 per la letteratura[10].
“Si dice di me, a volte per elogiarmi, a volte per criticarmi, che io sia lo scrittore di un unico argomento, l’Olocausto. Non ho niente in contrario e – salvo alcune riserve – perché non dovrei accettare il posto a me assegnato sulle mensole delle biblioteche? In fondo, quale autore non è lo scrittore dell’Olocausto? Intendo dire che non c’è bisogno di scegliere l’Olocausto come tema principale per notare quella voce rotta che da decenni regna sull’arte moderna d’Europa. Dirò di più: non conosco un’arte autentica e di valore nella quale non si percepisca questa rottura, come se dopo una notte di incubi, l’uomo non si guardasse distrutto e perso intorno al mondo. Io non ho mai considerato il complesso di problemi chiamato Olocausto come un conflitto inabrogabile tra tedeschi ed ebrei; non ho mai creduto che questo fosse il più giovane capitolo nella storia delle sofferenze degli ebrei. Non l’ho mai visto come un singolare deragliamento della storia, come un pogrom più imponente di quelli precedenti, come una premessa della creazione dello stato ebraico. Nell’Olocausto io ho riconosciuto la condizione umana, il capolinea della grande avventura dove è giunto l’uomo europeo dopo duemila anni di etica e di cultura morale.
Adesso dobbiamo riflettere soltanto su come proseguire da qui.”
[1] “Il fiore di una bambina” del 2008, ripubblicato in Un popolo come gli altri, Donzelli, Roma 2019, p. 135.
[2] Questa citazione e le seguenti sono riprese da un articolo pubblicato originariamente sul quotidiano ungherese Magyar Nemzet il 10 novembre 2001 a cura di Zoltán Hafner, direttore dell’Istituto Imre Kertész di Budapest. La traduzione è di Andrea Rény ed è visionabile online > qui <.
[3] Io, un altro. Cronaca di una metamorfosi, Bompiani, Milano 2012, p. 67-68.
[4] Da AmargiPress del 12.11-2020: “Zona Disagio. L’Ungheria riscrive (ancora) un pezzo di storia”.
[5] Dalla intervista, come le successive al regista e a Ennio Morricone, rilasciata dopo la presentazione del film a Cannes e riportata negli extra del DVD:
[6] Ed. italiana: Fiasco, Feltrinelli, Milano 2001. Sul rapporto con l’opera precedente è consultabile online l’intervista all’autore sul Corriere della Sera curata da Giorgio Pressburger in occasione dell’edizione italiana: > qui <.
[7] Ed. italiana, Feltrinelli, Milano 2006
[8] Cfr. la messa in scena a cura di e con Ruggero Cara.
[9] Le ricette di antidepressivi che la moglie, medico, continuava prescrivergli anche dopo la separazione.
[10] Il discorso era stato pronunciato in Ungherese. Online sono disponibili le versioni in Inglese e Francese: > qui < e > qui <.



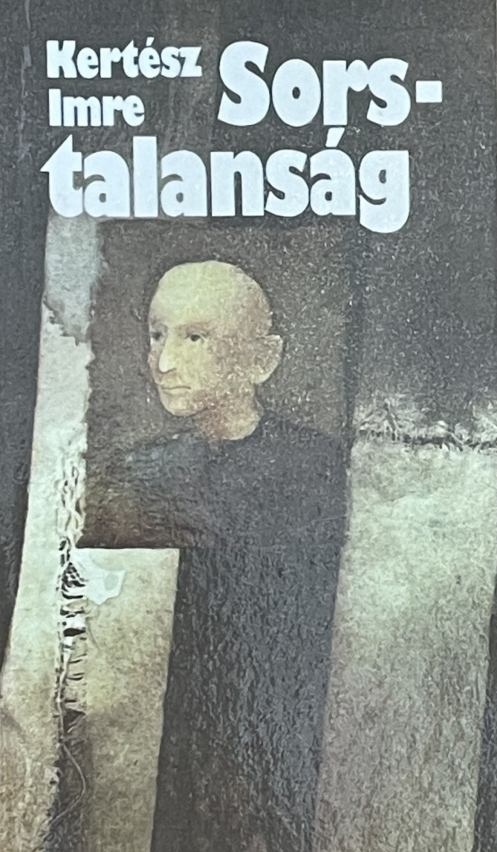












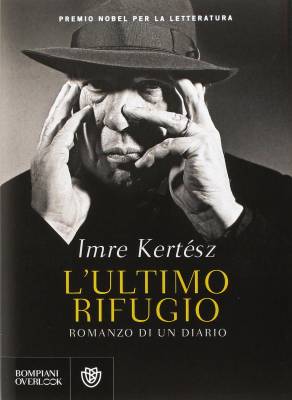

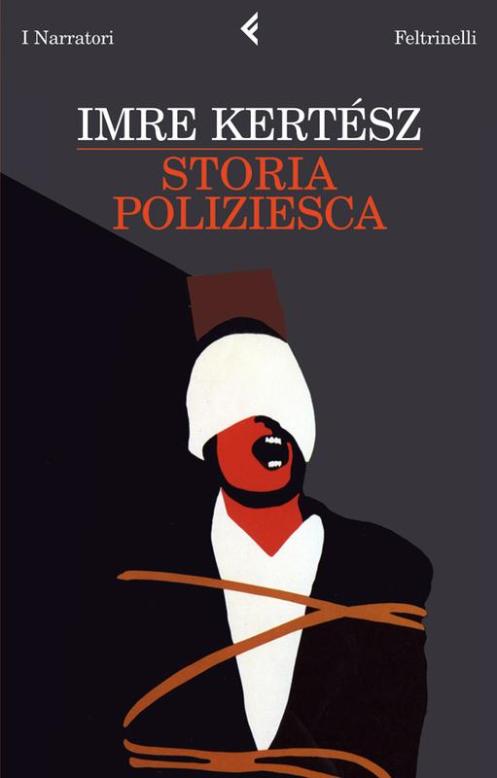

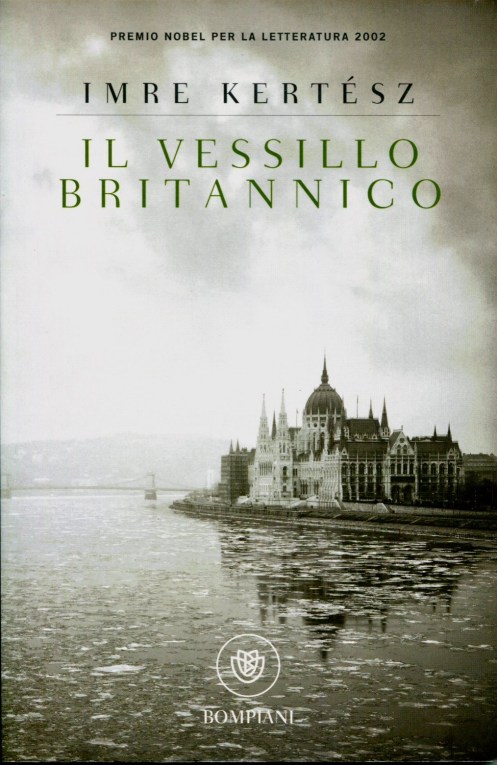



Trackbacks & Pingbacks