Lo sguardo anteriore di Gino Vermicelli
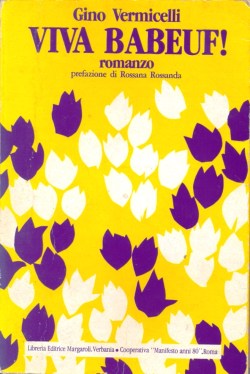
Sono stato invitato, nell’ambito delle iniziative per la Festa della Liberazione, a presentare a Pettenasco il romanzo “Viva Babeuf!” e il suo autore.
Sono andato così a rileggermi due articoli sul partigiano e Commissario politico della Divisione Redi “Edoardo” che anni fa avevo pubblicato sulla rivista Il Cobianchi.
Mi sono parsi ancora attuali e atti alla loro ripubblicazione in questo blog.
Di seguito il primo del 1998, scritto quando Vermicelli era da poco mancato.
Gino Vermicelli: Uno Sguardo Anteriore
” Parlare di Comunità… oggi ha un significato completamente diverso rispetto a qualche decennio fa: le Comunità locali sono sottoposte anch’esse ai processi di globalizzazione, frantumazione e specializzazione. La Comunità un tempo era un «luogo educante» e ruotava intorno a figure forti che ne costituivano il naturale punto di riferimento. La figura del «Maestro di vita» oggi è scomparsa o si è anch’essa specializzata e decontestualizzata”.
Più o meno queste parole ha pronunciato ad un certo punto, in Aula Magna nuova, uno dei relatori alla Tavola rotonda su “Scuola e Territorio”. Era il 13 maggio e il mio pensiero è andato subito a Vermicelli, in ospedale da alcune settimane, le cui condizioni si erano aggravate negli ultimi giorni. Si sarebbe spento la settimana successiva, la mattina del 21 maggio.
Se c’è infatti un tratto comune che riunisce la molteplicità dei ruoli percorsi da Gino (giovane emigrante in Francia, partigiano e commissario politico, dirigente prima politico poi della cooperazione, sostenitore delle lotte studentesche ed operaie degli anni ’60 e ’70, scrittore, apicoltore, pacifista …) è proprio questo: è stato per tutti coloro che hanno avuto la fortuna di conoscerlo un maestro, un maestro di vita.
Negli incontri che ebbe più volte con gli studenti della nostra scuola – in particolare dopo la pubblicazione del suo romanzo partigiano – sapeva immediatamente catturare l’attenzione e il rispetto. Le sue risposte erano chiare, semplici, mai banali. Anche alle domande più curiose sapeva rispondere inserendo i più piccoli episodi, apparentemente insignificanti, nella prospettiva più ampia dei grandi eventi e delle grandi scelte. Questa capacità di catturare l’attenzione, di dare risposte profonde, di rendere immediatamente chiaro a chi ascolta ciò che un attimo prima sembrava incerto, complicato, magari incomprensibile, insomma questa pacata saggezza mi sono chiesto da dove venisse. Non dai libri, non principalmente almeno. Forse dalla vita. Mi sono convinto che il suo sguardo ironico, vivace e sereno avesse la capacità di guardare le cose, quelle dei grandi eventi come il più piccolo episodio quotidiano, in modo diverso dal nostro. Era uno sguardo che guardava da lontano, che sapeva leggere gli eventi senza lasciarsi scalfire dalle perturbazioni del momento e dal superfluo. In questo sguardo “anteriore” la sua lungimiranza e la sua capacità di richiamarci ai valori antichi dell’uguaglianza, del rispetto, della semplicità.
Non è un caso che il suo romanzo partigiano sia titolato ad un “resistente” di duecento anni prima: Babeuf. Nell’ultimo anno Vermicelli ha lavorato, insieme ad altri due comandanti della sua divisione garibaldina (Aldo Aniasi ed Ettore Carinelli), alla pubblicazione di una ricostruzione a più voci della guerra di liberazione nella nostra provincia (Ne valeva la pena. Dalla “Repubblica” dell’Ossola alla Costituzione repubblicana). Il libro è da pochi giorni in libreria: ne riportiamo due sue testimonianze.
“La liberazione di Moscatelli
Non ricordo la data esatta, ma era ottobre, ottobre inoltrato del 1943. I tedeschi occupavano l’Italia e da oltre un mese Mussolini era stato liberato e da Salò aveva proclamato la repubblica sociale italiana. Tutto questo succedeva in Italia, ma non a Borgosesia, dove Moscatelli aveva un ufficio in piazza, accoglieva e sistemava soldati sbandati (e le loro armi), manteneva vivo, insieme ad altri antifascisti il Fronte Nazionale ed insieme il partito comunista, del quale riceveva gli emissari, clandestini, s’intende (ma non a Borgosesia dove sembrava tutto tranquillamente diverso). Sino a quel giorno, appunto, di ottobre inoltrato. Quel giorno i carabinieri mandarono a chiamare Vincenzo Moscatelli e lui, tranquillamente si recò in caserma. Non aveva niente da nascondere, Cino, aveva fatto tutto alla luce del sole.
I carabinieri, dispiaciuti e amareggiati, gli comunicarono che da Vercelli, dal prefetto, avevano ricevuto l’ordine di fermarlo e di trasferirlo nel capoluogo. Lo dissero anche ai suoi famigliari che lo fecero sapere a tutti.
Quel giorno giunsi a Borgosesia con un lentissimo treno che mi scaricò verso le undici. Naturalmente seppi subito dell’arresto di Cino. Lo sapevano tutti. Bisognava liberarlo. Io non avevo mai liberato nessuno da nessun carcere o caserma che fosse.
Avevo letto però che bisognava unire l’azione militare all’azione di massa. Lo dissi, nell’ufficio di Moscatelli affollato da amici e compagni.
Chi mi ascoltava non capiva molto che cosa volevo dire e forse nemmeno io avevo chiaro il concetto. Comunque, decidemmo di chiamare le donne a manifestare davanti alla caserma, così, nel pomeriggio, davanti alla stazione dei carabinieri di Borgosesia cento o duecento donne urlavano: “Moscatelli! Moscatelli! Vogliamo vedere Moscatelli!”
La caserma di Borgosesia aveva una porta che si apriva direttamente sulla strada. Era di legno massiccio con enormi rinforzi in ferro e dietro a quella porta vi erano una mezza dozzina di carabinieri armati. Per una buona mezz’ora, forse anche un’ora, i carabinieri fecero finta di ignorare quello che succedeva fuori, ma poi, finalmente, si fecero sentire:
“Cosa volete, donne? Andate via!”
“Vogliamo vedere Moscatelli! Vogliamo vedere se è ancora qui!”
Dopo esitazioni, nuovi trambusti, tamburellate sul portone, infine i carabinieri si decisero.
“Va bene, ma solo tre. Tre donne a salutare Moscatelli e via, a casa tutte “.
“D’accordo!”
La porta blindata si aprì e subito una bomba a mano scoppiò nell’atrio, poi tre alpini piuttosto cattivi si precipitarono nel vano e altre bombe esplosero.
Pochi secondi dopo gli alpini cattivi uscivano con Moscatelli. Uscirono di corsa.
Non vi fu tempo per i saluti; s’infiltrarono in una stradetta, verso la montagna, di corsa.
Io guardai l’ora al campanile. Il treno per Novara partiva dopo poco. Mi avviai verso la stazione, ma prima mi tolsi il soprabito.
Avevo un soprabito di gomma “similpelle” comperato in Francia. Sembrava vero daino, ma era gomma.
Non ne esisteva di simili, in Italia. Nel timore di essere identificato lo tolsi e lo portai sul braccio sino alla stazione, poi sul treno lo nascosi sul sedile, dietro la schiena.

Ne valeva la pena
Se ne è valsa la pena? Veramente la pena non ci fu, se per pena s’intende tormento dell’anima, sofferenza morale.
Eravamo sì afflitti da tormenti vari: fame (frequente), freddo in inverno, fatica sempre e poi insetti molesti e parassiti vari (senza contare i “neri” che tentavano di farci la pelle), ma il tutto era vissuto in un’atmosfera di vivace allegrezza. Il fatto è che avevamo vent’anni ed eravamo convinti che stavamo cambiando il mondo.
Abbiamo cambiato il mondo? Certamente. Non è poi tanto difficile immaginare in che mondo avrebbero dovuto vivere gli Italiani se i nazisti avessero vinto la guerra. Non l’hanno vinta perché milioni di donne e di uomini si sono opposti ad essi. Sovietici (20 milioni di caduti), Americani, Inglesi, Francesi, Polacchi, Jugoslavi e tanti altri popoli fra i quali noi, Italiani della Resistenza.
L’avventura della guerra fascista si era conclusa nella vergogna della sconfitta.
Il governo di Mussolini aveva dichiarato guerra a tutti i Paesi vicini e a molti altri lontani e si ritrovava con gli Alleati che, sbarcati in Sicilia, risalivano la Penisola. Era necessario farla finita con la guerra e con il fascismo. Gli stessi uomini della classe dirigente, il 25 luglio del 1943, dichiararono la fine del fascismo e allontanarono Mussolini dal potere e poi l’8 settembre 1943 firmarono l’armistizio con gli Alleati.
Tutto poteva concludersi così, sennonché i nazisti tedeschi inviarono le loro divisioni ad occupare le zone del nostro Paese non ancora raggiunte dagli Alleati. Misero insieme un governo “quisling”, alla testa del quale collocarono Mussolini, dopo aver provveduto a liberarlo dalla prigionia. Le vicende che abbiamo voluto rievocare in questo libro sono quelle dei mesi che seguirono l’occupazione tedesca e la costituzione del regime di Salò, in una zona dove la resistenza assunse un carattere emblematico per la presenza e, superando difficoltà, la collaborazione tra formazioni partigiane diverse che insieme inflissero pesanti colpi ai nazisti e ai fascisti, compreso la liberazione di una zona che contava già allora quasi centomila abitanti. Sono episodi della storia di gruppi di partigiani che sviluppandosi e ampliandosi formarono divisioni che parteciparono alla liberazione del territorio sino a Milano nell’aprile del 1945.
Certo che ne valse la pena. Non potevamo non farlo.
I fascisti comandavano abusivamente (senza l’avallo di elezioni libere) da oltre vent’anni.
I Tedeschi ci schiacciavano con la loro occupazione. Bisognava aiutare l’Italia a liberarsi.
È stato duro, difficile, ma bello. Un filosofo orientale ha scritto che ribellarsi è giusto.
È giusto e anche bello. Noi lo abbiamo fatto e non ne siamo pentiti. Ad ogni generazione la responsabilità del proprio tempo, il compito di valutare la realtà e di affrontarla. Senza sbagliare.
Libri sulla Resistenza ne sono stati scritti molti, centinaia da autori noti e da testimoni modesti, eppure il filone non è ancora esaurito, vi è ancora molto da mettere in evidenza e da approfondire. Il fatto che la Resistenza è la sola autentica rivoluzione che ha attraversato l’Italia, coinvolgendo classi e ceti sociali, incidendo profondamente sul modo di essere e di pensare (sul tipo di civiltà) della gente di questo paese. Nessun altro evento della nostra storia ha coinvolto come la Guerra di Liberazione. Nelle stesse guerre di Indipendenza, anche in quella del 1915-18 (se vogliamo considerarla tale) lo Stato ingiungeva ai cittadini l’ubbidienza. Il Re o comunque il Potere chiedeva ai sudditi di obbedire, per il bene della patria, s’intende.
Con la guerra partigiana invece si chiese alla popolazione di disobbedire e di ribellarsi a chi deteneva il potere, tedeschi o fascisti che fossero, di colpire con le armi l’apparato militare dominante, creando forze armate da contrapporgli, oltre che costituire un embrione di contropotere civile.
Ciò avvenne anche nelle zone dove si svolgono i racconti e gli episodi raccolti in questo libro, cioè la vecchia provincia di Novara, incluse la Valsesia e il Verbano, Cusio e Ossola. In questo territorio operavano formazioni partigiane diverse, con ispirazione politica diversa. Ma nessuno pretendeva dai singoli comandanti partigiani l’adesione all’orientamento politico maggioritario.
I lettori scopriranno che vi erano comandanti monarchici nei gruppi partigiani considerati rossi e militanti comunisti in gruppi che si distinguevano con fazzoletto azzurro o verde.
E tutto ciò prevalentemente in serena collaborazione. La necessità del pluralismo come elemento portante della democrazia veniva così esaltato nella Guerra di liberazione.
Dopo il passaggio di una rivoluzione è risaputo che le vecchie classi dominanti tendano a trovare il varco per riprendersi il potere perduto. Ma questa è un’altra storia.”
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
L’originale dell’articolo su “Il Cobianchi 1998”, in formato PDF, è scaricabile < qui >

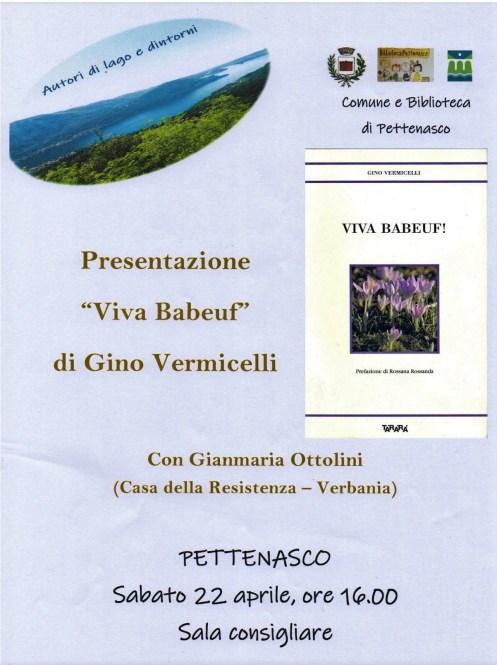
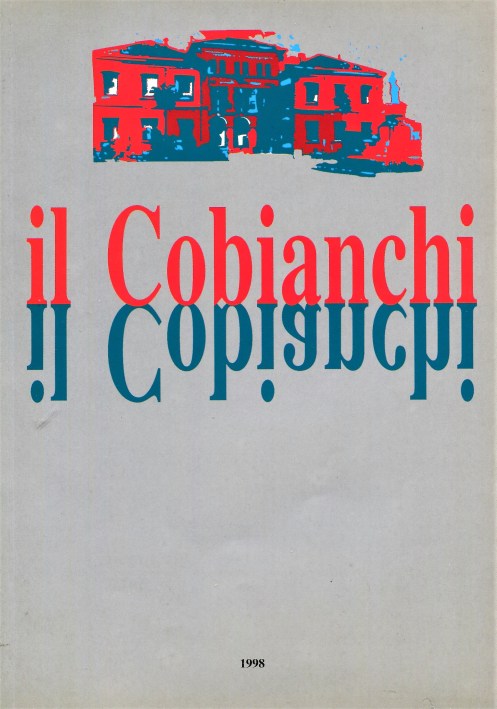



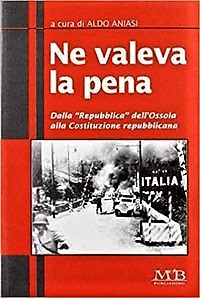


Trackbacks & Pingbacks