Intervento su “The Fox”
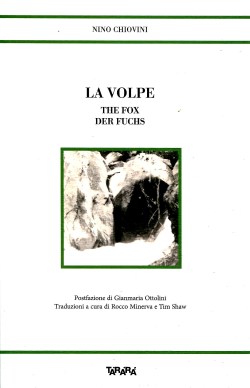
di Rocco Minerva
In corrispondenza del 77mo dell’eccidio di Trarego è stato pubblicato, per la prima volta in volume e in edizione trilingue, il racconto “La volpe” di Nino Chiovini, edito per i tipi di Tararà e patrocinato dal Parco Letterario titolato al noto partigiano e scrittore. Dopo una “anteprima” a Trarego al termine della commemorazione a Promé, il volume è stato ufficialmente presentato alla Casa della Resistenza il 26 febbraio 2022. Rocco Minerva, che ha curato la traduzione inglese e che per primo aveva suggerito una edizione plurilingue del racconto, ha preparato per l’occasione questo intervento.
Non ho mai conosciuto Nino Chiovini.
Le montagne della Valgrande, invece, avevo cominciato a frequentarle già trent’anni prima della sua morte, quando nel 1961 mio padre mi aveva portato sulla Marona. Allora ero un ragazzino di otto anni e ricordo ancora quella lunga scarpinata da Miazzina, su a Cappella Fina, passando accanto ai ruderi del vecchio albergo del Pian Cavallone, arrivando successivamente alla Forcola dove il sentiero poi s’inerpicava attraverso posti dai nomi mitici – La Scala Santa, il Passo del Diavolo – per arrampicarsi infine su, fino alla Cappella appena sotto la vetta.
Non vorrei che le mie parole suonassero irriverenti o, peggio ancora, sacrileghe, ma per me contava soltanto arrivare in cima. Di quello che mio padre mi andava dicendo – dell’albergo incendiato, dell’eccidio presso la vetta e di tutta Resistenza – io, sinceramente, non capivo molto. Le guerre cosiddette “civili” per quel bambino che ero si fermavano ai tempi quasi leggendari dell’antica Roma: Mario contro Silla, Cesare contro Pompeo, Augusto contro Antonio. E mi schieravo invariabilmente con il vincitore, come se fosse una gara sportiva in cui tifare per qualcuno.
Anche quando cominciai a girare da solo in Valgrande, ciò che mi attraeva erano sempre le sue vette: la Zeda, il Pizzo Ragno, Corte Lorenzo, il Proman, il Pedum. Poi, verso i vent’anni, arrivò il tempo delle traversate: da Premosello a Malesco, da Ponte Casletto lungo il fiume fino all’Arca e a In la Piana, le Strette del Casé, il Sentiero Bove. Il Parco non era ancora stato istituito e andare in Valgrande era come entrare in uno sconfinato parco-giochi, dove, appunto, era possibile giocare a fare l’esploratore nella natura selvaggia, ora cercando un sentiero appena accennato, ora fidandoti di qualche corda sfilacciata o di una fune arrugginita, guadando un torrente dalle acque impetuose, facendo il bagno in una pozza cristallina, accendendo il fuoco in una baita mezza diroccata e tirando fuori dallo zaino ogni ben di Dio.
Ma non capivo quasi niente di quei luoghi; non vedevo nei tetti sfondati e nelle travi tarlate o bruciate di quelle baite né i segni di una di una civiltà di fatica e sudore, né le ferite di una guerra feroce. La wilderness, che tanto mi appassionava, aveva come unico scopo la sua fruizione edonistica, io, però, non sapevo leggere quei posti, non ero capace di guardarli negli occhi.
Quando arrivai al Cobianchi nel 1985, incontrai colleghi – divenuti poi amici – con i quali si andava in montagna. Furono loro a farmi conoscere i libri di Nino Chiovini e furono quelle letture a spalancarmi il vissuto della Valgrande. Grazie a lui, le baite abbandonate divennero alpeggi pieni di vita, nei prativi attorno ad esse (ora invasi da betulle, rovi e ginestre) tornarono a pascolare mandrie e greggi, il mio parco-giochi di qualche anno prima si popolò di boscaioli operosi, bracconieri scaltri, spalloni e bricolle, ma, inevitabilmente, si trasformò anche nel terreno di guerra tra partigiani e nazifascisti.
Qualche anno fa, quando lessi per la prima volta La volpe, mi accorsi anch’io che quel racconto, rispetto ad altri scritti di Nino Chiovini, possedeva un’indubbia valenza letteraria. Si trattava, sì, di una testimonianza relativa a un episodio della Resistenza e che dunque aveva una precisa collocazione storico-geografica (peraltro volutamente non precisata dall’autore), ma presentava allo stesso tempo caratteristiche che esulano dall’ambito strettamente saggistico e che sono invece tipiche della letteratura.
La prima è costituita dal titolo, che svela il suo profondo valore simbolico soltanto nell’epilogo del racconto, uscendo all’improvviso – come la volpe – dalla selva di quei tragici eventi, attraversandoci la strada e facendoci comprendere, come in un’illuminazione, il senso del racconto.
Un altro aspetto è la scelta di un punto di vista soggettivo, che ha il pregio di affacciare emotivamente il lettore sul luogo degli eventi, senza però realizzarsi attraverso un narratore in prima persona, che sarebbe probabilmente troppo invadente e ingombrante, e, inevitabilmente, di parte. Nino Chiovini opta invece per un narratore esterno, più discreto e distaccato, che meglio può rendere quanto il protagonista subisca una serie di eventi a cui si sottrae grazie al suo profondo attaccamento alla vita.
Nella parte centrale del racconto gioca un ruolo fondamentale il monologo interiore che nel suo succedersi di esclamazioni, di frasi spezzate, interrotte e riprese, nei non sequitur che rasentano l’alalia rende mirabilmente lo stress e l’angoscia che il protagonista prova in quei momenti. E in quei momenti non c’è più nessun narratore; non ha più senso che ce ne sia uno. La sintassi non governa più le frasi e queste si riducono a parole, che non sono neppure più pronunciate, che restano pensieri, deboli, flebili.
Proprio mentre mi soffermavo su questi passi de La volpe sentivo il desiderio di dare più voce al racconto, al partigiano, al suo vissuto. E mi chiedevo se avesse senso che un pubblico più vasto di quello in grado di leggere in lingua italiana potesse accedere a questa storia. Così cominciai a tradurre il racconto in inglese, senza neppure sapere se mai si sarebbe potuti giungere a una pubblicazione. Ma a questo punto credo sia necessario chiarire qualche termine. Non mi interessava “tradurre” nel senso etimologico di “trans + ducere” cioè “condurre oltre”, come se il testo in lingua inglese fosse la meta verso cui puntare e il traduttore il protagonista di questo passaggio. Volevo piuttosto, come è più evidente nel verbo inglese, “translate”, termine che etimologicamente è legato al latino “trans + fero” (supino latum), cioè “portare oltre”, volevo portare più in là il racconto di Nino Chiovini, come per amplificarne la voce. E in quest’ottica mi misi al lavoro.
Se qualcuno fosse adesso interessato a conoscere quali siano state le maggiori difficoltà incontrate nella traduzione, chiariamo subito che non sono stati i passi di monologo interiore. Questi possono risultare meno chiari a una prima lettura, ma per la quasi totale assenza della sintassi e per la presenza di un vocabolario essenziale – direi quasi viscerale – non costituiscono in genere un problema.
Paradossalmente, per me, sono risultate più ostiche quelle parole apparentemente semplici come “baita”, “villetta” o “caffelatte”, che però hanno una connotazione fortemente legata a precisi contesti storico-culturali.
Il termine “baita” è usato sull’arco alpino centrale e occidentale in riferimento a piccole costruzioni solitamente con muri a secco in pietra e tetto in piode adibite ad abitazione, stalla, fienile e anche luogo di lavoro (per la produzione di latticini, per esempio). Non potremmo mai chiamare “chalet” o “cottage” una “baita”. Al di là delle differenze architettoniche, la funzione di quelle costruzioni è diversa. E all’interno dello stesso arco alpino, i vocaboli “baita” e “malga” non sono sinonimi, perché hanno connotazioni geografiche ben distinte, dove il secondo termine è tipico delle alpi orientali. In Scozia e in Irlanda si trovano ancora i ruderi di costruzioni rurali (“shieling”) che avevano funzioni analoghe a quella di una baita ed erano usate per la transumanza, ma oltre alla pietra impiegavano anche zolle erbose o torba. Esistono anche “bastle houses”, “blackhouses”, ma non avrebbe avuto senso ricorrere ad alcuno di essi, vista la loro precisa collocazione storico-geografica. Mi è sembrato più corretto scegliere “stone hut”, che da un lato richiama l’aspetto più evidente (la pietra) e dall’altro implica le caratteristiche dell’edificio, rurale e spartano.
Nel finale del racconto Nino Chiovini usa il termine “villetta”. Una villetta nel 1944 era ben diversa da una villetta del ventunesimo secolo. Se il lettore in italiano volesse visualizzare quella costruzione, dovrebbe fare un balzo indietro di un’ottantina d’anni. Ma che termine potrebbe essere meno fuorviante per chi legge in inglese? In città una villetta è una “small house”, mentre in campagna è un “cottage”, se è monofamiliare è una “detached house”, se invece è bifamiliare si parla di “semi-detached house”, colloquialmente “semi”. Se poi è una villetta a schiera il termine è “terraced house”. Si utilizza invece “small villa” nel caso che dei turisti anglosassoni prendano in affitto una casa per le vacanze estive soprattutto nell’area mediterranea. Ora, quanto tutti questi edifici assomiglino alla classica villetta progettata dal geometra che spesso ci immaginiamo dicendo “villetta” è tutt’altra questione. E poi non possiamo dimenticare che la villetta di cui si parla ne La volpe era stata costruita prima del 1944. Alla fine ho optato per “plastered house”, cioè “casa intonacata”, visto che a quei tempi la maggior parte delle abitazioni dei luoghi di cui si parla non lo erano.
Ma è possibile che anche il “caffelatte” abbia costituito un problema? Beh, sì, se ci chiediamo che caffelatte avrà mai bevuto il partigiano prima di partire. Un “white coffee”? Di certo non quello che, usando la parola italiana, in inglese si dice “latte”, riferendosi però a del latte macchiato con schiuma. Molto probabilmente si sarà trattato di latte caldo con un po’ di caffè e, vista la difficile reperibilità del caffè in quel contesto, sarà stato caffè di cicoria, anche se non era necessario specificarlo. D’altra parte non era una libertà che potevo assumermi e la scelta è ricaduta su “a cup of hot milk with coffee”, neutra, banale forse, ma non compromettente.
Queste considerazioni relative alla traduzione suoneranno forse come cavilli, pignoli e pedanti. Vorrei soltanto che fossero intese anche come un segno dello scrupolo con cui mi è sembrato doveroso procedere nel lavoro. In fondo, al di là del risultato, per me si è pur sempre trattato di una forma di rispetto per l’autore.
Qualche anno fa mi trovavo alla Cappella della Marona con un paio di amici. Raggiunta la meta, ci eravamo fermati per fare il classico spuntino, prima di iniziare la discesa. Dopo una decina di minuti ci raggiunse un’escursionista solitaria sulla cinquantina. Dal rapido scambio di saluti mi resi conto che era tedesca. Stavo ancora trafficando nello zaino per cercare un bicchiere e offrirle un sorso di vino, quando mi accorsi che era sparita dentro la cappella, dove un ossario – piuttosto malconcio, in verità – custodisce qualche reliquia dei partigiani uccisi dai nazifascisti. Ne uscì poco dopo con le lacrime agli occhi. In situazioni del genere ammetto di essere particolarmente impacciato – imbranato, se mi passate il regionalismo. La soluzione migliore, avendo finalmente trovato il bicchiere, mi sembrò proprio quella di versarvi un goccio di vino da bere insieme. Lei accettò di buon grado, chiedendoci di scusarla per il suo stato d’animo e ci disse che fin da quando era ragazzina aveva cominciato a frequentare il Lago Maggiore, dove i genitori venivano in vacanza. Continuò, raccontandoci che una quarantina d’anni prima era già stata alla Marona con suo padre, il quale le aveva parlato dell’eccidio del giugno del ’44. Ci disse anche che era un soldato, ma non aggiunse altro. Ripeteva come se fosse un rosario che non le sembrava possibile che degli esseri umani potessero arrivare a tanto e si scusava in continuazione fra lacrime e singhiozzi. Poi mi restituì il bicchiere, ringraziò, si scusò ancora una volta, ci salutò e s’avviò lentamente lungo il sentiero che scende a valle. La seguivo con gli occhi riandando mentalmente a quando a otto anni mio padre mi aveva portato sulla Marona e per me in montagna si doveva andare soltanto per salire su in cima e non capivo niente di Resistenza, di lotta partigiana, di guerre “civili”, fermo com’ero a quelle fra Mario e Silla, fra Cesare e Pompeo. Lei era diventata un punto sempre più in basso, che ogni tanto scompariva fra rocce e ontanelli e io intanto mi chiedevo se tutte le guerre, in fondo, non fossero sempre “civili” che si combattono fra esseri che spesso si scordano di essere umani.





